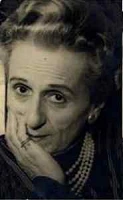Teatri: i De Filippo

Come apprendiamo dal programma distribuito all’ingresso, la compagnia dei fratelli De Filippo è ora «del teatro umoristico» : qualifica che per noi, ammiratori tanto delle qualità disoppilative dell’umorismo che dei due comici, è quasi una consolazione che ci raggiunge nell’estrema vecchiaia di spettatori, proprio quando la mente, per effetto dell’età, vuol tendere sempre più verso i problemi frivoli e innocenti e trascurare i gravi, tra i quali, appunto, quelli del teatro.
Infatti, che i De Filippo mantengano in piedi una compagnia comico-dialettale o una compagnia umoristica poco dovrebbe importarci : pure un’oscura soddisfazione ce ne viene, se in tale differenza d’impresa si identifica tutto il lavoro che è stato fatto dagli attori per emanciparsi da un loro gusto troppo particolare e tentare il volo nei giusti limiti del linguaggio da palcoscenico. Molti anni fa i due fratelli recitavano nel teatro della papalina via Urbana, su un palcoscenico frusciante e glorioso. Davano gli episodi della vita di Felice Sciosciamocca, commedie nelle quali non si arrivava più a distinguere il processo di lavorazione. A un dipresso, sul tronco della vecchia farsa napoletana s’innestava la commediola brillante francese e il dialogo a base di malintesi.
Fortemente caratterizzati nelle truccature, con certi vistosi abiti a scacchi, candide pagliette schiacciate e calzoni da saltafossi, si facevano in quattro per divertire un pubblicò emigrato nella capitale dal disciolto regno delle Due Sicilie. La comicità era raggiunta coi mezzi più drastici e proibitivi, senza lavoro di sfumatura, con una prepotenza sana e popolaresca e di umorismo non si poteva nemmeno parlare. Del resto l’umorismo era allora un prodotto d’importazione che aveva le sue brave difficoltà ad imporsi in un teatro parte impantanato nei frizzi, nelle «scemenze» e parte addirittura tuffato nell’alto lirismo dei drammaturghi minori.

Col tempo i due attori si fecero sempre più esigenti verso se stessi sino ad arrivare, è sempre il programma che ci informa, a nominarsi «registi» della compagnia. Regista è una denominazione piena di fascino per indicare, sulla scorta di molti esempi, chi, senza averne le attitudini, del capocomico ha tutti i difetti. Uno di questi registi l’abbiamo visto sul più piccolo palcoscenico della città, col paraocchi verde, mentre urlava, in un megafono, suggerimenti a due attori spauriti che gli erano distanti un passo, e ci sembrò che stesse dando una giusta definizione di se. Oltre a questo adattarsi al gusto «moderno» i De Filippo curarono di diminuire il pittoresco eccessivo della loro recitazione, la facilità del loro repertorio e di arrivare ad un’intesa tra le esigenze del vecchio pubblico borbonico c le proprie esigenze di autori portati a una visione scettica e sentimentale della vita. È cosi che, senza volerlo, finirono per capire le possibilità di una convivenza del teatro coll'umorismo, il quale finalmente entrava, per la porta di servizio, ma entrava; e per merito quasi esclusivo dei due attori napoletani. Diciamo quasi perché non ci vien fatto di ricordare, tranne Petrolini, altri attori comici che abbiano tentato imprese nuove per puro amore dell’esperimento. Nei De Filippo c’è, del resto, una tendenza allo studio, all’ordine che li salva dal pericoloso mare dei dialetti e ci fa azzardare l’ipotesi che la commedia italiana possa risuscitare passando per Napoli.
Per aver continuamente affinate le loro qualità istintive, oggi i De Filippo riescono a recitare senza suggeritore e senza commedia; cioè hanno tirato fuori dall’umorismo tutti i vantaggi possibili. Ciò che basta loro, è una situazione qualsiasi, anche se povera, banale e senza uscita. È noto che Ermete Novelli, in trattoria, faceva diluviare di lagrime l’uditorio declamando la lista delle vivande : i De Filippo potrebbero far sorridere il pubblico più esigente col solo aiuto della Guida Monaci. Non vogliono dir nulla, ma dirlo bene. È curioso che l’autore più vicino alla loro sensibilità è Cecof delle novelle. Ciò non soltanto per la Creatura senza difesa che è addirittura rifatta su un racconto dell’autore russo, ma per quella parte di repertorio che mira all’analisi, al descrittivo, ossia nelle scene della vita di provincia, nelle quali il destino di certi personaggi è disegnato fermamente, all’insaputa dei modestissimi autori delle commedie.
Di quei giovani che aspirano ad inurbarsi, lasciando la vita vegetativa e le vecchie tradizioni familiari per il miraggio di un impiego in «città», i De Filippo ci parlano con un’evidenza e un amore letterario resi più probabili dalla dizione che colloca geograficamente i tipi e non li abbandona al crepuscolarismo generico. Delia questione del Mezzogiorno, anzi, illuminano uno degli aspetti più patetici e in certi momenti rimane la convinzione che l’abbiano reso liricamente. Senza voler esagerare ci si accorge che sono più vicini loro alla letteratura di quanto non lo siano molti autori d’oggi al teatro : nel ponte sospeso tra teatro e letteratura sono loro, insomma, che si fanno avanti coraggiosamente, tenendo la mano giusta.
* * *
Nei tre atti comici dati all’Eliseo, i De Filippo danno una buona misura della loro esperienza di rifacitori e di autori. Nella Parte di Amleto, Edoardo ha modo e maniera di mostrarsi in tutte le sue melanconiche attitudini. I personaggi che incarna di preferenza quest’attore sono altrettante canzonette napoletane senza musica, piene di quella tristezza propria a un popolo che adopra i fuochi d’artificio per regalarsi un sole notturno. Su questo motivo l’accompagnatore, Peppino, ricama il suo prudentissimo cinismo.
C'è un esempio nella storia romana di un mimo mandato per ambasciatore da Nerone, che non avrebbe avuto uomini di più sicura comunicativa di cui disporre per una difficile impresa. L’aneddoto ci tornava alla memoria guardando Peppino de Filippo come Procopio nel breve atto Si salvi chi può. Nella parte di commesso di studio rassegnato e apatico, l’attore non dice che un paio di battute contentandosi poi di osservare gli altri, silenzioso e immobile per tutta la durata dell’atto, ma raccontando più lui, con lo sguardo assente, il pencolar della testa e gli sbadigli di quanto riescano gli altri personaggi parlando e l’autore scrivendo : quello che si dice un ambasciatore impagabile e «segreto» come Polonio.
* * *
Gli altri attori della compagnia sono ottimi, in ispecie il Salvietti e la Marchesini, la signorina Franci e il De Martino.
Ennio Flaiano, «Oggi», 2 maggio 1940
 |
| Ennio Flaiano, «Oggi», 2 maggio 1940 |