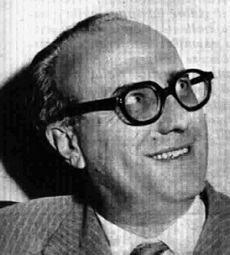Metz Vittorio
(Roma, 18 luglio 1904 – Roma, 1º marzo 1984) è stato uno scrittore, umorista e sceneggiatore italiano, autore di programmi televisivi e regista cinematografico.
Biografia
La sua lunga carriera, iniziata nel teatro per ragazzi, lo portò alle più svariate collaborazioni in campo giornalistico, cinematografico e televisivo, dove trovarono espressione la sua inventiva e la sua vena satirica. Dopo aver collaborato al Corriere dei Piccoli e al Candido di Giorgio Pisanò.[1]
Il Bertoldo
Fu tra i fondatori del Bertoldo nel 1939.
In coppia con Marchesi
A partire dagli anni cinquanta del XX secolo lavorò in televisione come autore di commedie musicali e spettacoli di varietà; il suo nome è spesso legato a quello di Marcello Marchesi, con cui firmò una serie di programmi di successo (Ti conosco mascherina, 1955; La piazzetta, 1956; il serial per ragazzi Giovanna, la nonna del Corsaro Nero,1961). Sempre con Marchesi collaborò alla sceneggiatura ed alla regia di alcuni film di Erminio Macario (Imputato, alzatevi!, 1939), di Totò (Totò cerca moglie, 1950; Totò sceicco, 1950) e altri successi della commedia all'italiana; non altrettanto fortunate furono le loro prove come registi (Milano miliardaria, 1951). Pubblicò anche raccolte di massime e proverbi e libri umoristici (Mia moglie a 45 giri, Roma in cocci).
Filmografia
Regia, sceneggiatura e soggetto
Era lui... sì! sì!, coregia con Marcello Marchesi (1951)
Milano miliardaria, coregia con Marcello Marchesi (1951)
Regia e sceneggiatura
Sette ore di guai, coregia con Marcello Marchesi (1951)
Il mago per forza, coregia con Marino Girolami e Marcello Marchesi (1951)
Tizio, Caio, Sempronio, coregia con Marcello Marchesi e Alberto Pozzetti (1951)
Noi due soli, coregia con Marcello Marchesi e Marino Girolami (1952)
Macario e l'idiozia intelligente
Macario è malato di umorismo. E, quel che è peggio, non di umorismo inglese, né russo, né di spirito francese. Bensì, di umorismo italiano. Quest’umorismo italiano, che non ha che pochissimi anni di vita, che è cresciuto a poco a poco, si è sviluppato sui giornali umoristici settimanali e bisettimanali e ne ha fatto, in un certo qual modo, la fortuna, ha creato una nuova maniera di parlare, ha dilagato in tutta la penisola propagandato dagli studenti che lo sentivano più di tutti, è entrato nel teatro, nella letteratura e nella radio, e finalmente, con Imputato, alzatevi! e Lo vedi come sei?! ha fatto il suo trionfale ingresso anche nel cinema. Quest’umorismo italiano che fa imbestialire i vecchi signori che non lo comprendono, che fa urlare di rabbia i critici che non riescono a definirlo e fa campare abbastanza bene quelli che lo hanno inventato.
Macario è appunto la personificazione teatrale di questo umorismo, che alcuni definiscono “intelligente”, che altri definiscono “idiota” e che forse non è altro che un’idiozia intelligente.
Si è detto che Macario è un clown, come si è detto che Macario è una maschera. Si sono scomodate le grandi ombre di Petrolini e di Ferravilla, si è parlato di “fenomeno Macario”, si è portato questo comico alle stelle, lo si è voluto demolire, centinaia di critici hanno tentato di definire la sua arte o la sua mancanza d’arte. Ora, io penso che Macario non si possa definire; si può, tutt’al più, discuterne. Macario, per alcuni è un Gianduia, foderato di Charlot e imbottito di fratelli Marx. Ora, se è difficile definire Gianduia, che ha secoli e secoli di teatro dell’arte dietro le spalle, se su Charlot sono stati scritti ponderosissimi volumi, se i fratelli Marx sono difficilissimi a comprendere, figuriamoci questi tre diversi esempi di comicità fusi insieme.
Per me, per esempio, ma solo in alcuni casi, Macario è un pupazzetto. Un pupazzetto di vignetta. È infatti l’unico comico che possa dire sulla scena le stesse cose che sono scritte in due righe sotto i disegni dei giornali umoristici.
L’associazione d’idee è la sua arma più formidabile. Dire, cioè, una cosa lontanissima come significato da quella che veramente vorrebbe dire. Per esempio: Macario, disperato, vuol andare a gettarsi nel fiume; ma siccome ha paura, lo dice a un suo amico, sperando che lo trattenga dal compiere l’insano proposito. Ma l’amico, l’immancabile Rizzo, non lo trattiene. Macario si avvia verso il fiume, ma, ad un certo punto, si volta.
“Non mi trattieni?”
“No...”
“Proprio per niente? Proprio per niente?”
“Ma no, ti dico!” risponde Rizzo, il cui compito principale consiste appunto nel dire, durante tutta la sera, “Ma no!”, “Ma, come?”, “Ma che dici!”, “Ma che ti salta in testa?”, per dar agio a Macario di dire la battuta. Una bella fatica! “Proprio no?”
“Ti dico di no...”
Macario fa un passetto, poi si volta. “Manica, manica?”
“Ma che dici?” ruggisce Rizzo.
”Si, non mi trattieni nemmeno per la manica?”
Nessuno pensa che Macario, dicendo “Manica, manica”, possa voler significare: “Sì, non mi trattieni nemmeno per la manica?” Può pensare, tutt’al più, allo stretto che divide la Francia dall’Inghilterra e nel quale oggigiorno non è consigliabile navigare. Oppure, non sa dove voglia andare a parare. Non si tratta di una battuta. Si tratta di una sorpresa. Sorpresa che agisce come un solletico mentale e fa ridere il pubblico, magari suo malgrado. Ed è questo che molta gente, come quelli a cui è stato fatto il solletico, dopo aver riso di ciò che dice Macario, per tutta una sera, esce dal teatro arrabbiatissima e magari indignata contro se stessa per aver riso. (...) È facile comprendere perché il pubblico rida quando Macario deforma le parole introducendovi delle enne dove non vanno, cioè dicendo “rimpetinzione”, invece di “ripetizione” e “anfonrisma”, invece di “aforisma”. Ride per la stessa ragione per cui si ride al balbettio dei bambini o alle impuntature dei balbuzienti. Come, quando, invece di “sempre scapolo, sempre scapolo?”, dice “sempre scampolo, sempre scampolo?”, la ragione dell'ilarità va ricercata nel fatto che la sostituzione meccanica di una parola di un dato significato con un’altra parola dello stesso suono ma di significato diverso è stata sempre ragione di riso. Pulcinella, invece di dire “Me ne entro quatto quatto, carponi, carponi”, dice: “Me ne entro quattro quattro, scarponi scarponi”, e tutti si contorcono sulle loro poltrone. Più difficile riuscire a comprendere perché il vezzo che ha Macario di ripetere due volte la stessa parola scateni l’allegria. Se lo stesso Pulcinella dicesse “Lume, lume”, non farebbe ridere nessuno. Se si scrivesse “lume, lume”, sotto una vignetta, ciò non desterebbe il buon umore nemmeno dell’uomo più ben disposto di questo mondo. Se Achille Campanile scrivesse “lume, lume” in uno dei suoi libri, i suoi lettori esclamerebbero: “Achille Campanile è finito!” Uno dei canoni dell’umorismo è che la ripetizione faccia ridere: questa forma di umorismo ha anzi un nome tecnico — si chiama “tormentone” — ma si tratta della ripetizione di un’intera frase che si riferisce ad un personaggio, come ad esempio: “Inutilmente, o astuto barone, eccetera, eccetera”, fatta a distanza e non di seguito. Se voi incontrate un amico e gli dite: “Bisogna che ti cambi il cappello”, lui la prima volta non riderà, se glielo ripeterete in occasione di un secondo incontro, lui, se non è un tipo permaloso, non dirà nulla; la terza volta, sapendo che state per dirglielo, rimarrà in attesa di quella vostra frase e, quando vi sarete deciso a pronunciarla, riderà prima ancora che l’abbiate finita per la soddisfazione di aver indovinato che gliel’avreste detta. Ma perché si ride quando Macario dice “lume, lume?”, o “Stai male, stai male?”. Può darsi che rida per la ragione suesposta, cioè perché se l’aspettava. Ma, allora, la prima volta, perché ha riso? Inquantoché la prima volta deve aver riso, altrimenti Macario non l’avrebbe ripetuta. Indubbiamente anche questo fa parte di quel solletico mentale di cui abbiamo parlato in precedenza, altrimenti sarebbe inesplicabile.
A voler essere sinceri, anche la faccenda del pupazzetto da giornale umoristico e il solletico mentale, i miei riferimenti a Pulcinella e alla commedia dell’arte sono tutte balle. E che Macario dica “lume, lume?” o “rimpentinzione”, a me non me ne importa proprio un fico secco.
Insomma, l’importante è che Macario continui a tener allegra la gente e a far pieni i teatri. Come ci riesca, sono affari suoi.
Vittorio Metz
Galleria fotografica e stampa dell'epoca

Nelle rubriche che lo hanno reso popolare egli condanna sua moglie a esprimersi con frasi stranamente tronche
Roma, luglio
Il ritratto della signora Metz appartiene ai classici dell’umorismo conetmporaneo. Lo ha narrato il marito trentanni fa: e ne rinverdisce sfondo e primi piani tuttora, nel timore che le tinte possano sbiadire e l’assunto polemico possa indebolirsi. Da allora, il profilo polemico della signora Metz non corre rischio di oblio, nella memoria dei innumeri lettori italiani.
Nessuna somiglianza
La signora Metz reale, evidente, fisicamente ignota al gran pubblico, non somiglia molto alla terribile donna sistemata da chi ben sappiamo nella letteratura contemporanea: sempre in gara col tempo: ognor presa dal dire in fretta il proprio pensiero, per parole mozze, frasi spezzate, tronche invettive, telegrafiche ordinanze. La signora Metz del ritratto dovuto alla fervida immaginazione di Vittorio Metz è profondamente dissimile dalla signora Metz che ha allevato molti figli, che dirige da ottima ed abbastanza sottomessa moglie una casa in città ed una in campagna. La violenza verbale attribuitale sembra tagliata più sulla minuta e piccante statura di Teresa Mosca, (consorte di Giovanni Mosca), che non sulle ragguardevoli e placate proporzioni della signora Metz.
Da trent’anni a questa parte, Metz ci presenta il suo personaggio come il terrore dei mariti distratti, ma estremamente volonterosi di riscattarsi da siffatta, pessima qualità. E', il suo, un modo come un altro per dirci che la paura va combattuta col non negare di avvertirla. Ma, in effetto, la signora Metz incute timore al marito non tanto per la propria per spicacia quanto per la personale decisissima dolcezza. Chi conosce direttamente questa signore Metz apprensiva e tranquilla, per la quale lo stato di allarme costituisce la situazione normale della vita di relazione, è ben in grado di ribattere le affermazioni di Vittorio Metz a carico della moglie. In verità, questo scrittore,"per amore di giustizia dovrebbe essere sottoposto ad uno di quei sin troppo lunghi processi che costituiscono il numero di centro della rubrica TV «Lui e Lei».
Ma tant’è! Vittorio Metz evade al placido quotidiano descrivendosi vittima della sorte famigliare, succubo della volontà muliebre. Sente il bisogno di essere commiserato. Non crede minimamente di essere proprio lui il colpevole, o fa finta dì volerlo credere. Si descrive arrotato dall’esistenza. Deve farci convinti della precarietà di ogni tentativo di svincolarsi dalla violenza di continuo esercitata contro le sue fondamentali libertà civili. All’avamspet-tacolo dell'improvvisazione, propone quale prologo la realtà del proprio dramma.
Da un’indagine approfondita che noi da anni stiamo conducendo sulla famiglia Metz, risulta che il violento è proprio il marito. Costui fa recitare a soggetto anche la moglie, dopo averla sottoposta a crudeli trattamenti di autoconvinzione. Lo umorismo di Vittorio Metz senza reale fondamento di verità descrive la sposa come l’archetipo della belva che, ai giorni nostri, rende insicuri i riposi meridiani di tutti i lavoratori dalle mezze maniche e dalle magre buste mensili. Secondo la lezione del nostro, la signora Metz, riuscito incrocio tra una indipendente virago dei cicli nordici ed un ferreo colonnello di Federico il Grande, mai a -vrebbe pronunciato intiero un sol vocabolo, preoccupata di accomunarne numerosissimi nei discorsi da far diluviare sullo smorto silenzio dell'avvilito consorte. Secondo quella lezione, il paradosso costituirebbe l’arma palese della signora Metz: la ingiunzione sarebbe la tattica normale di colei: la marcia famigliare in perenne ordine chiuso la sua specialità strategica. Invece, nella famiglia Metz, tutto procede a ruota libera, e ragionatamente. Ogni strada è mantenuta aperta ai barbari adolescenti che la compongono. E la signora Metz è sempre lì, a sospirare sulla soglia dei traguardi dispersi o all’ombra di divelte pietre miliari.
Tutta la verità
Cara signora Metz, così dissimile dalla malvagia deformazione che ne ha fatto la prosa maritale! Io no tenuto a cresima un suo figliolo e posso narrare l’ansia e le cure che essa prodiga alla famiglia in ogni giornata non certo fatta per restituire a normali condizioni di • nervi un qualsiasi «iper» od ; «ipo» teso. Comunque, dato che , abbiamo principiato ad istruirlo formalmente il processo a ; carico di un marito che ha cambiato le carte in tavola pur : di dimostrare da qual parte sia, : nel matrimonio in genere ed in quello che particolarmente è, lo riguarda in ispecie, la violenza, continuiamo a dirla intiera la verità su Vittorio Metz ! .
Perchè egli vittima si dice di esteriosi antipatie quando, in epoca lontana ma consegnata a lunga serie dì rivelatori taccuini, egli terrorizzò intieri paesi, attraversandone in divisa da rossodiavolo piazze e strade, a primalba, dopo aver abbandonato gli accampamenti di zingareschi Carri di Tespi dei quali a quel sol fine si dilettava far parte?
Perchè egli vittima si proclama della cronaca e della critica quando, in anni remoti ma non dimenticati e sempre documentabili, senza conoscere una sola nota, si dette ad orchestrare ed a dirigere intiere partiture di musica leggera napoletana. togliendo fama e scritture ai massimi specialisti del genere?
Perchè Vittorio Metz si confessa a piena discrezione di qualsiasi individuo destro nel difendere le proprie azioni o nell'ingannare l’inclita, quando, per mesi intieri, alla presenza di Leo Longanesi, epoca tra il 1945 ed il 1946, costituì il terrore dei posteggiatori che fregavano tutta Roma al gioco delle tre tavolette e che sempre furono regolarmente battuti da Vittorio Metz tra Piazza Navona, l’Isola di Francia e Trinità dei Monti?
Con simili precedenti, intimi ed estrinseci, di popolaresca autosufficienza, possiamo proprio considerare Vittorio Metz in balìa della fragile sposa? No, Signori della Corte ! Pollice verso per questo inegeneroso umorista del Secolo XX?
Yvon De Begnac, «Il Piccolo di Trieste», 4 luglio 1956

Troppo distratto per il fare il banchiere. Esordio avventuroso come autore e impresario al "Teatro delle Fiabe". Scambiato per il... diavolo in Calabria. Irruenza di Petrolini nella redazione del «Marc'Aurelio». Dai giornali umoristici a Cinelandia
Estro del prìncipe De Curtis
Totò sul set è uno spettacolo. Metz, autore di più di venti sceneggiature di suoi film a cominciare da «Totò cerca casa», mi spiega come il Principe De Curtis abbia bisogno dell'applauso e della risata del pubblico per essere davvero se stesso. Così nei teatri di posa, quando lavora lui, si consente ad amici e a curiosi di assistere alle riprese: uditorio che si gode gratis le trovate del divo: «E' un grande artista; potrebbe interpretare Molière; ma non rinuncia al proprio repertorio di lazzi che sa di sicuro effetto. Bisogna lasciarlo improvvisare. Se lo si contraria, si deprime e recita con l'occhio spento».
Furio Fasolo, «Stampa Sera», 2-3 dicembre 1959
La morte di Vittorio Metz un fondatore del «Bertoldo»
Ironizzò sulla retorica del fascismo
ROMA — Vittorio Metz, uno dei più famosi umoristi italiani, è morto sabato notte in una clinica romana in seguito ad un male incurabile. Aveva 79 anni. Lascia la moglie Celestina e cinque figli.
Alfredo Barberis, «Corriere della Sera», 5 marzo 1984

ROMA - «Quant'è forte la morte: ». Sono state le ultime parole di Vittorio Metz, rivolte alle figlie Delfina e Fioretta che, insieme con la moglie Celestina, gli sono rimaste accanto fino alla fine. Con un sorriso amato, Vittorio non è stato «tradito» dal suo «humour» e ha soggiunto: «Non ho argomenti sufficienti per controbatterla».
«Stampa Sera», 5 marzo 1984
Regia e soggetto
Lo sai che i papaveri, coregia con Marcello Marchesi (1952)
Sceneggiatura e soggetto
Non me lo dire! regia di Mario Mattoli (1940)
Pazzo d'amore regia di Giacomo Gentilomo (1942)
C'è un fantasma nel castello, regia di Giorgio Simonelli (1942)
Il fanciullo del West, regia di Giorgio Ferroni (1942)
Arcobaleno, regia di Giorgio Ferroni (1943)
L'avventura di Annabella, regia di Leo Menardi (1943)
Macario contro Zagomar, regia di Giorgio Ferroni (1944)
Circo equestre Za-bum, regia di Mario Mattoli (1945)
Tutta la città canta, regia di Riccardo Freda (1945)
Partenza ore 7, regia di Mario Mattoli (1946)
11 uomini e un pallone, regia di Giorgio Simonelli (1948)
Totò al giro d'Italia, regia di Mario Mattoli (1948)
Accidenti alla guerra!..., regia di Giorgio Simonelli (1948)
Adamo ed Eva, regia di Mario Mattoli [1949)
Totò le Mokò, regia di Carlo Ludovico Bragaglia (1949)
Totò sceicco, regia di Mario Mattoli (1950)
Tototarzan, regia di Mario Mattoli (1950)
Figaro qua, Figaro là, regia di Carlo Ludovico Bragaglia (1950)
I cadetti di Guascogna, regia di Mario Mattoli (1950)
Totò cerca moglie, regia di Carlo Ludovico Bragaglia (1950)
Bellezze in bicicletta, regia di Carlo Campogalliani (1951)
La paura fa 90, regia di Giorgio Simonelli (1951)
Arrivano i nostri, regia di Mario Mattoli (1951)
Il padrone del vapore, regia di Mario Mattoli (1951)
Era lei che lo voleva!, regia di Marino Girolami e Giorgio Simonelli (1953)
Io piaccio, regia di Giorgio Bianchi (1955)
La moglie è uguale per tutti, regia di Giorgio Simonelli (1955)
Totò lascia o raddoppia?, regia di Camillo Mastrocinque (1956)
Susanna tutta panna, regia di Steno (1957)
Femmine tre volte, regia di Steno (1957)
Totò, Vittorio e la dottoressa, regia di Camillo Mastrocinque (1957)
Buongiorno primo amore!, regia di Marino Girolami e Antonio Momplet (1957)
Totò a Parigi, regia di Camillo Mastrocinque (1958)
Mia nonna poliziotto, regia di Steno (1958)
Domenica è sempre domenica, regia di Camillo Mastrocinque (1958)
Totò, Eva e il pennello proibito, regia di Steno (1959)
I tartassati, regia di Steno (1959)
La cambiale, regia di Camillo Mastrocinque (1959)
Fantasmi e ladri, regia di Giorgio Simonelli (1959)
Le olimpiadi dei mariti, regia di Giorgio Bianchi (1960)
Femmine di lusso, regia di Giorgio Bianchi (1960)
Appuntamento a Ischia, regia di Mario Mattoli (1960)
A noi piace freddo...!, regia di Steno (1960)
Psycosissimo, regia di Steno (1961)
Sua Eccellenza si fermò a mangiare, regia di Mario Mattoli (1961)
Maciste contro Ercole nella valle dei guai, regia di Mario Mattoli (1961)
Totò diabolicus, regia di Steno (1962)
Appuntamento in Riviera, regia di Mario Mattoli (1962)
Uno strano tipo, regia di Lucio Fulci (1963)
Gli onorevoli, regia di Sergio Corbucci (1963)
002 agenti segretissimi, regia di Lucio Fulci (1964)
00-2 Operazione Luna, regia di Lucio Fulci (1965)
I due parà, regia di Lucio Fulci (1965)
Una ragazza tutta d'oro, regia di Mariano Laurenti (1967)
I ragazzi di Bandiera Gialla, regia di Mariano Laurenti (1967)
I tre che sconvolsero il West (Vado, vedo e sparo), regia di Enzo G. Castellari (1968)
I nipoti di Zorro, regia di Marcello Ciorciolini (1968)
Sceneggiatura
Lo vedi come sei... lo vedi come sei?, regia di Mario Mattoli (1939)
Imputato, alzatevi!, regia di Mario Mattoli (1939)
Il pirata sono io!, regia di Mario Mattoli (1940)
Cenerentola e il signor Bonaventura, regia di Sergio Tofano (1942)
Dove sta Zazà?, regia di Giorgio Simonelli (1947)
L'imperatore di Capri, regia di Luigi Comencini (1949)
Biancaneve e i sette ladri, regia di Giacomo Gentilomo (1949)
Il monello della strada, regia di Carlo Borghesio (1950)
La bisarca, regia di Giorgio Simonelli (1950)
47 morto che parla, regia di Carlo Ludovico Bragaglia (1950)
Totò terzo uomo, regia di Mario Mattoli (1950)
Una bruna indiavolata, regia di Carlo Ludovico Bragaglia (1951)
Io sono il Capataz, regia di Giorgio Simonelli (1951)
Era lei che lo voleva, regia di Marino Girolami e Giorgio Simonelli (1952)
Se vincessi cento milioni, regia di Carlo Campogalliani e Carlo Moscovini (1953)
Siamo uomini o caporali?, regia di Camillo Mastrocinque (1955)
Totò all'inferno, regia di Camillo Mastrocinque (1955)
Il campanile d'oro, regia di Giorgio Simonelli (1955)
Un militare e mezzo, regia di Steno (1959)
La duchessa di Santa Lucia, regia di Roberto Bianchi Montero (1959)
La ragazza di mille mesi, regia di Steno (1961)
Soggetto
Totò cerca casa, regia di Steno e Monicelli (1949)
È arrivato il cavaliere, regia di Steno e Monicelli (1950)
Totò, Peppino e i fuorilegge, regia di Camillo Mastrocinque (1956)
Pugni pupe e marinai, regia di Daniele D'Anza (1961)
I moschettieri del mare, regia di Steno (1961)
Yellow: le cugine, regia di Gianfranco Baldanello (1969)
Stanza 17-17 palazzo delle tasse, ufficio imposte, regia di Michele Lupo (1971)
Principali opere letterarie
La teoria sarebbe questa: romanzo umoristico, Milano, Rizzoli, 1935
Selciato di Roma, Milano, Rizzoli, 1942
Mia moglie a 45 giri, Milano, Rizzoli, 1963
Giovanna, la nonna del corsaro nero, Milano, Rizzoli, 1962
Mezzo secolo di risate ... a TuttoMetz: i più famosi scritti di Vittorio Metz caposcuola dell'umorismo italiano, dai mitici anni Trenta del Marc'Aurelio e del Bertoldo ai giorni nostri, prefazione di Oreste Del Buono, Milano, SugarCo, 1985
Note
Riferimenti e bibliografie:
- (EN) Opere di Vittorio Metz, su Open Library, Internet Archive
- (EN) Vittorio Metz, su Internet Movie Database, IMDb.com
- (EN) Vittorio Metz, su AllMovie, All Media Network
- Vittorio Metz in "Scenario", n.4, 1940
- "Follie del Varietà" (Stefano De Matteis, Martina Lombardi, Marilea Somarè), Feltrinelli, Milano, 1980
Sintesi delle notizie estrapolate dagli archivi storici dei seguenti quotidiani e periodici:
- Yvon De Begnac, «Il Piccolo di Trieste», 4 luglio 1956
- Furio Fasolo, «Stampa Sera», 2-3 dicembre 1959
- Alfredo Barberis, «Corriere della Sera», 5 marzo 1984
- «Stampa Sera», 5 marzo 1984