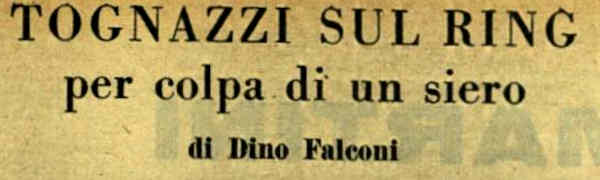Tognazzi Ugo
(Cremona, 23 marzo 1922 – Roma, 27 ottobre 1990) è stato un attore, regista, sceneggiatore, cuoco e gastronomo italiano.
Assieme a Totò girai nel 1958 il film « Totò nella luna ». Non ricordo quasi niente di quel film, uno dei primi che interpretai, ma conservo un prezioso e delicato ricordo di Totò. Rammento la sua sicurezza sul set, la soggezione che m’incuteva ed il piacere che provai quando mi disse che io non ero un « comico », ma un « attore ». Ci ritrovammo qualche anno dopo, per girare assieme un altro film, e mi ripetè « Diventerai un grosso attore ». Quando morì mi offersi di sostituirlo nel film « Il padre di famiglia » che Nanni Loy aveva in preparazione. Lo feci per rendergli un modesto omaggio.
Totò non era un attore, ma un « fatto » una forza concreta che si esprimeva in un modo surreale. Forse oggi si accetta un modo macchiettistico di fare ridere, ma si ride di meno. Un altro Totò, l’equivalente delle sue maschere, del suo tempismo, insomma un Totò inedito furoreggerebbe anche oggi; anzi, ci manca. Totò è stato il più grande « comico » che l’Italia abbia avuto.
Con Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi, è considerato uno dei "mostri" della commedia all'italiana (secondo la celebre definizione del critico Gian Piero Brunetta[1], un quartetto al quale, dagli anni Sessanta, è generalmente accostato anche Marcello Mastroianni).
Biografia
A causa della professione del padre Gildo, ispettore di una società di assicurazioni, vive gli anni dell'infanzia in varie città per tornare poi, nel 1936, nella natìa Cremona dove, quattordicenne, trova lavoro come ragioniere nel salumificio Negroni. Nel tempo libero recita in una filodrammatica del dopolavoro aziendale, ma l'esordio teatrale era già avvenuto al teatro Donizetti di Bergamo, a soli quattro anni. Durante la seconda guerra mondiale viene chiamato alle armi e si dedica con impegno a organizzare spettacoli di varietà per i commilitoni.
Dopo l'armistizio dell'8 settembre ritorna a Cremona dove lavora come archivista e fa parte per un breve periodo delle Brigate Nere. Nel 1945 la passione per lo spettacolo lo induce ad abbandonare il lavoro e trasferirsi a Milano. Qui partecipa a una serata per dilettanti tenuta al Teatro Puccini a seguito della quale viene scritturato dalla compagnia teatrale di Wanda Osiris. Nel 1950 esordisce al cinema con un film diretto da Mario Mattoli, I cadetti di Guascogna, al fianco di Walter Chiari.
Ugo Tognazzi, una questione di stile
Ricordiamo una delle prime apparizioni di Ugo Tognazzi dinnanzi al gran pubblico della Rivista: si presentava in uno sketch dove imitava con molto spirito e con vivo successo Totò e Dapporto. Fu quello sketch a dare il via alla sua fortunata carriera e non si può, dunque, rimproverargli il fatto che nella sua comicità permanga ancora un’eco dello stile di quei due grossi comici. Ma Tognazzi è giovanissimo e ha tutto il tempo di trovare se stesso, mondo d’ogni altrui scoria. Ha due formidabili doti per un attore comico: la simpatia, una simpatia che va a colpo sicuro, per cui conquista il pubblico non appena compare alla ribalta, e un preciso, modernissimo senso dell’umorismo, che si avverte dal modo ineccepibile con cui racconta le storielle, arte che può sembrare elementare, ma che è invece quanto mai ardua.
Un giorno — se la Casa Editrice « Academia » sarà d’accordo — compileremo una Guida alla Storiella nella quale evocheremo le origini, sintetizzeremo gli sviluppi, analizzeremo la importanza sociale e tracceremo un Panorama della Barzelletta. Dovremo allora riparlare a lungo di Ugo Tognazzi e di quella sua maniera di lanciare la battuta allegra a bazza in fuori e a occhi semichiusi, come fa il gallo col chicchirichì; e menzioneremo lo stile impeccabile con cui la bocca a taglio di salvadanaio del nostro Ugo aspira golosamente l’aria, fra una boutade e l’altra, quasi per assaporare da buongustaio il sale e il pepe della nuova storiella che gli viene in mente. Ma in ogni modo Tognazzi bisogna tenerlo d’occhio. Non passerà gran tempo e quel suo nome, che sa di provincia e di fuoco d’artificio, avrà conquistato definitivamente la più indiscussa delle rinomanze.
Dino Falconi e Angelo Frattini
L’ingresso di Elena Giusti avvenne in una cornice che meritò nutriti applausi a scena aperta. Si ebbe anzitutto il perfetto decollo di un grosso velivolo (con tante congratulazioni ai macchinisti), dopo di che furono accese tutte le luci su uno scenario vagamente interplanetario (o cosmico, che fosse), in cui soubrettine e boys facevano da costellazioni.
Sullo sfondo nuvole in movimento in un “cielo” splendidamente azzurro. Al centro, la via lattea, ossia una larga scala, lungo la quale scendeva una pigra cascata di schiuma. Infine, lungo la stessa scala (ma, naturalmente, ben lontano dalla schiuma, ossia dalla saponata) scese Elena Giusti. Cantò Desiderio d’amore e fu ammiratissima in un lucido abito argentato che aveva tutte le carte in regola per essere considerato un gioiello. Apparve ulteriormente, Elena Giusti, a cantare, e ballare, e recitare; si presentò anche in bikini giamaicano; e creò la stessa atmosfera di suggestione del quadri del suo ingresso, in sede di finale del primo tempo, con un — come si dice? — vaporosissimo abito bianco.
S. G. Biamonte

Finito il militare, andai a Milano con un bagaglio di esperienze come attore negli spettacoli per le truppe e partecipai a un concorso per dilettanti dal quale uscii trionfatore, e a cui segui l’immediata proposta di diventare comico di varietà, di avanspettacolo. Da quel momento inizia il mio lavoro di attore, perché da quel momento diventa lavoro veramente, mi danno 150 lire al giorno, nel ’44 ci potevo campare. Durante quell’ultimo anno di guerra ho fatto l’avanspettacolo fra Milano e provincia, poi... la grande occasione. Vengono due impresari a vedermi, due autori, i famosi Bracchi e D’Anzi, più Wanda Osiris, allora la regina, il massimo veramente, e mi propongono di diventare il comico della Osiris. Da quel momento smetto di fare l’avanspettacolo e vengo ugualmente pagato in attesa del debutto con la Wanda.
Senonché finisce la guerra e chi mi dava i soldi sparisce il giorno stesso della liberazione, quindi sparisce l’impresario e con lui anche il sogno Wanda Osiris. Però ormai ero uno chiacchierato, se non altro, e cosi divento attore di rivista di un livello superiore, cioè passo subito allo spettacolo teatrale vero e proprio, anche perché nel dopoguerra vengono di moda tutti quegli spettacoli di rivista che avranno poi il loro apice nei lavori di Garinei e Giovannini. Dal '45, formandosi le compagnie di giro, cominciano delle cose tragiche per il lavoro dell’attore. Sarebbe bene rammentare che cosa significava per esempio viaggiare da Genova a Bari in vagone bestiame, perché non erano ancora state ripristinate le carrozze normali, per debuttare due giorni dopo, poi tre o quattro città delle Puglie, poi un salto a Palermo, altre tre o quattro città, duecento città e tre paesi toccati durante una stagione; quando a Milano o a Roma si facevano 15 giorni era già un bel successo.
Ugo Tognazzi
L'anno seguente conosce Raimondo Vianello con cui forma una coppia comica di grande successo che dal 1954 al 1960 lavora per la neonata RAI con il varietà Un due tre; la comicità più popolaresca e sanguigna di Ugo e quella più raffinata e "inglese" di Raimondo si compenetrano a vicenda con ottimi risultati comici. Dopo numerose farse cinematografiche e televisive Tognazzi negli anni sessanta passa alla commedia all'italiana, dando un apporto molto personale al genere: al suo interno infatti gioca magistralmente la carta delle sue radici equidistanti tra l'operosa Milano e la godereccia Bassa Padana tra Cremona, Piacenza e Modena, interpretando personaggi emiliani, e più specificamente parmigiani, in modo assolutamente convincente, agli ordini prima di Alberto Bevilacqua (La Califfa, 1971; Questa specie d'amore, 1972) e poi di Bernardo Bertolucci (La tragedia di un uomo ridicolo, 1981, che vale a Tognazzi la Palma d'Oro al Festival di Cannes come miglior attore protagonista).
Attaccatissimo alla sua terra e alla sua città, pur essendo un appassionato tifoso del Milan, non era infrequente trovarlo allo stadio Zini a tifare per la Cremonese del suo amico e primo compagno di palcoscenico, il presidente Domenico Luzzara. Ugo ritaglia spesso per i suoi personaggi battute in dialetto cremonese. Leggendarie sono quelle, numerose, contenute nel film La marcia su Roma (1962) di Dino Risi. Nella pellicola che lo lancia nel cinema satirico, Il federale (1961) di Luciano Salce, il suo personaggio è di Azzanello, piccolo paese in provincia di Cremona.
Parallelamente a quelle esperienze di cinema d'autore, Tognazzi si impegna nelle trilogie di Amici miei (1975, 1982, 1985) e Il vizietto (1978, 1980, 1985), che rappresentano l'apice del suo successo di pubblico. Si autodirige in cinque film (Il mantenuto, 1961; Il fischio al naso, 1966; Sissignore, 1968; Cattivi pensieri, 1976; I viaggiatori della sera, 1979) e nella serie televisiva FBI - Francesco Bertolazzi investigatore (1970). Negli anni ottanta si dedica soprattutto al teatro, recitando in Sei personaggi in cerca d'autore a Parigi (1986), L'avaro (1988) e, con Arturo Brachetti, M. Butterfly (1989).
Esperto culinario e grande tombeur de femmes, ma anche amico di Vittorio Gassman, Paolo Villaggio, Luciano Salce e Mario Monicelli, negli ultimi anni della sua vita si ammala di depressione - il male oscuro che condivise personalmente con lo stesso Gassman - e muore improvvisamente, nel sonno, il 27 ottobre 1990 a Roma per un'emorragia cerebrale, lasciando incompleta la serie televisiva Una famiglia in giallo (ne furono ultimati e poi trasmessi in televisione l'anno successivo solo due episodi), rimasta pertanto il suo ultimo lavoro; è sepolto a Velletri. Vent'anni dopo, alla Festa del Cinema di Roma, la figlia Maria Sole presenta il documentario a lui intitolato, Ritratto di mio padre.
Vita privata
Oltre che la goliardia, di Ugo Tognazzi celebri sono state le passioni per le donne e per gli eleganti corteggiamenti, tipici del suo carattere. Nel 1954 s'innamora di una ballerina inglese d'origini irlandesi della sua rivista, Pat O'Hara dalla quale ebbe il figlio Ricky, divenuto a sua volta attore e regista. Con Pat non si sposa, e la storia dura fino a circa il 1961. Nel 1961 conosce Margarete Robsahm, attrice norvegese con cui lavora ne Il mantenuto, che sposa nel 1963, e l'anno seguente nasce Thomas, che ora si divide tra produzione e regia. Con Margarete Ugo vive tre anni, di cui uno tra l'Italia e la Norvegia.
Dopo averla già conosciuta e corteggiata invano qualche anno prima, nel 1965 Ugo ritrova colei che alla fine diventerà la donna della sua vita, Franca Bettoja: è anche lei attrice, bella e raffinata. Ma è soprattutto donna intelligente e generosa, che non solo sa rimanergli accanto fino alla fine, ma sa anche tenere assieme una strana, allargata famiglia, rinunciando a inseguire il proprio successo professionale. Ugo sposa Franca nel 1972, a Velletri, dove i due misero su una bellissima e accogliente grande casa comune, oggi aperta al pubblico per iniziative culturali[4]. Dalla loro relazione nascono due figli: Gianmarco Tognazzi nel 1967, anche lui attore affermato, e Maria Sole Tognazzi nel 1971, regista. I figli precedenti sono sempre stati di casa, soprattutto Ricky, mentre Thomas, che continuava a vivere con la madre Margarete, ha fatto sempre la spola tra l'Italia a la Norvegia per unirsi a loro.
Era un acceso e appassionato tifoso del Milan. Della squadra rossonera disse in un'intervista del 1986:
« Sono milanista dalla nascita. Il Milan per me è stato prima la mamma, poi Ia fidanzata e poi la moglie. La moglie però si tradisce.[5] »
Goliardia e satira
Un due tre praticamente fu il primo esempio di satira televisiva, che non evitò di toccare Presidenti della Repubblica e del Consiglio. Per un'epoca nella quale la censura televisiva discendeva dalla stessa impostazione data alla rete unica della RAI, ciò si prestava inevitabilmente a qualche guaio censorio, che sarebbe evoluto verso la chiusura stessa del programma. Questa avvenne il 25 giugno del 1959 quando il duo Tognazzi-Vianello decise di mettere in burletta un incidente occorso la sera prima alla Scala e rigorosamente taciuto dai principali mezzi di stampa: il Capo dello Stato italiano (Giovanni Gronchi), a causa del tentativo di un gesto galante con una signora, cadde a terra per la sottrazione della sedia accanto al presidente della Repubblica Francese De Gaulle. Il duo ripeté la scena in televisione: Vianello tolse la sedia a Tognazzi che cadde a terra e Vianello gli gridò: "Chi ti credi di essere?". La sera stessa Ettore Bernabei cancellò la trasmissione dalla programmazione televisiva e il direttore della sede di Milano venne cacciato.[6][7]
Lo spirito goliardico di Ugo Tognazzi raggiunse il culmine vent'anni dopo quando, nel 1979, prese parte a uno dei più clamorosi scherzi mediatici della storia italiana: accettò di essere fotografato ammanettato da finti carabinieri. Si trattava di una burla predisposta dal settimanale satirico Il Male. Tre finte edizioni del Giorno, della Stampa, di Paese Sera[8] "uscirono" con titoli che annunciavano l'arresto dell'attore, in quanto capo ("grande vecchio") delle famigerate Brigate Rosse.
Giustificandosi della goliardata disse che, in un'epoca del genere, aveva solo rivendicato "il diritto alla cazzata". In realtà, lo scherzo cadeva all'indomani della retata del "caso 7 aprile", nella quale la stampa tambureggiava sui "capi occulti" delle BR che avevano simulato lo scioglimento di "Potere operaio" per proseguire sotto le insegne di "Autonomia Operaia" nell'attività di fiancheggiamento dell'eversione: ecco perché il titolo del Male, chiosando il vecchio scherzo satirico, aggiungeva: "ricercato Vianello, la coppia finse lo scioglimento dai tempi di Un due tre".
Durante un'intervista condotta da Pippo Baudo, iniziò polemicamente e ironicamente a discutere sulla liberalizzazione della marijuana, sullo scandalo Negri e sulla legalizzazione della prostituzione.
Galleria fotografica e stampa dell'epoca
Ugo Tognazzi, raccolta di articoli di stampa
Tognazzi con i capelli grigi
I sorrisi di Claudia hanno illuso Tognazzi
Ugo Tognazzi, il seduttore geloso
Ugo Tognazzi sposerà Franca Bettoja
I mostri sono tra noi
Un povero Nero Wolfe con famiglia a carico
Ugo Tognazzi padre di sé stesso
Ugo Tognazzi ha fatto tutto: rivista, cinema, teatro, TV
Ugo Tognazzi, raccolta di articoli di stampa
Tognazzi con i capelli grigi
I sorrisi di Claudia hanno illuso Tognazzi
Ugo Tognazzi, il seduttore geloso
Ugo Tognazzi sposerà Franca Bettoja
I mostri sono tra noi
Un povero Nero Wolfe con famiglia a carico
Ugo Tognazzi padre di sé stesso
Ugo Tognazzi ha fatto tutto: rivista, cinema, teatro, TV
vice, «Gazzetta del Popolo», 21 dicembre 1954
«Epoca», 1956 - Recensione della rivista con Tognazzi e Vianello Campione senza volere

Con un discutibile copione, ma una recitazione molto corretta, Ugo Tognazzi si è presentato per la prima volta al pubblico romano come attore di prosa
Risorse dei tempi. Se è possibile e lecito far diventare una volgare saponetta del fragrante olio d’oliva per la tavola dei più esigenti palati, perchè non dovrebbe essere lecito e possibile trasformare un qualsiasi racconto poliziesco in una gaia commedia a successo, sofisticata con volubili problemi psicologici e strampalate pensierosità, da offrire ad un pubblico che, in fondo, non chiede altro che di divertirsi anche quando s’annoia? Barare a teatro è un reato ancora consentito e non cade sotto le zampe del codice.
Cominciando magari dal titolo. Il quale, appropriandosi senza ragione alcuna le bibliche minacce di Gog e Magog, evoca conturbanti ricordi di profetiche catastrofi che non si sognano neanche lontanamente di passare nelle vicinanze del copione.
Ebbe inizio tosi. A firma di Roy Vickers, appare in Inghilterra uno dei soliti e tanti romanzi polizieschi. Entrano in scena i signori Roger MacDugall e Ted Allan. Lo rimpolpano quel che è necessario, lo articolano in tre atti e lo mandano alla ribalta come giallo psicologico. Successo. Qualcuno lo vede, lo acquista, lo porta in Francia e lo mette nelle mani di Gabriel Arout, scaltro manipolatore del teatro francese un po’ meno ignoto dei suoi due colleghi londinesi. Egli lo ridialoga da capo a fondo lo condisce in dosi acconce dei più sperimentati ingredienti del repertorio così detto boulevardier, punta decisamente sul risultato comico conferendogli una farsesca lepidezza spruzzata di quell’intellettualismo che fa tanto intelligente, lo dà ad interpretare a Francois Périer il quale ne fa, dicòno, una creazione spassosissima, e realizza uno dei maggiori successi parigini. Due anni di repliche continuate.
In coscienza, a questo punto, poteva non arrivare in Italia?
I nostri teatranti, si sa, se non vanno ad origliare nei teatri di Parigi almeno ogni paio di mesi si sentono mancare il terreno sotto i piedi. Si tratta di cercare un copione per l’esordio in prosa di Ugo Tognazzi e pensano di aver trovato il fatto loro. Tognazzi, tanto per non smentirsi, oltre ad essersi fatto abbandonare, alla vigilia del debutto, dal regista e dalla prim’attrice — tanto per la cronaca: Sandro Bolchi e Laura Solari — dal canto suo ci aggiunge e ci toglie qualche altra cosetta e gioca la sua carta. Non fa cappotto ma vince la partita ai punti.
Stringi stringi, di che si tratta? Della consueta rivolta dello schiavo, conseguita per mezzo del venerando espediente dei sosia con tutti gli equivoci che possono generarsi da una somiglianza perfetta. Sfido, i due sosia sono la stessa persona: Giuliano Fanshow, uomo timido e remissivo, marito innamorato e preoccupato, genero disprezzato e vilipeso, pittore fallito, musicista incompreso e, per giunta, nipote truffato da un sarcastico zio, incaricato, dal defunto genitore, di amministrargli il patrimonio ereditato ma non goduto. Nell’altro se stesso, egli realizza tutto ciò che non è: supera ed ipercompensa il proprio complesso di inferiorità, affascina e riconquista la moglie, agguanta il successo, seduce la suocera, mette nel sacco lo zio e, sospettato per un momento di essere stato lui, anzi di aver architettato tutto a quell’unico scopo, fa esplodere gli istinti omicidi sonnecchiante nell’ inconscio di un meschino impiegato che gli toglie dai piedi l'incomodità dello zio.
Ad un primo atto banale, lento e risaputo, ne seguono altri due, per fortuna, più vari, svelti e spiritosi con qualche modesta trovatina originale grazie ad innocui furtarel-li operati e danno di Freud e Piraijiello: subcosciente, frustrazioni, sdoppiamento della personalità; come sono e come mi vedono, realtà' e illusione, finzione e verità e via discorrendo.
A Milano gli intervalli sono evasivi e noncuranti, a Roma sono risentiti e feroci. Giudicando dai discorsi del pubblico del Quirino durante il primo intervallo, il meglio che uno si potesse aspettare in seguito era un’esecuzione capitale. Viceversa, copione e recitazione, nella seconda parte, le sorti della serata si sono risollevate e tutto è finito in gloria consentendo al cronista di poter aggettivare la parola successo col termine incontrastato, letteralmente ineccepibile.
Quando si dice il complesso della prosa! Chi si attendeva un Tognazzi estroso, improvvisatore, rivistaiolo, è stato deluso, o soddisfatto a seconda del punto di vista. Molto controllo, molta correttezza, molta eleganza, sufficiente stile, un’aria da bravo giovanotto di buona famiglia e un impeccabile completo color testa di moro. Un impegno serio. O, per meglio dire, una vittoria strappata in formazione di difesa. Gli altri: la Steni, la Giachetti, il Severini, il Cartoni, il Cundari? Bene. Ma sì, crepi l’avarizia!
Carlo Terron, «Tempo», anno XXII, n.45, 5 novembre 1960

Nel film “La moglie americana” Ugo Tognazzi porta a termine un'esperienza piuttosto amara e sconcertante: emigra nella lontana Florida in cerca di fortuna e di facili avventure, ma poi si rende conto che, tutto sommato, sarebbe stato molto meglio continuare a vivere in Italia
 Juliet Prowse, in perfetta tenuta da bagnante, sorride a Ugo Tognazzi, impegnato in un tenero baciamano. Siamo a Miami Beach, in una delle tante piscine-albergo della Florida. I due attori sono attualmente impegnati nella lavorazione cinematografica di "La moglie americana”. Il film narra la vicenda di un italiano - Ugo Tognazzi - che, emigrato negli Stati Uniti in cerca di un lavoro che gli consenta di rientrare in patria con un po’ di quattrini, s’innamora a tal punto di quel Paese da restarci per sempre. Continuamente alla ricerca di facili avventure amorose, cadrà nella rete tesagli da Juliet Prowse e finirà con lo sposarla; ma si renderà poi conto, a contatto con un mondo tanto diverso dal suo, che la vita continua ad essere difficile per lui, in ogni caso. Juliet Prowse fu, per un certo periodo di tempo - precisamente nel 1961, e per oltre un anno - la fidanzata ufficiale (si parlò addirittura di un loro matrimonio) di Frank Sinatra.
Juliet Prowse, in perfetta tenuta da bagnante, sorride a Ugo Tognazzi, impegnato in un tenero baciamano. Siamo a Miami Beach, in una delle tante piscine-albergo della Florida. I due attori sono attualmente impegnati nella lavorazione cinematografica di "La moglie americana”. Il film narra la vicenda di un italiano - Ugo Tognazzi - che, emigrato negli Stati Uniti in cerca di un lavoro che gli consenta di rientrare in patria con un po’ di quattrini, s’innamora a tal punto di quel Paese da restarci per sempre. Continuamente alla ricerca di facili avventure amorose, cadrà nella rete tesagli da Juliet Prowse e finirà con lo sposarla; ma si renderà poi conto, a contatto con un mondo tanto diverso dal suo, che la vita continua ad essere difficile per lui, in ogni caso. Juliet Prowse fu, per un certo periodo di tempo - precisamente nel 1961, e per oltre un anno - la fidanzata ufficiale (si parlò addirittura di un loro matrimonio) di Frank Sinatra.


Un altro atteggiamento da dongiovanni, rispettoso (si noti l’inchino di Tognazzi che tiene le braccia dietro la schiena) e dolciastro assieme, del nostro attore durante una scena del film. A destra: una espressione piuttosto imbarazzata e incerta del "conquistatore". Sotto: la bellissima Juliet Prowse in bikini, durante una pausa della lavorazione del film. Juliet. nata a Bombay 29 anni fa. è un’ottima ballerina. Fece parte anche, nel 1957. della compagnia di Macario come "soubrette" nella rivista "Non sparate alla cicogna". Ha interpretato molti film fra cui "French Can Can”.
«Tempo», anno XXVII, n.6, 10 febbraio 1965
«Noi donne», anno XXIII, 2 novembre 1968
e. b., «Radiocorriere TV», 25 aprile 1970

ROMA. E' morto ieri sera alle 23 e 15 a Villa Nomentana, l'attore Ugo Tognazzi. Giovedì scorso era stato colto da un malore nella sua villa di Torvajanica, ieri mattina l'emorragia cerebrale che l'ha costretto al ricovero. Ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate ed è entrato in coma.
Era nato a Cremona il 23 marzo del 1922. Il suo esordio nel cinema avvenne nel 1950 con il film «I cadetti di Guascogna». Da allora ha interpretato oltre 200 film, portando sullo schermo il volto dell'italiano medio e i mutamenti di costume della società. Tra i suoi film più noti: Il Federale, L'ape regina, Io la conoscevo bene, Venga a prendere il caffè da noi, Questa specie d'amore, Amici miei e Il Vizietto. Si era anche cimentato nella regia con cinque film, l'ultimo dei quali «I viaggiatori della sera» del 1979.
[r. cri.], «La Stampa», 28 ottobre 1990

«Il Piccolo di Trieste», 29 ottobre 1990 - Parte 1 - Parte 2 - Parte 3
Mino Monicelli, «Radiocorriere TV», 17 novembre 1990
Riconoscimenti
Premi cinematografici
David di Donatello
1967 L'immorale Migliore attore protagonista Vinto
1971 La Califfa Migliore attore protagonista Vinto
1976 Amici miei Migliore attore protagonista Vinto
Nastro d'argento
1964 Una storia moderna: l'ape regina Migliore attore protagonista Vinto
1966 Io la conoscevo bene Migliore attore non protagonista Vinto
1968 L'immorale Migliore attore protagonista Candidatura
Il padre di famiglia Migliore attore non protagonista Candidatura
1969 La bambolona Migliore attore protagonista Vinto
1970 Il commissario Pepe Migliore attore protagonista Candidatura
1975 Romanzo popolare Migliore attore protagonista Candidatura
1976 Amici miei Migliore attore protagonista Candidatura
1977 La stanza del vescovo Migliore attore protagonista Candidatura
1982 La tragedia di un uomo ridicolo Migliore attore protagonista Vinto
Globo d'oro
1971 La Califfa Miglior attore Vinto
Grolla d'oro
1964 I mostri Miglior attore Vinto
1967 L'immorale e Il fischio al naso Miglior attore Vinto
Golden Globe
1968 L'immorale Miglior attore in un film commedia o musicale Candidatura
Festival di Cannes
1981 La tragedia di un uomo ridicolo Miglior interpretazione maschile Vinto
Dediche
Gli sono stati dedicati:
il Parco "Ugo Tognazzi" a Cremona
il cinema "Tognazzi" a Cremona (non più attivo)
l'istituto professionale alberghiero (I.P.S.S.A.R.) "Ugo Tognazzi" di Pollena Trocchia (NA)
il Teatro comunale "Ugo Tognazzi" di Velletri (RM)
l'istituto professionale alberghiero "Ugo Tognazzi" di Velletri (RM)
una delle sale del cinema "Multisale Ariston" di Colleferro (RM)
un tratto del lungomare di Torvaianica, comune di Pomezia (Roma)
una frazione di Torvaianica (Pomezia, Roma) porta il suo nome
Teatrografia
1944 - Spettacolissimo
1944 - Si chiude (quasi) all'alba
1945 - Vive le donne!
1945 - Polvere negli occhi
1945 - Polvere di Broadway
1946 - Bocca baciata
1946 - Cento di queste donne
1946 - Cavalcata di donne
1948 - Febbre azzurra
1948 - Paradiso per tutti
1949 - Castellinaria
1950 - Quel treno che si chiama desiderio
1951 - Dove vai se il cavallo non ce l'hai
1952 - Ciao fantasma
1953 - Barbanera, bel tempo si spera
1954 - Passo doppio
1955 - Campione senza volere
1955 - Il medico delle donne
1956 - Il fidanzato di tutte
1957 - Uno scandalo per Lilli
1957 - Papà mio marito
1957 - L'uomo della grondaia
1960 - Gog e Magog
1975 - Il Tartufo
1986 - Sei personaggi in cerca d'autore
1988 - L'avaro
1989 - M. Butterfly
Filmografia
Attore
Cinema
I cadetti di Guascogna, regia di Mario Mattoli (1950)
La paura fa 90, regia di Giorgio Simonelli (1951)
Una bruna indiavolata, regia di Carlo Ludovico Bragaglia (1951)
Auguri e figli maschi!, regia di Giorgio Simonelli (1951)
L'incantevole nemica, regia di Claudio Gora (1953)
Sua Altezza ha detto: no!, regia di Maria Basaglia (1953)
Siamo tutti milanesi, regia di Mario Landi (1953)
Se vincessi cento milioni, regia di Carlo Campogalliani e Carlo Moscovini (1953)
Café Chantant, regia di Camillo Mastrocinque (1953)
Ridere! Ridere! Ridere!, regia di Edoardo Anton (1954)
Milanesi a Napoli, regia di Enzo Di Gianni (1954)
La moglie è uguale per tutti, regia di Giorgio Simonelli (1955)
Domenica è sempre domenica, regia di Camillo Mastrocinque (1958)
Totò nella luna, regia di Steno (1958)
Mia nonna poliziotto, regia di Steno (1958)
Marinai, donne e guai, regia di Giorgio Simonelli (1958)
Il terribile Teodoro, regia di Roberto Bianchi Montero (1958)
Guardatele ma non toccatele, regia di Mario Mattoli (1959)
Fantasmi e ladri, regia di Giorgio Simonelli (1959)
Non perdiamo la testa, regia di Mario Mattoli (1959)
Policarpo, ufficiale di scrittura, non accreditato, regia di Mario Soldati (1959)
Le cameriere, regia di Carlo Ludovico Bragaglia (1959)
Psicanalista per signora, regia di Jean Boyer (1959)
Noi siamo due evasi, regia di Giorgio Simonelli (1959)
La duchessa di Santa Lucia, regia di Roberto Bianchi Montero (1959)
La cambiale, regia di Camillo Mastrocinque (1959)
Tipi da spiaggia, regia di Mario Mattoli (1959)
La sceriffa, regia di Roberto Bianchi Montero (1959)
La Pica sul Pacifico, regia di Roberto Bianchi Montero (1959)
I baccanali di Tiberio, regia di Giorgio Simonelli (1960)
Genitori in blue-jeans, regia di Camillo Mastrocinque (1960)
Il principe fusto, regia di Maurizio Arena (1960)
Il mio amico Jekyll, regia di Marino Girolami (1960)
Le olimpiadi dei mariti, regia di Giorgio Bianchi (1960)
Femmine di lusso, regia di Giorgio Bianchi (1960)
Un dollaro di fifa, regia di Giorgio Simonelli (1960)
Tu che ne dici?, regia di Silvio Amadio (1960)
A noi piace freddo...!, regia di Steno (1960)
Gli incensurati, regia di Francesco Giaculli (1961)
Sua Eccellenza si fermò a mangiare, regia di Mario Mattoli (1961)
Che gioia vivere, regia di René Clément (1961)
Il federale, regia di Luciano Salce (1961)
5 marines per 100 ragazze, regia di Mario Mattoli (1961)
La ragazza di mille mesi, regia di Steno (1961)
Il mantenuto, non accreditato, regia di Ugo Tognazzi (1961)
Pugni pupe e marinai, regia di Daniele D'Anza (1961)
I magnifici tre, regia di Giorgio Simonelli (1961)
Una domenica d'estate, regia di Giulio Petroni (1962)
La voglia matta, regia di Luciano Salce (1962)
Psycosissimo, regia di Steno (1962)
La cuccagna, non accreditato, regia di Luciano Salce (1962)
I tromboni di Fra' Diavolo, regia di Giorgio Simonelli (1962)
I motorizzati, regia di Camillo Mastrocinque (1962)
La marcia su Roma, regia di Dino Risi (1962)
Il giorno più corto, regia di Sergio Corbucci (1963)
Ro.Go.Pa.G., episodio Il pollo ruspante, regia di Ugo Gregoretti (1963)
Le ore dell'amore, regia di Luciano Salce (1963)
Una storia moderna - L'ape regina, regia di Marco Ferreri (1963)
I mostri, regia di Dino Risi (1963)
I fuorilegge del matrimonio, regia di Valentino Orsini, Paolo e Vittorio Taviani (1963)
Alta infedeltà, episodio Gente moderna, regia di Mario Monicelli (1964)
Liolà, regia di Alessandro Blasetti (1964)
La vita agra, regia di Carlo Lizzani (1964)
La donna scimmia, regia di Marco Ferreri (1964)
Il magnifico cornuto, regia di Antonio Pietrangeli (1964)
Controsesso, episodio Il professore, regia di Marco Ferreri (1964)
I complessi, episodio Il complesso della schiava nubiana, regia di Franco Rossi (1965)
Una moglie americana, regia di Gian Luigi Polidoro (1965)
Io la conoscevo bene, regia di Antonio Pietrangeli (1965)
Oggi, domani, dopodomani, non accreditato, episodio L'uomo dei cinque palloni, regia di Marco Ferreri (1965)
Ménage all'italiana, regia di Franco Indovina (1965)
L'uomo dei cinque palloni, regia di Marco Ferreri (1965)
Marcia nuziale, regia di Marco Ferreri (1966)
Una questione d'onore, regia di Luigi Zampa (1966)
I nostri mariti, episodio Il marito di Attilia, regia di Dino Risi (1966)
Le piacevoli notti, regia di Armando Crispino e Luciano Lucignani (1966)
Il fischio al naso, regia di Ugo Tognazzi (1967)
L'harem, regia di Marco Ferreri (1967)
L'immorale, regia di Pietro Germi (1967)
Il padre di famiglia, regia di Nanni Loy (1967)
Gli altri, gli altri e... noi, regia di Maurizio Arena (1967)
Straziami ma di baci saziami, regia di Dino Risi (1968)
Barbarella, regia di Roger Vadim (1968)
Sissignore, regia di Ugo Tognazzi (1968)
La bambolona, regia di Franco Giraldi (1968)
Satyricon, regia di Gian Luigi Polidoro (1969)
Porcile, regia di Pier Paolo Pasolini (1969)
Il commissario Pepe, regia di Ettore Scola (1969)
Nell'anno del Signore, regia di Luigi Magni (1969)
Cuori solitari, regia di Franco Giraldi (1970)
Venga a prendere il caffè da noi, regia di Alberto Lattuada (1970)
Splendori e miserie di Madame Royale, regia di Vittorio Caprioli (1970)
La Califfa, regia di Alberto Bevilacqua (1970)
La supertestimone, regia di Franco Giraldi (1971)
In nome del popolo italiano, regia di Dino Risi (1971)
Stanza 17-17 palazzo delle tasse, ufficio imposte, regia di Michele Lupo (1971)
Questa specie d'amore, regia di Alberto Bevilacqua (1972)
L'udienza, regia di Marco Ferreri (1972)
Il maestro e Margherita, regia di Aleksandar Petrović (1972)
Il generale dorme in piedi, regia di Francesco Massaro (1972)
Vogliamo i colonnelli, regia di Mario Monicelli (1973)
La grande abbuffata, regia di Marco Ferreri (1973)
La proprietà non è più un furto, regia di Elio Petri (1973)
Non toccare la donna bianca, regia di Marco Ferreri (1974)
Permettete signora che ami vostra figlia?, regia di Gian Luigi Polidoro (1974)
Romanzo popolare, regia di Mario Monicelli (1974)
La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone, regia di Pupi Avati (1975)
La smagliatura, regia di Peter Fleischmann (1975)
Amici miei, regia di Mario Monicelli (1975)
L'anatra all'arancia, regia di Luciano Salce (1975)
Al piacere di rivederla, regia di Marco Leto (1976)
Telefoni bianchi, regia di Dino Risi (1976)
Cattivi pensieri, regia di Ugo Tognazzi (1976)
Signore e signori, buonanotte, regia di Luigi Comencini, Nanni Loy, Luigi Magni, Mario Monicelli ed Ettore Scola (1976)
La stanza del vescovo, regia di Dino Risi (1977)
Casotto, regia di Sergio Citti (1977)
I nuovi mostri, regia di Mario Monicelli, Dino Risi ed Ettore Scola (1977)
Il gatto, regia di Luigi Comencini (1977)
Nenè, non accreditato, regia di Salvatore Samperi (1978)
La mazzetta, regia di Sergio Corbucci (1978)
Primo amore, regia di Dino Risi (1978)
Il vizietto, regia di Édouard Molinaro (1978)
Dove vai in vacanza?, episodio Sarò tutta per te, regia di Mauro Bolognini (1978)
L'ingorgo, regia di Luigi Comencini (1979)
I viaggiatori della sera, regia di Ugo Tognazzi (1979)
La terrazza, regia di Ettore Scola (1980)
Arrivano i bersaglieri, regia di Luigi Magni (1980)
I seduttori della domenica, episodio Il carnet di Armando, regia di Dino Risi (1980)
Il vizietto II, regia di Edouard Molinaro (1980)
La tragedia di un uomo ridicolo, regia di Bernardo Bertolucci (1981)
Scusa se è poco, regia di Marco Vicario (1982)
Amici miei - Atto IIº, regia di Mario Monicelli (1982)
Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come un brigante da strada, regia di Lina Wertmüller (1983)
Il petomane, regia di Pasquale Festa Campanile (1983)
Dagobert, regia di Dino Risi (1984)
Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, regia di Mario Monicelli (1984)
Fatto su misura, regia di Francesco Laudadio (1985)
Matrimonio con vizietto (Il vizietto III), regia di Georges Lautner (1985)
Amici miei - Atto IIIº, regia di Nanni Loy (1985)
Yiddish Connection, regia di Paul Boujenah (1986)
Ultimo minuto, regia di Pupi Avati (1987)
Arrivederci e grazie, regia di Giorgio Capitani (1988)
I giorni del commissario Ambrosio, regia di Sergio Corbucci (1988)
Tolérance, regia di Pierre-Henry Salfati (1989)
La battaglia dei tre tamburi di fuoco, regia di Souheil Ben-Barka e Uchkun Nazarov (1990)
Televisione
FBI - Francesco Bertolazzi investigatore, miniserie TV in 6 episodi, regia di Ugo Tognazzi (1970)
Cuore nero episodio della miniserie TV Sogni e bisogni, regia di Sergio Citti (1985)
Qui c'est ce garçon?, miniserie TV in 2 episodi, regia di Nadine Trintignant (1987)
Una famiglia in giallo, postumo, film TV, regia di Luciano Odorisio (1991)
Regista
Il mantenuto (1961)
Il fischio al naso (1967)
Sissignore (1968)
FBI - Francesco Bertolazzi investigatore, miniserie TV in 6 episodi (1970)
Cattivi pensieri (1976)
I viaggiatori della sera (1979)
Radio
Colpo di vento, "baraonda musicale" di Italo Terzoli, regia di Adolfo Perani (domenica 17 giugno 1956) Secondo programma, ore 21.
L'imperfetto, di Giulio Scarnicci e Renzo Tarabusi, regia di Renzo Tarabusi (1956)
Vado e torno paisà, Le occasioni dell'umorismo di Gianni Bellavisata, regia di Nino Meloni (domenica 27 aprile 1958), Terzo programma.
Il dissipatore, di Ferdinand Raimund regia di Sandro Bolchi (1958)
Gran Varietà, (1966-1972)
Discografia
Singoli
1981 - Risotto amaro
Libri
Afrodite in cucina, Cava de' Tirreni, Marlin, 2005, p. 256, ISBN 88-6043-000-3.
L'abbuffone. Storie da ridere e ricette da morire, Avagliano, 2004, p. 183, ISBN 88-8309-143-4.
Note
- ^ a b G.P. Brunetta, Il cinema italiano contemporaneo: Da “La dolce vita” a “Centochiodi”, Laterza, Bari 2007 - ed. dig. 11-2015
- ^ Teche RAI Consultato il 18 agosto 2016
- ^ Treccani - Enciclopedia del Cinema (2003) - Scheda di M. d'Amico - Consultato il 18 agosto 2016
- ^ La villa di Ugo Tognazzi a Velletri apre al pubblico... e a iniziative culturali, in Il Caffè, 11 aprile 2014. URL consultato il 31 luglio 2014.
- ^ Ugo e il Milan, su Ugo Tognazzi Official Web Site.
- ^ Raimondo Vianello ricorda Ugo Tognazzi per il Corriere
- ^ Dalla " caduta " di Gronchi alla Scala alle " corna " di Leone anti universitari
- ^ Curiosità. Ugo Tognazzi è il capo delle Brigate Rosse
Riferimenti e bibliografie:
- Carlo Terron, «Tempo», anno XXII, n.45, 5 novembre 1960
- Sito ufficiale, su ugotognazzi.com
- (EN) Ugo Tognazzi, su Find a Grave
- Ugo Tognazzi, su Discografia nazionale della canzone italiana, Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi
- (EN) Ugo Tognazzi, su Discogs, Zink Media
- Ugo Tognazzi, su CineDataBase, Rivista del cinematografo
- (EN) Ugo Tognazzi, su Internet Movie Database, IMDb.com
- (EN) Ugo Tognazzi, su AllMovie, All Media Network
- (DE, EN) Ugo Tognazzi, su filmportal.de
- Tognazzi - L'ugoista, su La Storia siamo noi. URL consultato il 24 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 22 giugno 2013)
- Ugo Tognazzi, su RSI (archiviato dall'url originale il 3 dicembre 2011)
- Bruno P. Pieroni, 90 anni di "Italie": Appunti del decano dei giornalisti medici, 2012.
- Roberto Buffagni (a cura di), La supercazzola. Istruzioni per l'Ugo, Mondadori, ISBN 88-04-55073-2.
- Roberto Buffagni (a cura di), Un, due, tre, Mondadori, ISBN 88-04-49312-7.
- Aldo Bernardini, Ugo Tognazzi, Gremese, 1978, ISBN 88-7605-030-2.
- Andrea Jelardi, Giordano Bassetti, Queer TV, Roma, Croce, 2006.
- Andrea Pergolari, Paolo Silvestrini, Tognazzingiallo, Giulio Perrone Editore, 2010, ISBN 978-88-6004-163-0.
- Alessandro Ticozzi, Il grande abbuffone. Tra cinema e cucina con Ugo Tognazzi, SensoInverso Edizioni, 2013.
- Fabio Francione, Lorenzo Pellizzari (a cura di), Ugo Tognazzi regista, Alessandria, Edizioni Falsopiano, 2002.
- Il Radiocorriere, annate varie 1953/1980.
- "La città del cinema", AA.VV., Napoleone, Roma, 1979
- "Guida alla rivista e all'operetta" (Dino Falconi - Angelo Frattini), Casa Editrice Accademia, 1953
- "Follie del Varietà" (Stefano De Matteis, Martina Lombardi, Marilea Somarè), Feltrinelli, Milano, 1980
Sintesi delle notizie estrapolate dagli archivi storici dei seguenti quotidiani e periodici:
- vice, «Gazzetta del Popolo», 21 dicembre 1954
- «Epoca», 1956 - Recensione della rivista con Tognazzi e Vianello Campione senza volere
- «Epoca», 1960
- Carlo Terron, «Tempo», anno XXII, n.45, 5 novembre 1960
- «Tempo», anno XXVII, n.6, 10 febbraio 1965
- «Noi donne», anno XXIII, 2 novembre 1968
- «Radiocorriere TV», 1969
- e. b., «Radiocorriere TV», 25 aprile 1970
- [r. cri.], «La Stampa», 28 ottobre 1990
- Mino Monicelli, «Radiocorriere TV», 17 novembre 1990
- «L'Unità», 28-29 ottobre 1991