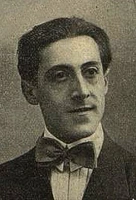Gustavo De Marco, l’ispiratore di Totò – Vita e arte

Il comico-zumpo che saltò oltre il suo tempo - La carriera di Gustavo De Marco
Ah, Gustavo De Marco (Napoli, 1883 – Napoli, 1944), un nome che oggi evoca forse qualche vago profumo di palcoscenico impolverato, ma che agli inizi del Novecento era sinonimo di risate a crepapelle, mimica forsennata e una capacità di contorcersi come un polpo epilettico sotto stimolazione ritmica. Signore e signori, preparatevi a un tuffo nel teatro di varietà, in quell’epoca gloriosamente kitsch e sfacciatamente teatrale in cui gli uomini si chiamavano “comico-zumpo” e Totò ancora si limitava a prender appunti.
Prologo – Nato sotto il segno del sipario
Napoli, 1883. Nel ventre teatrale del San Ferdinando – non metaforicamente, ma "letteralmente" nei camerini – si racconta che fu concepito Gustavo De Marco. Figlio di due attori, Rodolfo De Marco e Letizia Crispo, che evidentemente prendevano molto sul serio il concetto di “vivere il teatro”, Gustavo non aveva scampo: destinato fin da prima del parto a un’esistenza tra palchi, parrucche e paillette, nasce col talento per la risata e il corpo già pronto alla torsione.
L’adolescenza: l’inizio della leggenda
Appena adolescente, fa il suo debutto alla Fenice – e no, non quella di Venezia, ma quella partenopea, meno lagunare ma ugualmente vivace. Da lì in poi è un’escalation: Gustavo diventa il "macchiettista" più gettonato di Napoli, il re del doppio senso, il pioniere della comicità cinetica. Lo guardi e ti chiedi: "È un uomo o una molletta impazzita?" Il suo corpo diventa uno strumento musicale, una sinfonia di spasmi comici e smorfie perfettamente sincronizzate.
L’eredità comica: Totò, prendi nota
Chiunque abbia mai riso guardando Totò dovrebbe almeno una pizza e una candela a Gustavo. Fu lui il primo vero modello del principe della risata. Totò ne assorbì il linguaggio del corpo, la mimica dinoccolata, l’arte del nonsense mimato, e pure quel certo modo di scivolare sul palco come se avesse le molle sotto i piedi. Anche Nino Taranto, altro monumento della napoletanità comica, prese appunti. Insomma, Gustavo non fu solo un attore: fu un virus benevolo che contagiò generazioni di comici.
L’invenzione dell’"uomo-marionetta" – e l'antesignano del flashmob
Gustavo non si limitava a raccontare barzellette. No. Lui creava "personaggi viventi", vere e proprie caricature danzanti che si muovevano a ritmo di piatti e grancasse. Il suo "numero del tamburo" era leggendario: chiedeva all’orchestra “Dammi un colpo!”, riceveva una percussione, e BAM – un arto partiva per conto proprio. Altro colpo, altra contorsione. Sembrava che il tamburo fosse collegato direttamente ai suoi nervi.
A questo punto non si capiva se stesse recitando o subendo un esorcismo funky, ma il pubblico impazziva. Ogni performance era un’orgia di movimento, suono e mimica, con finali che potevano mettere in crisi un ginnasta olimpico per precisione e tempismo.
Gli studi e i maestri – la scuola del “diventa una molla”
Dietro tanta follia, c’era una formazione ferrea: Gustavo studiò con Giovanni Mongelluzzo e il leggendario "Marchetiello", imparando l’arte dell’imitazione, della danza sincopata, e dello sbattere piatti come un cuoco nervoso. Ma fu Leopoldo Fregoli, maestro delle trasformazioni lampo, a dare il tocco finale: Gustavo imparò da lui a cambiarsi d’abito più velocemente di quanto uno spettatore medio riuscisse a dire “ma che sta succedendo?!”.
Il “Bel Ciccillo” – la macchietta immortale
Tra le sue creazioni più famose, quella del "bel Ciccillo" – un personaggio-tipo del tempo, vanesio, sciupafemmine, parodico fino all’assurdo. Un cliché vivente, ma reso immortale da Gustavo con un misto di gestualità esasperata e mimica facciale che pareva avere vita propria. Questo personaggio fu poi riciclato, raffinato e rispolverato da Totò e compagnia bella, dimostrando che un’idea brillante, anche se caricaturale, può vivere ben oltre il suo creatore.
Il gran finale – più che una recita, una danza acrobatica
Ma il vero marchio di fabbrica di De Marco erano i "finali". Non parliamo di battute ad effetto o inchini teatrali. No. I suoi finali erano coreografie frenetiche e perfettamente orchestrate, tra smorfie, salti, sbattimenti di piatti e movimenti da elastico umano. Quando Gustavo chiudeva un numero, non si capiva se applaudire, chiamare il medico o fondare un culto. Eppure, tutti ne volevano ancora.
Epilogo – Il silenzio dopo il ruggito
Gustavo De Marco morì nel 1944, sempre a Napoli, chiudendo il cerchio in quella città che lo aveva visto nascere, crescere e contorcersi fino all’ultimo respiro scenico. Lasciò dietro di sé una scia di risate, un’eredità di comicità fisica e una quantità indecente di imitatori – alcuni eccellenti, altri decisamente meno. Non ha lasciato film (il cinema comico stava appena cominciando a capire come inquadrare i matti come lui), ma il suo spirito aleggia ancora oggi tra le smorfie di un cabarettista e i movimenti spezzati di un clown moderno.
In conclusione, Gustavo De Marco fu un monumento all’arte del corpo, al potere della mimica e alla capacità di trasformare il palcoscenico in una festa visiva. Se oggi ridiamo guardando una gag ben fatta, un mimo geniale o Totò che si contorce come un verme felice, è anche grazie a lui – il comico-zumpo, l’uomo-marionetta, il Bel Ciccillo originale. Un uomo che prese il teatro e lo piegò – letteralmente – a modo suo.
[...] Così c’erano sempre per me applausi a non finire. Ma che erano, quelli destinati a me, in confronto agli applausi che riscuoteva Gustavo De Marco? Io lo conobbi a Roma, all'Acquario. Ero uno del pubblico e mi piacque tanto che divenni un suo tifoso, cominciai ad imitarlo. Ho cominciato la carriera proprio imitando quel comico. Perciò non ho frequentato nessuna accademia, nessuna scuola mi ha avuto come discepolo. D’altra parte sarei stato un cattivo scolaro: ho sempre amato crearmi le «mosse» da me. [...] Lo so che dico due cose che sembrano contrarie fra loro. Ma ai capocomici io dovevo presentarmi con qualcosa che già in partenza piacesse al pubblico. E il pubblico allora amava De Marco: col ripetere o imitare un suo numero, il successo era assicurato.. Aggiungo questo, perché qualcuno non possa dire che io non sapevo fare qualcosa di personale: quale giovane attore non imita, nei primi suoi anni di attività, questo o quell’altro suo collega che più gli piace? tutto consiste nel non restare ancorati all’imitazione. Ed io volli e seppi uscire dalla imitazione di De Marco e costruire un «tipo» di comico che col passare del tempo divenne solo mio e che servì al pubblico per identificarmi. Non è vero, perciò, come hanno scritto alcuni critici, che io fino al ’40 ho ricalcato Gustavo De Marco, facendo la marionetta disarticolata. Nel ’25, quando ero il «numero uno» alla Sala Umberto, già le macchiette erano «mie», nel senso che rivestivo con la mia comicità i fatti che vedevo andando per strada.
Antonio de Curtis
Le “periodiche” erano dei trattenimenti che si tenevano nelle famiglie di Napoli, alla domenica. Si ricevevano gli amici, i parenti, e allora si chiamava un’orchestrina con qualche macchiettista; cosi che si ballava, si cantava e si facevano macchiette. Io partecipavo con i miei amici e ricordo che le domande per avermi non mancavano mai, perché si era sparsa la voce che io facevo “ridere assai”. Cosi c’erano sempre applausi a non finire. Ma che erano quelli destinati a me in confronto agli applausi che riscuoteva Gustavo De Marco? Io lo conobbi a Roma, all’Acquario. Ero uno del pubblico, e mi piacque tanto che divenni un suo tifoso, cominciai ad imitarlo. Perciò non ho frequentato nessuna accademia, nessuna scuola mi ha avuto come discepolo.
D'altra parte sarei stato un cattivo scolaro: ho sempre amato crearmi le “mosse” da me. Lo so che dico due cose che sembrano contrarie fra loro. Ma ai capocomici io dovevo presentarmi con qualcosa che già in partenza piacesse al pubblico, e il pubblico allora amava De Marco; col ripetere o imitare il suo numero il successo era già assicurato. Aggiungo questo perché qualcuno non possa dire che io non sapevo fare qualcosa di personale: quale giovane attore non imita nei suoi primi anni di attività questo o quell’altro suo collega che più gli piace? Tutto consiste nel non restare ancorati all’imitazione. E io volli e seppi uscire dall’imitazione di De Marco e costruire un “tipo” di comico che col passare del tempo divenne solo mio, e che servi al pubblico per identificarmi. Non è vero, perciò, come hanno scritto alcuni critici, che io fino al '40 ricalcavo Gustavo De Marco, facendo la “marionetta disarticolata”. Nel '25, quando ero il “numero uno” alla Sala Umberto, già le macchiette erano “mie”, nel senso che rivestivo con la mia comicità i fatti che vedevo per strada.
Antonio de Curtis
L’eredità artistica e l’influenza su Totò
Ma chi era questo Gustavo De Marco, questo comico che Totò, fin dall’adolescenza, aveva come modello e come ispiratore? Sulla scia dei cento e cento uomini di gomma, uomini di legno, uomini di ferro, uomini serpenti, uomini coccodrilli, uomini leoni e così via calati a Napoli da tutta Europa sul finire dell’Ottocento, in coincidenza con gli splendori del «Salone Margherita» e degli altri caffè-concerto, nella città partenopea avevano continuato a prosperare fantasisti indigeni dalle più svariate risorse e dai più strani atteggiamenti. Uno di questi, sicuramente il più celebre fra quelli di estrazione locale, era appunto Gustavo De Marco, detto l’uomo di caucciù.
Figlio d’arte per eccellenza, il De Marco era nato, esattamente nel pomeriggio del 24 novembre 1883, in un camerino di quel «Teatro San Ferdinando» che aveva visto i plebei trionfi di don Federico Stella. Si rappresentava, quel giorno, il drammone «I due sergenti» in cui, fra gli altri, l’attore Rodolfo De Marco sosteneva il ruolo di Gustavo, aspirante amoroso, e in cui sua moglie Letizia Crispo interpretava la parte dell’attrice giovane. La signora Letizia, incinta di nove mesi, nel momento in cui si alzò il sipario, lanciò, colta dalle doglie del parto, un altissimo urlo e andò a gettarsi a terra nel camerino, mentre il suo posto sul palcoscenico veniva preso da una ragazza di utilité. Fra il primo e il secondo atto di «I due sergenti», vide la luce un bimbo al quale il padre, in riferimento al personaggio che stava interpretando, impose il nome di Gustavo.
Poco più che ragazzino, Gustavo De Marco esordì alla «Fenice», quindi si specializzò in dizioni di macchiette e in caratterizzazioni di marionette disarticolate, formando anche, successivamente, compagnia con Salvatore Catterò, Giovanni Mongelluzzo e Marchetiello. Le macchiette «Paraguay» e «Il bel Ciccillo» erano i suoi cavalli di battaglia; inoltre su frenetiche musiche pronunciava incomprensibili e lunghissimi scioglilingua che gli fornivano il pretesto per prodursi in salterelli, contorsioni degli arri e movimenti del collo. Il pubblico, di ciò che lui diceva, non capiva nulla, ma si divertiva moltissimo assistendo a quelle esercitazioni clownistiche.
Per quel che riguarda la musica, poi, Gustavo De Marco aveva operato, in un’epoca in cui il jazz ancora non era comparso in Italia, una vera e propria rivoluzione, dando la preminenza, fra i vari strumenti che componevano l’orchestra, alla batteria. Ritto sul palcoscenico, De Marco si rivolgeva al direttore d’orchestra; gli diceva: «dammi un colpo», e al ritmo del tamburo compiva un imprevedibile movimento; «dammi un altro colpo», e via un’altra azione.
Totò aveva sì e no quattordici anni quando, al teatro «Trianon», assistette per la prima volta a uno spettacolo di Gustavo De Marco. Ne rimase letteralmente entusiasmato. Volle recarsi dietro il palcoscenico e andò a stringere la mano al comico.
«Scusate, maestro», gli chiese, «come avete imparato a fare quei movimenti frenetici col corpo?».
«Da solo», rispose De Marco. «Ho un grande specchio, a casa. Per ore ed ore me ne sto davanti ad esso e controllo i miei movimenti. Tutto qui».
Da quel giorno Totò prese l’abitudine, nella grande stanza di sua madre in via Santa Maria Antesaecula, di trascorrere intere giornate davanti allo specchio fino a riuscire ad imitare, quasi alla perfezione, i gesti di Gustavo De Marco. Si procurò poi i versi di «Paraguay», di «Il bel Ciccillo» e delle altre macchiette del repertorio di colui che aveva eletto a suo maestro, e li mandò a memoria. Le festicciuole «periodiche» delle famiglie della piccola borghesia di via Foria furono, come abbiamo visto, le sue prime palestre di collaudo.
L’approdo di Totò ai vari teatrini della ferrovia, non scompose affatto Gustavo De Marco. L’uomo di caucciù vantava allora non solo a Napoli ma in tutta Italia un gran numero di imitatori i quali, come del resto Totò, si erano perfino appropriati il suo repertorio; e quegli imitatori, anzi, solleticavano la sua vanità. «Dicano e facciano quel che vogliono. Il vero Gustavo De Marco sono io», rideva.
Gustavo De Marco incominciò a impensierirsi e a seriamente preoccuparsi dopo che Totò riscosse il suo formidabile successo napoletano all’«Eden». Se finora aveva sempre guardato con occhio distaccato i suoi epigoni, stavolta andò su tutte le furie.
«Il vero Totò sono io», tuonò Gustavo De Marco, capovolgendo il suo antico slogan, e minacciò rappresaglie e ritorsioni.
Una sera, infine, spinto dalla curiosità più che dalle insistenze di amici comuni, volle recarsi ad ascoltare il suo imitatore. Rimase esterrefatto. Pronunciate da Totò, le strofette «Paraguay» e «Il bel Ciccillo» assumevano un diverso sapore, come pure le contorsioni e i salterelli, eseguiti da Totò avevano un carattere totalmente nuovo.
Lealmente, Gustavo De Marco volle andare a complimentarsi col giovane.
«Bravo», gli disse. «Sono davvero contento che i miei insegnamenti abbiano dato questi frutti».
Fu quello, un modo di passargli idealmente uno scettro: nelle mani di Totò funzionò a meraviglia, molto meglio che non in quelle di colui che, prima, l’aveva impugnato. E del resto Totò, da parte sua, conservò sempre una grande ammirazione per Gustavo De Marco continuando a considerarlo il suo maestro e il suo ispiratore. «A De Marco», diceva Totò per modestia, «gli è stato di nocumento la perfetta perpendicolarità del suo naso; se avesse disposto anche lui di una narice traviata, avrebbe avuto fortuna quanto me».
Vittorio Paliotti ("Totò, principe del sorriso" - Fausto Fiorentino Ed., 1977)

Lo sketch interpretato da De Marco "Il bel Ciccillo", riproposto da Totò nel film "Yvonne la nuit" di Giuseppe Amato nel 1949.
Il mio primo incontro con lui [Totò] risale nientemeno che al 1918 o ’19. [...] Fui attratto da un manifesto che diceva così: Questa sera (a caratteri grandi) il comm. Gustavo De Marco (e sotto, a caratteri piccolissimi) imitato da Totò. [...] Gustavo De Marco, macchiettista, contorsionista, trasformista e « Marionetta vivente ». Questa ultima qualità gli proveniva dal fatto che sapeva imitare alla perfezione i movimenti dei « pupi ». [...] Ad un certo punto pareva che si snodasse nelle ossa e nelle membra, fino ad assumere atteggiamenti « marionettistici », così paradossali da suscitare nel pubblico i più clamorosi consensi. Ad un determinato momento della sua esibizione, quando il ritmo si faceva più frenetico che mai, qualcuno dalla platea o dal loggione, gli gridava: « Asso ‘e spade... » (asso di spade). Bene, De Marco si fermava di colpo in tutta la persona assumendo improvvisamente, per quanto possibile, la figura geometrica della carta « asso di spade » che fa parte del « mazzo » di carte da gioco napoletane. Progressivamente, poi, si metteva a girare su se stesso fino a raggiungere un ritmo vertiginoso, tanto da sembrare una trottola.
Peppino De Filippo
Conobbi Totò quando cominciava a lavorare nei varietà periferici di Napoli, piccoli teatrini sgangherati. [...] Faceva l’imitazione di un artista che si chiamava Gustavo De Marco [...]. Ricordo ancora dei manifesti per le strade col suo nome scritto grande, anzi grandissimo, e sotto, tra parentesi e in lettere piccolissime: ‘imitato da Totò’. Il fatto è che la stella di De Marco era ormai in declino e sulla sua scia sorgeva invece questo guaglione.
Peppino De Filippo
Pure,in questo nuovo genere, che da qualche anno invade il cafè chantant, genere che io non amo né incoraggio, quanta grazia, quanto brio, quanta comicità trasfonde Gustavo De Marco; temperamento sensibile di artista che a ben altri cimenti potrebbe provarsi e che su più spaziosa ribalta vorrei potere ammirare.
E' destino del mio paese questo !... Le migliori energie vanno disperse e la lotta per la vita sottrae alle buone battaglie l soldati su cui potrebbe farsi affidamento.
Amico mio, se questa è la tua via percorrila ancora con fortuna e che l'arte ed il galantomìsmo di Rodolfo De Marco siano la tua corazza e fa tua luce. lo non so che applaudirti!
Libero Bovio, settembre 1909
Totò e De Marco: così la stampa dell'epoca
1916: Totò ancora diciottenne viene definito "degno emulo di Gustavo De Marco" (Cafè Chantant», a. XX, n.9, 11 maggio 1916)

«Il Café-Chantant», 12 gennaio 1920
1922. Viene annunciato quel numero di Totò, imitatore di De Marco di cui abbiamo già riferito e l’anno successivo, in modo ancora più esplicito, si legge l’annuncio di una serata romana:
Salone Elena: Gustavo De Marco, pardon; la imitazione particolare eseguita da certo Totò, e, dicono, esageratissima [...] A terminare il varietà ci apre la stabilè Compagnia De Marco [«nfrù»] sempre eclatante, sempre applauditissima.
La definizione di “imitatore” sparisce presto da manifesti e recensioni, non perché il pubblico nel frattempo si dimentichi dell’originale ma perché il numero, la macchietta, l’esibizione inizialmente ispirata a Gustavo De Marco sarà talmente personalizzata dal suo discepolo da divenire una creazione autonoma.
Io, prima di tutto, sono comico parodista da circa dieci anni, e cioè fin da tempo avanti che Petrolini ritornasse dalla sua prima tournée americana; a meno che i miei salti, i miei sischi, i miei... rumorosi annessi e connessi nell’eseguire una macchietta il pubblico e gli intelligenti non debbano chiamarli imitazione. E se al nome di parodista volli prendere quello di eccentrico (questo pure non l’ho registrato ancora) fu perché le mie acrobazie mi parvero più eccentricità che parodie e perché (non voglio sputare un paradosso) ritenevo già che tutta la nostra opera di artisti varietisti era una vera... parodia della vita e dell’arte. Quindi ... con buona pace dei colleghi sobillatori se il collega (anch’io sono maestà e ne ho tutelato il diritto in America) Petrolini ha indirizzata la sua lettera contro i petrolineggiatori ovvero i parodisti, certamente non lo aveva con me. E se alcuni titoli di mia interpretazione possono far credere per tale, eccomi a dare... le prove del contrario. Io eseguo fin dal 1911 un Otello vendutomi da Mimi Albin, regolarmente registrato, e presentato al colto pubblico dei più importanti Varietà italiani, riproducendo la scena della morte di Desdemona e termina con la tarantella d’ ’e vase. Prego sapermi dire se l’altro Otello è padre o figlio del mio o ... spirito santo di... chiaroveggenza! [...] Che dovrei poi dire della Traviata? Che della Messalina, con la quale fin dall’anno 1910 io trescavo, con un certo successo, coi sempre nuovi desideri del pubblico senza però tradire, con i miei zompi, la loro fede di nascita e istigare l’esclusività d’interpretazione tra le colleghe della Subburra o dei Boulevards parisiens? [...] Ma lasciamo le satire (questa non l’ho registrata) e ritorniamo a noi come si conviene a Re, Imperatori e Padreterni alleati od intesi come meglio si vuole, e da artisti della vecchia guardia e cioè di quella che divenne generale dopo aver mangiato alla... gavetta e che, appunto alla comicità di maestri come Maldacea e Villani prese la sua via diritta nell’arte, dividendosi quando, per le mutate condizioni del gusto del pubblico occorse costituirsi un io. Io che è la prova della differenza fra me e Petrolini poiché mentre questi prendeva la Via Parodia (veramente lui dice resta Parodia ...ti è piaciata?) il sottoscritto infilava Via dello Zompo per raggiungere: il primo il regno della risa ed il secondo l’impero... dei cieli [...]
Gustavo De Marco

«Cafè Chantant», 1906
Ad essere sinceri, anche diversi comici del moderno varietà derivano dal De Marco; il più noto fra tutti, che più ebbe fortuna, e trovate nell'ampliare il “tipo” di altre ingegnosità elettrizzanti, resta ancora Totò. Gustavo, però, esordi come piccolo attore alla Fenice. Poi, quel che spesso abbiamo visto accadere ai suoi colleghi, accadde anche a lui. Tempo fa, nei teatri minori, dopo la commediola, seguivano alcuni numeri canzonettistici; e quella volta alla Fenice mancò il noto macchiettista Ciccillo Mazzola, tanto simpatico al pubblico della Napoli d’altri tempi.
“Come si fa? Come non si fa?”
“Gustà, tu saie paricchi mmacchiette: vuo’ asci a carità stasera?”
Gustavo spiritò i suoi occhietti di topo, affilò ancora di più il naso e il mento pronunziato, allungò il collo secco e di già non breve, e disse:
“Eh”.
E mi disse anche che fece un fanatismo (parola all’ordine del giorno, nell’ambiente). Poi aggiunse, a complemento delle informazioni, che nell’estate del 1909, sulla loggetta d’uno stabilimento di bagni a Sorrento, egli pensava: “Ma come! Petrolini, Maldacea, Viviani, Cuttica sono cosi personali, e solamente io devo restare ancora nella tradizione?!... No, ce sta poco ’a fa: aggia ammentà nu genere pur'i... Debbo creare un tipo. I’ m’aggia metter’ ’e case e de puteca... E cosi mi piazzai innanzi ad uno specchio matina e ssera... e a bòtt’ ’e e sbattere ’e piere, nterra, ’e smorfie e sturzellamiente... Cicci, sa’ che ssaccio? 'Aggio fatto ’a bòtta. Oggi sono un maestro.”
Francesco Cangiullo
Le “periodiche” erano dei trattenimenti che si tenevano nelle famiglie di Napoli, alla domenica. Si ricevevano gli amici, i parenti, e allora si chiamava un’orchestrina con qualche macchiettista; cosi che si ballava, si cantava e si facevano macchiette. Io partecipavo con i miei amici e ricordo che le domande per avermi non mancavano mai, perché si era sparsa la voce che io facevo “ridere assai”. Cosi c’erano sempre applausi a non finire. Ma che erano quelli destinati a me in confronto agli applausi che riscuoteva Gustavo De Marco? Io lo conobbi a Roma, all’Acquario. Ero uno del pubblico, e mi piacque tanto che divenni un suo tifoso, cominciai ad imitarlo. Perciò non ho frequentato nessuna accademia, nessuna scuola mi ha avuto come discepolo. D'altra parte sarei stato un cattivo scolaro: ho sempre amato crearmi le “mosse” da me. Lo so che dico due cose che sembrano contrarie fra loro. Ma ai capocomici io dovevo presentarmi con qualcosa che già in partenza piacesse al pubblico, e il pubblico allora amava De Marco; col ripetere o imitare il suo numero il successo era già assicurato. Aggiungo questo perché qualcuno non possa dire che io non sapevo fare qualcosa di personale: quale giovane attore non imita nei suoi primi anni di attività questo o quell’altro suo collega che più gli piace? Tutto consiste nel non restare ancorati all’imitazione. E io volli e seppi uscire dall’imitazione di De Marco e costruire un “tipo” di comico che col passare del tempo divenne solo mio, e che servi al pubblico per identificarmi. Non è vero, perciò, come hanno scritto alcuni critici, che io fino al '40 ricalcavo Gustavo De Marco, facendo la “marionetta disarticolata”. Nel '25, quando ero il “numero uno” alla Sala Umberto, già le macchiette erano “mie”, nel senso che rivestivo con la mia comicità i fatti che vedevo per strada.
Antonio de Curtis
🎭 Conclusioni
La figura di Gustavo De Marco, attore comico napoletano, rappresenta un capitolo fondamentale del teatro comico napoletano e del mondo del varietà e cafè-chantant. Considerato l’ispiratore di Totò, esercitò una profonda influenza su Totò grazie alla sua mimica e comicità, elementi che il Principe seppe trasformare in uno stile unico e inconfondibile. Ricordare Gustavo De Marco significa riscoprire uno dei maestri di Totò e comprendere come l’incontro tra due generazioni abbia arricchito la tradizione della comicità italiana.
Riferimenti e bibliografie:
- "Totò, principe del sorriso", Vittorio Paliotti - Fausto Fiorentino Ed., 1977
- "Totò attore", Ennio Bispuri - Gremese, 2010
- "Totalmente Totò, vita e opere di un comico assoluto" (Alberto Anile), Cineteca di Bologna, 2017
- "Totò, l'uomo e la maschera" (Franca Faldini - Goffredo Fori) - Feltrinelli, 1977
- "Vita di Totò" Giancarlo Governi, (Supplemento al numero di Gennaio 1992 di Totò Cine & Tv) Milano, Nuova Fonit Cetra.
- "Demarcheide", Gustavo De Marco in "Il Cafè Chantant", 1914 a.XVIII, 26 luglio 1914
- "Totò" (Orio Caldiron) - Gremese , 1983
- Ettore Mo, In tandem con Peppino, “Corriere della Sera”, 15 aprile 1977
- Francesco Cangiullo in "Le novelle del varietà", Richter & c., Napoli, 1938
- Angelo L. Lucano, "Serio discorso d'un attore comico", «Rivista del Cinematografo», n.1, 1 gennaio 1966
- "Follie del Varietà" (Stefano De Matteis, Martina Lombardi, Marilea Somarè), Feltrinelli, Milano, 1980