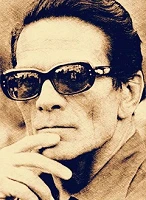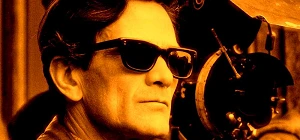Approfondimenti e rassegna stampa - Pierpaolo Pasolini

La rassegna stampa
Pierpaolo Pasolini, rassegna stampa
Totò e Pier Paolo Pasolini – Il legame inatteso nel cinema del dopoguerra
Totò al circo – Monsieur Cournot e l’aquila (L’aigle)
Totò sul set di Uccellacci e uccellini (1966): l’intervista di Giacomo Gambetti
La morale delle favole – Totò, Pier Paolo Pasolini e il cinema di poesia in “Uccellacci e uccellini” («Vie Nuove», 25 novembre 1965)
Totò: caporali o aquile — ritratto amaro tra caricatura e mimica (Settimana Incom Illustrata, 12 dicembre 1965)
Il principe de Curtis odia Totò (Oggi, 13 gennaio 1966) — L’uomo contro il personaggio
Silvana Mangano come la vede Pasolini: bionda e innamorata di Totò (Tempo, 16 novembre 1966) — “Le Streghe”, antologia d’autore e un amore per Totò
Nastro d’Argento: storia del premio e i riconoscimenti legati a Totò
1965 - Intervista a Pasolini e Totò sul film “Uccellacci e uccellini”
1966 - Anteprima
1971 - Cinema 70
Pierpaolo Pasolini: ecco il mio Totò – La Repubblica, 3 agosto 1976. Un ritratto umano e poetico del suo attore “innocente”
1998 - Avvenimenti
Uccellacci e Uccellini - Galleria fotografica e Rassegna Stampa (1965): il film di Totò e Pasolini tra critica e Festival di Cannes
Ma insomma, chi è questo Pasolini?
L'addio di Pasolini alle borgate
Ecco Pasolini, il ricco "maledetto"
Totò, Pasolini e una Luna prostituta – «L'Unità», 20 luglio 2007 – I film pasoliniani che rivelano il Totò “padre-maestro”
Pasolini all'inferno
Pierpaolo Pasolini: «vivo il mio momento gaio»
La rivincita di Totò – «Il Messaggero», 6 gennaio 1974: quando la critica riscoprì il genio dimenticato

Con "Una vita violenta", il romanzo pubblicato recentemente da Garzanti, P. P. Pasolini riconferma la novità del suo ingegno
Con questo nuovo romanzo: Una vita violenta, ediz. Garzanti 1959, Pier Paolo Pasolini riconferma, se ce ne fosse bisogno, splendidamente, la novità del suo ingegno (dei primi d’oggi), a distanza di quattr’anni da Ragazzi di vita. Ancora, dunque, una storia d’ambiente romano, di fondo di popolo, vivificato da una parlata che, per esser più vicina al vero, punta sul dialetto, se ne fa una forza. Di qui la difficoltà d’intendere appieno, con ogni suo proprio agio, per il comune dei lettori. Scriveva Pasolini, presentando Ragazzi di vita: «Crediamo che non ci sia lettore che, pur imbattendosi per la prima volta in qualcuna delle parole del gergo della malavita o della plebe romana, non ne afferri o non ne intuisca il significato: tuttavia, più per scrupolo, e curiosità, che per effettiva utilità, elenchiamo qui un certo numero di parole dialettali e gergali con la loro traduzione». Come dirla! Quanto a noi (e beati gli altri che ne sanno di più...), assai volte ci è accaduto, leggendo oggi Una vita violenta, come, or sono quattr’anni, Ragazzi di vita, di ricorrere invano al "glossarietto"; eppure abbiamo una certa pratica, aiutati dal fatto che non siamo del Piemonte o della Venezia. Allora, per rimediare alle nostre deficienze, cerca nel Dizionario moderno del Panzini, edizione ultima, con l'appendice del Migliorini; e non bastando, chè non poteva bastare, ricorri al Vocabolario romanesco del Chiappini, con le giunte del Migliorini (sempre lui, che sia benedetto!). Ma qui, gli scrupoli, spesso, di non aver voluto dire pane al pane e vino al vino, a certi punti scabrosi. Insomma, una fatica grossa (e quant’era meglio che l’autore, di sua mano, d procurasse le scorciatoie!).
Anche qui come, e forse più, che in Ragazzi di vita, il dialetto, ora è una tinta appena accentuata del comune linguaggio (direi, semplicemente, d’un tono più forte), ora è carico, che quasi ne gronda, d’un sapore nuovo (acceso, ricco: espressionismo, più che espressione). Fatto più importante: che il romanzo s’arricchisce d'un'espe-rienza di gran valore e novità, com’è il libro de Le ceneri di Gramsci, dove, a un certo luogo (dico, particolarmente, del Pianto della scavatrice), oltre il mutevole variare del canto, c’è un motivarsi, punto per punto, di sillaba in sillaba, come nell’impetuoso inventare del ”gregoriano” (con un arricchimento d'invenzioni, un intarsio novissimo, oltre, si direbbe, la volontà stessa dell’autore, e oltre le regole). Dedurrei di qui, come da scaturigine segreta, il comporre nuovo, con una forte carica, di certe parti e composizioni e rappresentazioni in grande del nuovo romanzo (un acquisto inedito, direi); e motiverei per gradi quest’acquisto, partendo da certe "impressioni", o pure "sperimenti”, fino a toccare poi il massimo di resa, l’acuto sopr’acuto. "Tommaso, Lello, il Zucabbo e gli altri ragazzini che abitavano nel villaggetto di baracche sulla Via dei Monti di Pietralata, come sempre dopo mangiato, arrivarono davanti alla scuola almeno una mezzoretta prima"; e subito questa scena viva, chiassosa: «"Che, è arrivato er maestro, a Carlè?” chiese a un mignoletto che gli stava appresso. "Che nna so!" rispose quello alzando le spalle. "Chi ce sta oggi, a ffà ’e pulizzie?" chiese dopo un po’ Tommasino, ch’era stato assente in quei due tre giorni, perchè aveva avuto la febbre. "Lello, mi sa", fece Carletto. "Aòh, me fai fumà?” chiese poi, rivoltandosi di scatto, incazzato, a un altro, che stava fumando lì accanto accucciato s’un tufo». E’ l'inizio del romanzo, quel che si dice una "macchia", per adoperare un termine pittorico, su cui cresce poi e s’organizza una serie di varianti ricche e complesse. Le corrisponderà un intreccio fitto di cose vive, mosse, parlanti; mezzo narrativa, insomma, mezzo teatro, con uno scambio vivace dei due modi, che direi complementari, col conseguente acquisto di varietà e di movimento, e un che di chiassoso.
Ma chi vuol cogliere, tutt’in una volta, il segno più alto del libro, il punto di forza, veda al capitolo terzo della "Parte seconda" che s’intitola: Che cercava Tommaso? Un contrappunto vivo d'invenzioni e di poetici modi, con qualcosa, propriamente, di ricco e strano; e si chiude in modo degno: "Coi grugni sporchi sotto i ciuffi, si tenevano abbracciati, parlando tutti smaniosi, senza guardare in faccia nessuno. Alcuni parlavano, parlavano, altri tacevano ridendo. E quelle faccette, sopra i colletti zozzi a colori, alla malandrina, erano l’immagine stessa della felicità: non guardavano niente, e andavano dritti verso dove dovevano andare, come un branco di caprette, furbi e senza pensieri": donde la chiusa malinconica e stupenda: "Aaaah" sospirò Tommaso, "so* stato ricco, e no l’ho saputo!”. C'è differenza tra l’uno e l’altro esempio: quello, libero fin troppo, questo incatenato e stretto, e tutto nuovo, parlante.
Perchè, il narrare di questo libro, di questo racconto, è tutto movimento; un "parlato” fitto, complesso, arioso, montante, che ogni tratto n’è come inebriato. Si toma a quell’idea del principio, queirimpetuoso inventare del "gregoriano", quella forza espansa, ricca di moti espressi, sorgivi, e un che di tumultuante. Questo "rappresentare” fastoso è più che raccontare; ed è l’acquisizione del nuovo libro, con in mezzo, giova ripeterlo, l’esaltante esperienza de Le ceneri di Gramsci, al punto suo più alto (voglio dire il Pianto della scavatrice). Di tanto, insomma, Una vita violenta sopravanza Ragazzi di vita; su questi termini, vivi, esatti, incogniti, s’è ingrandito il suo narrare, che è, propriamente, rappresentare, a linee incrociate.
Giuseppe De Robertis, «Tempo», anno XXI, n. 31, 4 agosto 1959
«Gazzetta di Mantova», 30 giugno 1960

Fabrizio Menghini, «Il Messaggero», 8 marzo 1963
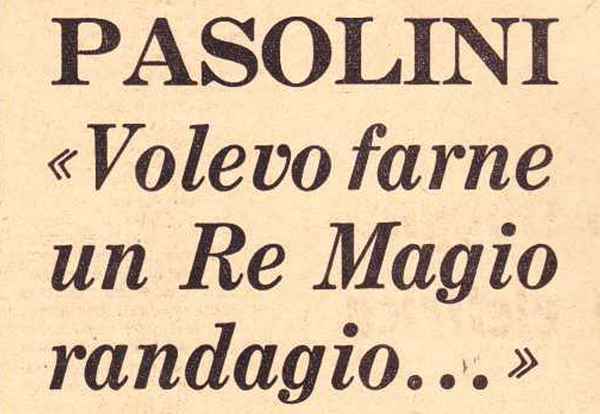
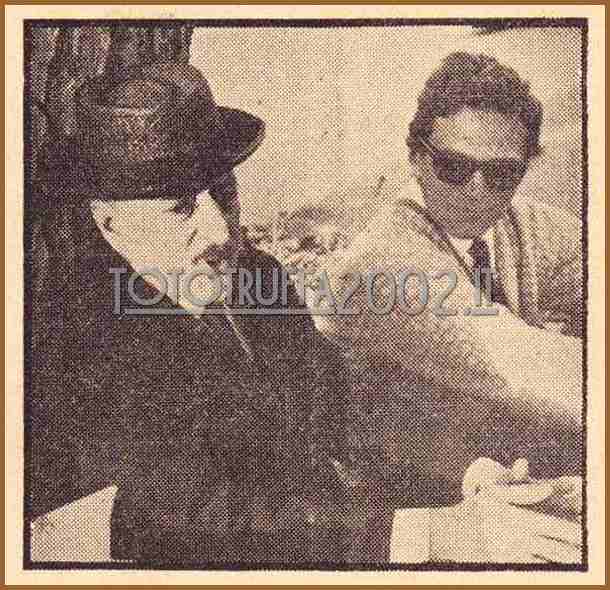
Pier Paolo Pasolini si trova attualmente in Marocco, per girare il film «Edipo re». Siamo stati noi a dargli la notizia della scomparsa di Totò. Erano le 19.30 quando lo abbiamo raggiunto, telefonicamente, a Quar Zazate. Sconvolto. Pasolini ci ha donato queste poche righe:
Spero che il lettore di Paese Sera possa immaginare lo stato d'animo in cui io mi trovo. E' assurdo che lo riesca a dire qualcosa di sensato. In questi ultimi due anni ho lavorato quasi ininterrottamente con lui; l'ultima volta l'ho visto, felice, in una serata in cui lo premiavano.
E' stato sottratto alla nostra vita, come se fosse stato rubato. Alla mia, come una parte di me stesso, quando dovevamo lavorare ancora insieme quattro o cinque episodi che dovevano formare un intero film.
lo ho già immaginato a una a una tutte le facce che egli avrebbe fatto nelle vesti del Re Mago randagio, un Re Mago arrivato in ritardo al presepio per le mille peripezie e le mille buone azioni compiute e, quando arriva davanti al presepio, ormai vuoto, muore di stenti e di stanchezza e un angelo lo prende per mano e lo porta in paradiso ballando al suono di una musica di Mozart.
Pier Paolo Pasolini, «Paese Sera», domenica 16 aprile 1967
In televisione per «Controcampo» un dibattito sulla polemica aperta da Pier Paolo Pasolini. Secondo lo scrittore-regista siamo cambiati in peggio: «Non c’è più differenza culturale apprezzabile tra un qualsiasi cittadino fascista e un qualsiasi cittadino antifascista». Chi sono gli oppositori che partecipano alla trasmissione e quali le loro argomentazioni.
Giuseppe Sibilla, «Radiocorriere TV», 19 ottobre 1974

E' stato trovato all'alba di ieri con il cranio fracassato da bastonate e il corpo schiacciato dalle ruote di un'auto - L'omicida, di 17 anni, ha confessato - La notte precedente era stato fermato sull'Alfa dello scrittore per eccesso di velocità - Scambiato, in un primo tempo, per un ladro - I due non si conoscevano - Pasolini gli ha offerto un passaggio nei pressi della stazione Termini
Roma, 2 novembre.
Pier Paolo Pasolini è stato ucciso. Lo hanno trovato all'alba in uno spiazzo di terreno a una ventina di metri da via dell'Idroscalo, una strada che da Ostia porta alla foce di Fiumara grande, dove uno dei bracci del Tevere sfocia a mare. Giuseppe Pelosi, 17 anni, che era stato fermato dai carabinieri all'una e trenta di notte, ha confessato in carcere di essere l'omicida. Per la polizia il caso non è definitivamente chiuso. Potrebbero esserci dei complici nel delitto? Viene scartato il movente politico dell'assassinio.
«Eravamo arrivati alle 6 e mezzo. Vicino casa, in mezzo alla strada — dice Alfredo Principessa, carpentiere — mia moglie ha visto un mucchio scuro a terra». Racconta Maria Teresa Lollobrigida: «Mi sono avvicinata e solo allora ho visto il corpo. Ho gridato, mi sono sentita svenire». Un uomo giace a pancia sotto, il braccio destro sotto il corpo: ha il cranio sfondato. E' in canottiera verde scuro, blue-jeans, calze e stivaletti neri. E' martoriato di ferite. Il volto è irriconoscibile. A terra c'è un anello d'oro con pietra rossa. Arriva la polizia. Le tracce di sangue portano a un Campetto di calcio. Viene trovata la sua camicia, macchiata di sangue, un giubbotto a strisce e un mazzo di chiavi. Tutta la zona, desolata, pullula di baracche abusive. Nessuno vi abita d'inverno. Ci vanno la domenica per tirare su muri e costruire casupole fatiscenti.
Nessuno ancora lo ha riconosciuto. Dal giubbotto arriva la prima indicazione: all'interno si legge, appena, il nome Pasolini. La polizia avverte Ninetta Davoli, amico fraterno del poeta-regista. Sono le 10 quando avviene il riconoscimento ufficiale. Davoli non ha dubbi: «Dio mio». Poi piange. Ecco il suo racconto: «Avevamo parlato a lungo ieri sera al ristorante. Mi aveva lasciato dicendomi che sarebbe andato a casa. Stavamo preparando un film. Era tranquillo, del tutto simile all'uomo, profondamente buono, che avevo conosciuto. Una sola frase mi aveva colpito. Aveva detto: "E' odiosa la gente. Venendo qui ho camminato a lungo a testa bassa per non vedere nessuno negli occhi"».
Sul posto arriva Alberto Moravia. E' scosso. Il cadavere di Pasolini è già in viaggio per l'obitorio. «E' orribile, orribile». Sono le sue uniche parole. Intanto le indagini hanno preso una svolta decisiva. Polizia e carabinieri collegano l'assassinio di Pasolini con l'arresto di un minorenne, Giuseppe Pelosi. Il ragazzo era stato fermato dai carabinieri a Ostia, durante un normale servizio di pattugliamento. Era a bordo di una «Gt Alfa Romeo» metallizzata: procedeva a velocità sostenuta in una strada a senso unico, contromano. Erano quasi le due di notte. Il giovane non era riuscito a dare spiegazioni, aveva balbettato poche parole a sua difesa. Il motivo dell'arresto era furto d'auto e guida senza patente. Mentre lo trasportavano al carcere minorile di Casal del Marmo aveva detto a un carabiniere: «L'anello. Mi sono perso il mio anello d'oro con un rubino. Lo devo andare a cercare». Così i due episodi si saldano. L'auto è di Pasolini. L'anello trovato accanto al cadavere dell'artista è di Giuseppe Pelosi. Il ragazzo viene messo alle strette, mentre si indaga nei suoi trascorsi. Si prende in esame l'ipotesi del delitto politico che viene però accantonata. Di fronte alle precise contestazioni del magistrato di turno, il ragazzo confessa e dà la sua versione dei fatti, drammatica nella sua cruda e atroce durezza. Qual è il motivo dell'assassinio? Secondo il Pelosi, arrivati a Ostia, Pasolini gli chiede di avere rapporti sessuali. Il giovane protesta e rifiuta. Scendono dall'auto ed è Pasolini — sempre secondo la versione del minorenne — a colpirlo con un bastone. La reazione di Giuseppe Pelosi è violenta: lo colpisce con una tavola di legno accecato dall'ira. Poi fugge con la macchina passando sul corpo della vittima. In base a questa e ad altre testimonianze la polizia ricostruisce le ultime quattro ore di vita dello scrittore.
Ore 22 di sabato, 1 novembre: Pasolini va al ristorante «Pomodoro», al quartiere San Lorenzo. Si incontra con Ninetto Davoli, la moglie e i loro due bambini.
Ore 23: Pasolini esce dal ristorante. In macchina raggiunge la zona della Stazione Termini. Si incontra con un ragazzo e lo porta a cena in un ristorante del quartiere San Paolo.
Ore 0,15 di domenica 2 novembre: c'è la testimonianza precisa di un automobilista (la squadra mobile non ne vuole fornire il nome) che riconosce Pasolini e un giovane fermi ad un distributore automatico «Total» della via Ostiense.
Ore 1,30: Giuseppe Pelosi viene arrestato dai carabinieri.
L'ora del delitto si localizza così tra luna e l'una e un quarto di notte. C'è la spiegazione difensiva del ragazzo. Si apprende che Pasolini conosceva la zona ed è quindi possibile che sia stato lui a portare il giovane alla periferia di Ostia. Resta da appurare la verità. Dalle macchie di sangue e dai segni di colluttazione sembra più plausibile che sia stato Pasolini a tentare di sfuggire all'aggressore.
Dalle indagini finora svolte non risulta traccia che al delitto abbiano partecipato più persone. Ma una domanda da porsi è precisa: Pasolini aveva un fisico atletico, giocava a calcio, era molto forte. Poteva soccombere contro un ragazzo di diciassette anni? Di Giuseppe Pelosi si conosce quasi tutto: vive a Guidonia ma è nato a Roma. Il padre fa il commesso di negozio. Ha una sorella più grande, dì diciannove anni. Aveva studiato fino alla seconda media poi si era messo a lavorare come panettiere. Aveva avuto una denuncia per furto, seguita da perdono giudiziario. Il ragazzo è alto un metro e sessantanove, riccio di capelli, bruno. Un volto come quelli cari ai racconti e ai film di Pasolini. Era un ragazzo di vita? Perché aveva accettato un passaggio in macchina da uno sconosciuto per poi rifiutare il rapporto sessuale? Pelosi non era solo? Il racconto, in verità lacunoso, lo ha fatto per proteggere altri giovani? Sono domande ancora da chiarire. L'autopsia potrà in parte rispondere. Sullo sfondo del delitto c'è l'angoscia di un uomo che, non era un mistero per nessuno, ricercava rapporti omosessuali e che, per questo, più volte aveva pagato. L'anno scorso, alle Terme di Caracalla, lo aggredirono a calci e a pugni. In altri casi era stato derìso e umiliato. Ora Pier Paolo Pasolini è stato ucciso dalla violenza che lo atterriva, proprio nell'estrema periferia della città che amava.
Fabrizio Carbone, «La Stampa», 3 novembre 1975
«Oggi sono in molti a credere che c'è bisogno di uccidere»
A colloquio con lo scrittore sei ore prima della morte. L'ultima intervista di Pier Paolo Pasolini destinata a "Tuttolibri". Con la lucidità di sempre ha parlato di cinema, di letteratura e di se stesso - "C'è in me grande contraddizione, nostalgia ma anche malessere"
Roma, 2 novembre.
Sono le quattro e un quarto di sabato pomeriggio. Sopra il citofono della palazzina di via Eufrate, all'Eur, c'è scritto «Dr. P. Pasolini». E' una strana casa, uno strano luogo per vivere, perché ha due facce. Guardo davanti e vedo, sopra quella targhetta, la palazzina confortevole, senza stile e senza gusto che è il condominio dell'Eur, il quartiere residenziale più ambito di Roma. Volto le spalle alla palazzina, e oltre la strada vedo quel vuoto strano e angoscioso che circonda Roma. Un vuoto che non è né città né campagna. Il verde sono cespugli, non alberi, passano strade che non si vedono. La campagna di Fiumicino è proprio là davanti, senza una faccia, come la periferia di Roma e i suoi desolati misteri.
Nella strada deserta incrociano due motociclisti giovani, uno in tuta azzurra e splendore di cerniere lampo, entrambi col casco e la visiera scura davanti alla faccia. I due motociclisti vanno e vengono come se facessero a gara a chi sta più in equilibrio evitando di accelerare. Con la macchina accosto due volte. Per due volte le facce nascoste dal casco non rispondono alla domanda sulla strada e sul numero. Accelerano lievemente, due ragazzi che guidano bene. Quando esco, due ore più tardi, vedo ancora la tuta blu, la moto, le gambe ferme e divaricate, lontano, in mezzo alla strada. Ma ormai è buio, è un frammento d'immagine inquadrata dai fari, mentre faccio marcia indietro, con la paura eccessiva di sbagliare, di cadere indietro nel vuoto, nel punto dove Roma finisce.
Fra i libri
Dentro, al primo piano, al fondo di una scala buia, di un pianerottolo buio (nei condomini rispettabili si risparmia la luce) c'è Pasolini. Mi aspetta, seduto di fianco, ben coperto nello stanzone gelido, un ambiente sproporzionato che nei condomini si chiama «salone di rappresentanza». Pasolini è su una poltrona, e la poltrona su una moquette che non è grande abbastanza per coprire tutto quel marmo. Accanto c'è un enorme camino spento. L'unica difesa sembrano i libri, tanti libri sul tavolo basso e per terra, come una trincea provvisoria. Davanti c'è un volumetto spagnolo («Conversaciones con P. P. Pasolini»). Lui ha in mano Sciascia, «La scomparsa di Majorana».
Nel libro spagnolo, aperto, mi pare con un gesto brusco, che ha forzato la legatura, faccio in tempo a leggere la fine di una domanda: «Tenerezza, nostalgia, violenza, avventura, solitudine, avversione, odio, a momenti, eppure anche dolcezza... Sono questi i sentimenti che le vengono dal ricordo del padre? ».
E l'inizio di una risposta: «Sì, un po' di tutto. Devo ammettere che c'è in me una grande contraddizione, la nostalgia ma anche il malessere... ». Incominciamo a parlare.
— E' bello, è bello il Majorana di Sciascia. E' bello perché ha visto il mistero ma non ce lo dice, hai capito? C'è una ragione per quella scomparsa. Ma lui sa che in questi casi un'indagine non rivela mai niente. E' un libro bello proprio perché non è una indagine ma la contemplazione di una cosa che non si potrà mai chiarire.
Pasolini abita nel suo maglione, nei suoi stivaletti, nelle ossa dure della sua faccia, nelle mani che apre e chiude inavvertitamente come per un esercizio, abita nel suo corpo ben difeso e in guardia. E' lì che bisogna cercarlo e stanarlo, e in quegli occhi sempre in guardia, nonostante l'amicizia, la dolcezza o il sorriso. Non nella casa, non negli oggetti, che si sono accumulati qui intorno, o nell'altra che sta finendo, al mare, o in quella di campagna, che dicono sembri un castello. E' circondato di oggetti che potrebbero sparire di colpo, senza toccarlo.
Unica gioia
Stando con lui si capisce che i suoi articoli, i suoi «Scritti corsari», anche nei momenti più acuti del paradosso sono assolutamente sinceri. Toccava le cose come un prestigiatore, facendo apparire quel che voleva, persuaso che non esistono. Qualcuno doveva sapere che solo colpendolo al corpo, con tutta la violenza possibile, si poteva finirlo. Il cervello ottuso che ha risposto all'impulso di un folle mandato (maturato dentro o fuori di lui? Non ce lo diranno mai) doveva avere percepito la forza di quella sfida.
— Ho la vita di un gatto — diceva Pasolini. E allora rideva offrendosi al rischio di vivere con una specie di gioia che forse era la sua unica gioia. Temeva la protezione degli oggetti, temeva la protezione della ideologia, persino la protezione dei pensieri saggi, del buon senso. Rompeva ogni volta l'involucro per sentire in faccia solitudine e rischio, due cose che lo riguardavano profondamente. Tutto, detto o non detto, sembrava esprimere in lui questa idea fissa: tanto non c'è niente da fare, non la scampi. E allora perché proteggersi, perché adattarsi ai camminamenti delle cose mezze fatte, mezze dette, mezze accettate? Giocava col privilegio (del cinema, del successo) come il mago Houdini con catene sempre più dure, bauli sempre più fondi e rischi sempre più «inevitabili». In questo gioco terribile diventava profeta. Uno strano profeta, agile, in guardia, proprio perché disarmato e separato da ogni forma di protezione e alleanze.
— Hai fatto il film sulla Repubblica di Salò proprio prima del delitto del Circeo.
— Sì, e adesso mi fa impressione guardarlo, il mio film prima ci pensi come a una intuizione, che per quanto terribile ha la pace e l'armonia delle cose pensate. Poi ci lavori, e il cinema è tecnica, scena dopo scena, un'inquadratura dopo l'altra, e questo lavoro è come una enorme routine, dilata i tempi, ti macina nei dettagli, sei alla catena di montaggio del tuo stesso prodotto. Poi guardi, vedi quello che è successo. Quello che è successo è "anche" quello che luti fatto o voluto. Ma c'è qualcosa che vedi per la prima volta. Io ho sentito disagio e paura.
— Hai fatto il film pensando a "quella" Salò, alla tetra storia di allora, o i tuoi incubi su questa violenza sono in avanti, qualcosa che viene dopo? — Ma non vedi che gli assassini del Circeo cercavano disperatamente una divisa, un travestimento? Che avrebbero dato chissà che cosa per avere in mano un ordine, una ragione, un'idea che desse un senso al loro massacro? Non lo sapevano, ma erano già travestiti. Travestiti da nuovi assassini.
Ultima sera
Pasolini parlava, verso le cinque, mentre veniva sera, tirandosi sempre più dentro di sé, con gli occhi sempre più lucidi, con quella specie di disperata felicità di chi sa di più perché viene fra la parte in luce del mondo — la razionalità, l'immaginare, il creare, il dibattere, le polemiche, i confronti dell'intelligenza — e la zona tetra in cui si vede da vicino, senza le maschere, una faccia vera e tremenda. Pasolini si era dedicato, come a una ossessione, alla descrizione di quella faccia. La vedeva venire vicina. Era, in modo misterioso ma vero, l'identikit del suo o dei suoi assassini.
Pasolini parlava, rispondendo attento, puntiglioso, alle domande di una lunga intervista, per Tuttolibri. E intanto sembrava constatare in sé nel suo essere vivo, testimone disperato di cose che sapeva da solo, l'unica garanzia, l'unico segno.
— Io dico che le vostre obiezioni sono sbagliate perché non vi siete accorti che dai codici della malavita, come da quelli che chiamate « politica » è ormai esclusa l'umanità. Oggi «si deve uccidere», voi non avete idea in quanti siano a crederlo. La morte è un comportamento di massa. Però non era triste. Non lo angosciava quel panorama vuoto della città che finisce davanti alle sue finestre, nei cespugli di Fiumicino. Pasolini si alza, mette da parte con cura le pagine che abbiamo scritto. E va a farsi uccidere. Mancavano sei ore e trentacinque minuti al massacro.
Furio Colombo, «La Stampa», 3 novembre 1975


Roma, 2 novembre.
Alle 12,45 il furgone funerario del comune ha varcato i cancelli dell'obitorio di Roma. Il corpo straziato di Pier Paolo Pasolini è stato subito chiuso in una cella frigorifera: nessuno accompagnava la salma, nessuno del personale dell'Istituto di medicina legale era oggi in servizio. Erano passate circa 12 ore dal momento della morte: per tutto questo tempo lo scrittore è rimasto supino là dove era caduto, fra via dell'Idroscalo e il mare di Ostia, in un campo aperto al vento e devastato dalla sabbia, dalle costruzioni abusive, dai rifiuti di plastica, dai cani randagi e affamati.

E' lo scenario di tanti suoi racconti, letterari e cinematografici. Si lascia la strada asfaltata, stretta e tortuosa, per inoltrarsi in un sentiero sterrato. A distanza — come un muro compatto di cemento — corrono le case nuove di Ostia. Il mare è a circa cinquanta metri, una striscia grigiastra che lambisce una spiaggia praticamente inesistente, di continuo mangiata dalle mareggiate. Al centro di questa terra di nessuno — delimitata in un altro lato dalla fiumara, uno dei bracci del Tevere — s'erge un rudere cadente, la torre di San Michele. Tutt'intorno, baracche, case di lamiera, muri di tufo, recinzioni che crollano, cancelletti chiusi con catenacci, palizzate che proteggono altri «Lavori in corso», patetiche scritte («Villa Serena»), cartelli che contrassegnano fazzoletti di terra (.«Lotto n...»), una marrana che scorre a cielo aperto, immondizie di ogni genere.
«Oddio, adesso lasciano i rifiuti anche in mezzo al passaggio», ha esclamato stamattina la donna che per prima ha scoperto il cadavere di Pasolini, scambiandolo per un ammasso di stracci insanguinati. Era da poco giorno, e insieme con il marito e la figlia aveva raggiunto la «casa» che con le loro mani, domenica dopo domenica, si vanno costruendo. Esattamente come i loro vicini, come nasce tutta la zona, abusivamente, senza fogne, senza elettricità, senz'acqua. Una sorta di villaggio per la vacanze dei poveri, di fronte a un mare povero e squallido, che pure rappresenta una conquista per il sottoproletariato della grande periferia urbana espropriato di tutto, anche della possibilità di godere della natura.
«Brutti, sporchi e cattivi» è il titolo di un film con Manfredi che Ettore Scola sta girando nella stessa zona. Il guardiano delle roulottes. Bruno Ortensi, dice: «Pure con Pasolini ho lavorato qui. Non mi ricordo per quale film. Forse "Uccellacci e uccellini", forse "Accattone". Era un posto che gli piaceva».
Veniva anche per giocare a pallone nel Campetto a mala pena delimitato sulla terra battuta, a pochi metri di distanza. Sotto la porta rudimentale è stata trovata la sbarra di legno con cui, probabilmente, l'assassino o gli assassini lo hanno colpito.
Arriva un autobus, vuoto, e prosegue fino al capolinea, uno spiazzo deserto su cui si affaccia un ristorante che espone questa scritta: «Si accettano clienti con cibi propri». La desolazione è quella di sempre, così bene conosciuta e interpretata da Pasolini. C'è un gran silenzio intorno quando il suo corpo viene sollevato e portato via: due palate di sabbia coprono le macchie di sangue. A terra, di lui, non resta più nessuna traccia.
Liliana Madeo, «La Stampa», 3 novembre 1975
Diceva sempre la sua verità non veniva a patti col mondo
Pier Paolo Pasolini: la violenza ha spento la poesia
Pier Paolo Pasolini era nato il 5 marzo 1922, a Bologna, da Carlo Pasolini, romagnolo, ufficiale di carriera, e da madre friulana. Gli spostamenti frequenti del padre lo portarono da Bologna, dove si laureò in lettere, nel Friuli, dove visse alcuni anni e iniziò la propria formazione poetica. E' infatti di quel tempo il suo primo libretto di versi, scritti nel dialetto materno, «Poesie a Cusarsa» (1942). A Casarsa Pasolini abitò dal 1943 al 1949, promuovendo studi sul dialetto locale e stampando una rivistina, «Quaderno romanzo». I versi friulani di quest'epoca sono riuniti con i precedenti nel libro «La meglio gioventù», uscito nel 1954; i versi che scriveva contemporaneamente in lingua, il poeta li raccolse in un altro libro, «L'usignolo della Chiesa cattolica» (1958).
Nel 1949 Pasolini si trasferì a Roma, dove scrisse i due romanzi del sottoproletariato delle borgate romane, «Ragazzi di vita» (1955) e «Una vita violenta» (1959), che gli diedero la fama e suscitarono una infinità di discussioni letterarie. Essi appartengono al «neorealismo» e trovano origine in una matrice ideologica marxista. Altri libri di poesia, oltre a «La meglio gioventù» e «L'usignolo della Chiesa Cattolica», sono «Le ceneri di Gramsci» (1957), «La religione del mio tempo» (1961) e «Poesia in forma di rosa» (1964). Tra i romanzi, uscirono nel 1962 «Il sogno di una cosa», nel 1965 «Ali dagli occhi azzurri» e nel 1968 «Teorema». Notevoli sono i suoi libri di critica, da quello sulla «Poesia dialettale» (1947) a «Passione e ideologia» e alia «Poesia popolare italiana» (entrambi del 1960). Quest'anno sono usciti gli «Scritti corsari».
Pasolini è stato anche un grandissimo regista. Cominciò la sua attività cinematografica nel 1955, come sceneggiatore del film di Mario Soldati «La donna del fiume». Nel 1957 curò i dialoghi in romanesco di «Le notti di Cabiria» di Fellini, due anni dopo scrisse il soggetto di «Morte di un amico» di Franco Rossi e curò la sceneggiatura di «La notte brava» di Bolognini, di cui sceneggiò anche, l'anno successivo, «Il bell'Antonio».
«Accattone», del 1961 (Gran premio del Festival di Karlovy Vary), riproposto giorni or sono dalla televisione, segnò il passaggio di Pasolini alla regia. Dell'anno successivo è «Mamma Roma», interpretato dalla Magnani, ritratto di una prostituta. Nello stesso anno, ancora due sceneggiature: «La commare secca», dell'allora esordiente Bernardo Bertolucci, e «Una vita violenta», per la regia di Heusch e Rondi. Seguirono «La ricotta», un episodio di «Ragopag» (1963) e «Il Vangelo secondo Matteo» (1964), vincitore del premio speciale della giuria alla mostra di Venezia nel 1964 e del nastro d'argento per la miglior regia nel 1965.
Del '66 è «Uccellacci e uccellini» (definito, dallo stesso regista, «un film ideocomico») interpretato da Totò e da Ninetto Davoli. Negli anni successivi Pasolini ricostruì per lo schermo due miti classici, «Edipo Re» (1967) e «Medea» (1970), diresse «Teorema» e «Porcile» (1968 e 1969) che divisero la critica cinematografica, e fu autore di due episodi dei film «Capriccio all'italiana» (1968) e «Amore e rabbia» (1969). Nel '71 «Decameron» segna l'inizio di quella che Pasolini definì la «trilogia della vita», completata da «I racconti di Canterbury» C72) e da «Il fiore delle mille e una notte » (1973). Sempre nel '73, Pasolini scrisse la sceneggiatura di «Storie scellerate», di Sergio Cittì, per il quale aveva scritto anche la sceneggiatura di « Ostia » nel 1970.
L'ultimo film, «Salò o le 120 giornate della città di Sodoma», non ancora uscito sugli schermi ma ormai quasi terminato, descrive le torture cui venne sottoposta una se rie di prigionieri durante la repubblica di Salò. Parte dei negativi del film furono rubati insieme con quelli di altre due pellicole nello scorso agosto dagli stabilimenti della Technicolor. Giorni fa Pasolini dichiarò che il film non aveva però subito gravi danni: sarebbe stato possibile infatti sostituire le scene mancanti con «doppioni» o «scarti», e non vi sarebbero stati ritardi nell'uscita a metà novembre. Attualmente Pasolini stava lavorando ad un progetto che aveva in mente da tempo: la storia dell'ideologia, rappresentata da una cometa, e degli uomini che la seguono.
n. s., «La Stampa», 3 novembre 1975
Pier Paolo era un amico generoso e dolce: aveva uno sguardo mite, la voce gentile anche quando s'infervorava, anche quando dibatteva le sue idee con veemenza, la veemenza che gli dava la certezza della solitudine.
La sua amicizia sembrava arrivare da lontano: sapeva sempre in anticipo dirti i tuoi pensieri. Egli ha saputo anche dire in anticipo le ragioni del proprio assassinio. E questo, per chi lo ha amato, è un motivo di strazio inconsolabile. Raccontare la sua esistenza, testimoniare della sua genialità, è facilissimo e difficilissimo in questo momento. Sembra che Pasolini sia riuscito a far coincidere, come accade talvolta ai poeti, l'invenzione e la realtà. Quale realtà? Bisogna citare i suoi versi, bisogna con la memoria tornare alle immagini di «Accattone», il film col quale dette modo a tutti di constatare lo scempio cui la vita si riduce fra i sottoproletari.
«Poi... Ah, nel sole è la mia sola lietezza... I Quei corpi, coi calzoni dell'estate, I un po' lisi nel grembo per la distratta carezza I di rozze mani impolverate... Le sudate / comitive di maschi adolescenti, / sui margini di prati, sotto facciate / di case, nei crepuscoli cocenti... / L'orgasmo della città festiva, I la pace delle campagne rifiorenti...».
Per ideologia
Il poeta, in lui, aveva rovesciato la sua ottica tradizionale: non scendeva a patti col mondo, si lasciava intridere di tutti i più degradati odori della vita, per «passione» e per «ideologia». La sua non fu una poesia nutrita da ciò che turba la coscienza per le vie di un distorto edonismo. Pasolini non era turbato dallo spettacolo del mondo, di quel mondo che reinventava nelle sue parole, nei suoi versi, con la sua cinepresa: egli cercava in ciò che scopriva sconfitto e deietto, buttato ai margini dei luccicanti orizzonti del «miracolo italiano» e poi della «civiltà dei consumi», le ragioni di forza per il suo intelletto.
Aveva il coraggio di dire sempre la sua verità, sconfessando le reticenze degli altri. E' vissuto di questo coraggio, sfidando chiunque, sfidando persino il suo stesso cuore. «...quando I scrivo poesia è per difendermi e lottare, / compromettendomi, rinunciando I a ogni mia antica dignità: appare, / così, indifeso quel mio cuore elegiaco I di cui ho vergogna, e stanca e vitale I riflette la mia lingua una fantasia / di figlio che non sarà mai padre...». Giro intorno alle parole, e sento che non ricompongono le membra sparse di Pier Paolo. Vano è riaccendere il fuoco della sua «disperata vitalità»: restano i suoi scritti, i suoi versi.
Da ultimo diceva di essere un «luterano»: si schermiva con qualche ombra a chi lo accusava di cattolicesimo puro e semplice. In effetti aveva ragione: apparteneva alla lunga schiera dei protestanti in nome della fede, a coloro che credono sia giusto spendere la propria vita, pagare di persona per ogni proprio detto, per i fini del proprio credo. Ecco, alle origini, il suo «cuore elegiaco» di poeta: i versi friulani. Già li lo strazio per la morte del fratello, ucciso dagli jugoslavi durante la Resistenza; già quel suo sguardo radente ai fatti minimi dell'esistere fisiologico: «Cutuardis ains! I cuarp cilat di belessa! / i tociavi la me cuessa / sot lì plejs limpiis de la barghessa». Sono versi cantati, dettati in un respiro con l'ansia esclamativa della giovinezza. L'estasi narcisistica è il loro tratto più evidente: una estasi mostrata senza ambiguità. L'idillio sembra prevalere. Oggi, invece, sappiamo che «La meglio gioventù» (è il titolo che egli diede nel '54 ai suoi primi versi, che in plaquettes aveva già stampato nel '42, nel '45, nel '53) è il primo momento d'una ininterrotta dedizione. Pasolini è stato uno straordinario poeta del linguaggio. Il linguaggio povero e il linguaggio colto italiano sono passati al suo vaglio, ed egli ne ha dato misura e risultanze attraverso un inesausto lavorare. Ne controllava il suono non sui parametri della musica pura: ne saggiava in profondità, invece, il contenuto ideale, e insieme emozionale. Vi leggeva in trasparenza l'animo di chi lo pronunciava: da quali moventi quest'animo era trascinato, di cosa si faceva attore o verso quale deriva andava a perdersi. Una lettura ideologica, insomma.
Doppio volto
I suoi versi hanno, perciò, un doppio volto: esprimendo il cuore del soggetto che si poneva al loro centro, Pasolini medesimo («cerco, nel mio cuore, solo ciò che ha»), svelano, in una sorta di riverbero inafferrabile, il loro oggetto: «l'umile Italia», dobbiamo dire, ricorrendo al titolo d'un poemetto compreso nel «Le ceneri di Gramsci». L'umile Italia dalle «cocenti» parole dialettali, l'umile Italia nostalgica del suo lontano e lussuoso passato (depositato nella aulicità della sua lingua letteraria): Pasolini se ne sentì investito, e ci fu un momento in cui la violenza sulla sua immaginazione fu tale che egli trapassò, senza soluzione di continuità, con quel mondo nella mente e negli occhi, dalla parola scritta a), cinema: dal romanzo al film, da «Ragazzi di vita» (1955) e «Una vita violenta» (1959) a ((Accattone» (1961). La sua esigenza di rappresentazione e conoscenza annullò le paratie dello stile verbale: ricorse ai fotogrammi, cosi come, per arrivare ai romanzi, aveva obliterato il dialetto materno, il friulano, per il romanesco. Proprio nel '59, rispondendo a una inchiesta sul romanzo promossa da Moravia per «Nuovi argomenti», Pasolini disse della necessità di «lasciar parlare le cose»: solo che questa operazione richiedeva una virtù: «Occorre essere scrittori, e anche perfino vistosamente scrittori». Il passaggio al cinema non presuppone in lui l'abbandono di quel precetto («essere vistosamente scrittori»), quanto un suo potenziamento se, come sosteneva anche, «il cinema è la lingua scritta della realtà». La realtà: fu il suo angoscioso bisogno. Era forse la parola che ricorreva più spesso nel suo discorrere. E se qualcosa era per lui «reale» voleva dire che il massimo della compiutezza espressiva e formale era raggiunto.
Contraddizione
Lasciar «parlare la realtà»: significava svelarne il connettivo politico, cioè il potenziale di dolore da riscattare, da tradurre in bene se mai l'uomo fosse riuscito a sfiorare con le sue mani il bene. Fu, quindi, Pasolini anche un poeta civile. Lo fu poiché genialmente sottopose la poesia a sollecitanti processi conoscitivi: la parola doveva restituire i contenuti del mondo, la forma plasmarli. Ma sottopose anche se stesso, quel suo cuore coraggioso ed elegiaco, a violenza: parlò per lui la sua lacerazione di uomo, preso in una contraddizione che «Le ceneri di Gramsci» (1956), il primo poemetto «politico» del nostro dopoguerra, dichiarò con sconcertante limpidezza. Era Gramsci il suo interlocutore, e Pasolini si confessò: «Lo scandalo di contraddirmi, dell'essere, con te e contro di te; con te nel cuore, in luce, contro di te nelle buie viscere». Gramsci, la sua tomba, la sua storia individuano la prospettiva luminosa del progresso e della ragione: contro tutto ciò le «buie viscere» reagiscono, e le viscere valgono quella parte inconscia dell'uomo che, fuori di ogni razionalità, lo tradisce e oscuramente lo perde. Cosa disse per moltissimi in quei versi Pasolini? Cominciò allora la sua stagione felice: egli dava verità al lungo travaglio in cui la letteratura italiana, particolarmente la più nuova, la più giovane, si era avvolta fra spasimi ed esaltazioni dopo il '45, la storia — «lo straccetto rosso della speranza», per dirla nelle sue parole — chiamava ad un rinnovamento lungamente augurato, ma qualcosa recalcitrava nell'animo di tutti. Cosa bisognava riscattare in noi per poter realizzare quel che la nostra stessa volontà chiedeva?
Quella vitalità
Pasolini tornò a dirci che quanto cercavamo era in noi e fuori di noi: dovevamo riscattare quella parte di noi diseredata, emarginata, abbandonata alla violenza. Si è parlato, in questo, d'un suo regressivo «populismo»: ma Pasolini aveva in odio la fredda concettualizzazione; era un poeta, e viveva di immagini e della plasticità delle immagini. Il sottoproletariato urbano fu per lui una grande metafora, la metafora della «disperata vitalità» da tradurre in forza positiva, concreta. Ecco, allora, quell'«umile Italia» scoperta nei dialetti, nella poesia popolare (grandissimo storico di quest'ultima è stato il giovane Pasolini negli Anni Cinquanta), veniva fisicamente plasmata dalla sua fantasia e offerta come in un'«auto da fé.) al comune ripensamento. I suoi versi, i suoi romanzi, sappiamo come vennero accolti: denunce e processi. Il personaggio pubblico violava in Pasolini ogni accademica «allure». La sua presenza era comunque dirompente. Egli perseguitava i suoi nemici nell'intelletto e nella sensibilità in forme cosi esplicite e gioiose, anche d'una ferrigna gioiosità, da suscitare sempre e in ogni momento uno scandalo. Ma la ragione ultima di questo scandalo a lui stesso era nota: ripeto, lo aveva scritto per Gramsci: «Lo scandalo di contraddirmi, dell'essere con te e contro di te». Sì, la contraddizione fra coraggio ed elegia, fra epos e narcisismo segnano indelebilmente ogni sua pagina: fino alle ultime, le pagine che amava definire appunto «luterane», le pagine polemiche in cui chiamava in causa quell'umile Italia non più riconoscibile, e sui suoi mutamenti, avvenuti a scorno di ogni razionalismo, voleva sollecitare l'attenzione di tutti.
Ferocia civile
Il suo cuore era fermo là, non aveva creduto ai possibili riscatti della società, del benessere, non aveva creduto all'encomiastica di certi politici. L'umile Italia ormai versava nella bruttura e nel fango: sparito il suo dolore, sparite le sue timide vergogne: essa ha il volto della violenza, una violenza immedicabile. La poesia non era annegata dentro di lui: era sempre più pigmentata di elementi spuri, non lirici, non eletti; ma era sempre più ricca di bagliori, di ferocia civile. Il suo discorso è rimasto a mezzo, in un momento in cui sembrava la sua mente ricchissima di contenuti, di parole inespresse e anche di vaticinio. Ripeto: era un uomo dolcissimo, un amico sollecito. Con lui e Moravia abbiamo curato insieme, da nove anni a questa parte, la nuova serie di «Nuovi Argomenti». Per la rivista aveva in animo di raccogliere un'antologia di giovani poeti. Aspettavo per oggi, per domani una telefonata: dovevamo studiare i modi in cui mettere mano alla raccolta. L'umile Italia ormai irresolubilmente violenta l'ha ucciso. La telefonata non verrà. Non sentirò la sua voce quieta dire, «ciao, sono Pier Paolo».
Enzo Siciliano, «La Stampa», 3 novembre 1975
"Anche questa morte è una confessione"
I primi commenti nel mondo della letteratura e del cinema
Una tragedia improvvisa, in un'atmosfera crudele. La morte di Pier Paolo Pasolini, in circostanze così drammatiche, ha sconvolto il mondo della cultura e del cinema. Carlo Bo, critico letterario e rettore dell'Università di Urbino, ha detto: «Sono molto addolorato. Pasolini era un autentico poeta ed è stato uno degli interpreti più appassionati e acuti della tragedia italiana». Il poeta Carlo Betocchi: «Penso al dolore di sua madre. Amavo Pasolini fin dal tempo della poesia friulana, della sua antologia dei poeti dialettali. Nel 1952, poverissimo, frequentava ogni tanto la mia povera casa di Roma. Era un ingegno fertile, sottile, di una eleganza nativa, ma non poteva tradire il cuore. Aveva un'onestà di fondo che sconfiggeva le malizie dell'artista. Ombre e luci si ferivano a vicenda in lui. Non esitava a dirlo. Era sincero. Lo rimpiango profondamente».
Alberto Bevilacqua ci ha rilasciato questa dichiarazione: «L'orrore di un omicidio, e di un omicidio così terrificante, si sintonizza immediatamente con l'oscura e atroce violenza che è sempre stata dentro l'enorme vitalità pasoliniana come un presentimento, o una maledizione contro cui avventarsi, o un segno della parte crudele di un dio. Ma questa atroce violenza attirava Pasolini, nel senso che lo attirava il rischio con cui, nel mondo-tenebra s'avventurava, spinto da una sete di guardare in faccia l'inferno. Ne aveva l'ancestrale sgomento di un miraggio. E ciò gli consentiva di conoscerlo, raffigurarlo, colpirlo. In fondo, intelligente e ipersensibile com'era, Pasolini non poteva non rendersi conto che una fine simile era prevedibile in quella tenebra». Ha aggiunto: «Mi auguro che non venga ricordato, superficialmente, tra i "poeti maledetti". C'era in lui una vena candida e perfino ingenua, da magico rito agrario, direi la sua faccia solare che io ho conosciuto negli anni in cui ebbe vita la nostra amicizia, quando la provincia per lui era un forte richiamo. E poi nei nostri primi anni romani. La sua vitalità, il coraggio di pagare comunque di persona, sono esplosi in un dopoguerra spesso culturalmente colpevole di vigliaccheria, di ipocrita culto della faida e dell'intrigo, dove troppe volte la linfa mancante ha creduto e crede di ritrovare sostituzione nelle piccole beghe mentali. Io credo che la cosa più importante sia poter dire di un autore, al di là dei suoi stessi pregi e difetti: "E' stato sinceramente vivo"».
«Sono assolutamente sconvolto, molto impressionato e molto disgustato perché mi pare una cosa orrenda». Queste le prime reazioni del regista Luchino Visconti. «Non ero particolarmente amico di Pasolini — ha proseguito Visconti — ma lo conoscevo, lo stimavo e lo ammiravo. La sua fine orrenda, di cui peraltro non conosco e non riesco a capire esattamente i termini, poteva avvenire solo in Italia, un Paese in cui la violenza è ormai scatenata e priva di ogni controllo». Il regista Alberto Lattuada ha detto: «Sono impressionatissimo perché era un poeta e uno scrittore che incideva nella nostra vita con la sua personalità. Impressionatissimo non tanto per il delitto — perché ormai viviamo in mezzo ai delitti — ma perché è un delitto contro una voce vera e uno spirito indipendente come lui, contrario a qualsiasi conformismo.
Lo scrittore Giancarlo Vigorelli ha ricordato il suo ultimo incontro con Pier Paolo Pasolini a Roma: «Era stato uno scontro ed una riconciliazione affettuosissima. In poche parole un mese fa gli avevo detto che tutto quanto andava scrivendo contro la violenza, la perdita del sacro, l'involgarimento di ogni valore culturale e civile, rischiava di essere in parte smentito dalla sua vita, dal suo lavoro, soprattutto da certi suoi film. Lasciasse quindi Roma, rompesse con il cinema, si sottraesse al denaro e a certa mondanità: lo avevo visto piangere, disarmato come ai primi anni della sua Meglio gioventù quando mi faceva leggere i primi versi ed io fui tra i pochi, allora, a credere in pieno nella sua poesia. «Mi rispose che doveva accettare anche la propria dannazione, e che ogni fuga poteva essere una diserzione o un privilegio, quindi una colpa. Mai come in quell'ultimo incontro, ebbi la riprova della sua onestà, anzi della sua dannata religiosità». «E' morto un vero poeta — ha aggiunto — e forse l'unico testimone pagante, in bene e in male, di questa nostra società letteraria, che così raramente paga di persona. Esasperatamente, paradossalmente Pier Paolo Pasolini era diventato in questi ultimi tempi una "voce nel deserto" su tanti problemi; ed erano in molti ormai a non tollerare più i suoi interventi, le sue confessioni in pubblico. Anche la sua morte atroce, infame, è una pubblica confessione. Senza veli. Era facile discutere, anche respingere certe sue idee; ma era impossibile negarne l'innocenza, il disinteresse, la sincerità sino alla perdizione. Pasolini non ha mai accusato gli altri, senza accusare e processare per primo se stesso. Era l'unico "puro" della nostra letteratura: benché vissuto gomito a gomito fra tanti furbi e furbastri della cultura, del cinema, della politica». «Sono preso da un tremendo sconvolgimento. Abbiamo perso un grande uomo e un grande esempio di coraggio». Queste le parole con cui lo sceneggiatore Cesare Zavattini ha commentato la morte del regista. «Il suo bisogno di sapere le cose "con gli indirizzi e con i nomi", aveva instaurato — ha spiegato — un modo di agire che ci doveva trascinare tutti. E' stato un esempio di quelle qualità di cui gli italiani hanno estremo bisogno in questo particolare momento. La sua morte è una tragedia per l'Italia».
E la regista Lina Wertmuller: «Abbiamo perduto forse l'intelligenza più lucida dell'Italia contemporanea. I suoi interventi civili avevano il raro pregio dell'analisi. Una perdita pesante; faccio fatica a credere che sia avvenuta casualmente».
Il regista Michelangelo Antonioni ha definito la morte di Pasolini «una delle notizie più sconvolgenti degli ultimi tempi anche perché si inserisce in un contesto che Pasolini — con i suoi numerosi scritti — cercava di definire: l'Italia di oggi, i giovani, le contraddizioni palesi. In fondo — ha aggiunto — egli è la vittima dei suoi stessi personaggi. Una tragedia perfetta prevista nei suoi diversi aspetti, senza sapere che un giorno avrebbe finito con il travolgerlo».
Tonino Delli Colli, direttore della fotografia dei più famosi film di Pasolini: «Sono appena rientrato da Parigi e sono ancora sotto choc. Non so proprio cosa dire. E' una cosa tremenda. E' la cosa più ingiusta per un uomo della sua sensibilità e cultura che potesse accadere. No, non c'è giustizia».
Parla Ninetto Davoli l'ultima sera al ristorante. «Parlava della violenza, diceva che oggi ha assunto una torma aberrante e sciocca, completamente assurda, e che anche nelle borgate romane la vita dei giovani, quella che lui tanto realisticamente aveva descritto, era cambiata, aveva lasciato ormai posto ad una mentalità arrivistica che la società capitalista aveva alimentato». Sono parole di Ninetto Davoli, l'ultimo amico che ha visto in vita Pier Paolo Pasolini.
Al tavolo del ristorante «Il Pomidoro», nel popolare quartiere San Lorenzo, Pasolini aveva parlato ieri sera con l'amico e la moglie di tanti problemi, di «un po' di tutto», dice Ninetto Davoli. Dalla sceneggiatura di un film che insieme stavano preparando, ai problemi della vita quotidiana, fino all'omicidio del Prenestino e all'assurda spirale della violenza che sta devastando la città. «Sembrava tranquillo, del tutto simile all'uomo, profondamente buono, che io ho conosciuto in tanti anni di amicizia — ha detto Davoli —. Nulla nella sua voce, nelle sue parole, nel suo comportamento mi ha fatto presagire quanto poche ore dopo gli è accaduto. Una sola frase mi ha colpito. Quando è giunto alla trattoria ha mormorato: "E' odiosa la gente. Venendo qui ho camminato a lungo a testa bassa per non guardare nessuno negli occhi"».
«La Stampa», 3 novembre 1975
Nel cinema come un profeta
Da "Accattone" al "Vangelo secondo Matteo", di ispirazione evangelico-marxista, alla rilettura di testi illustri come il "Decamerone" - Nessun altro regista, forse, era nel nostro tempo come Pasolini, anche quanto al furore polemico
Ci sono casi che l'ufficio di necrologista cinematografico è esecrabile; e questo è uno. Di un regista ancora in essere; non solo, ma così appassionatamente applicato al concetto di evoluzione linguistica stilistica del cinema da poter essere ascritto alla schiera dei teorici del film, dover comporre, senza una minima pausa di riflessione, mezzo fiaccati noi medesimi, l'elogio funebre... Il letterato Pasolini conquistò il cinema in proprio, nel 1961, alla Mostra del Lido di Venezia, con Accattone, che per una singolare (o fatale?) combinazione, è ripassato poche sere fa davanti agli occhi dei telespettatori. Non è una formula di comodo affermare che in quel film d'esordio il Pasolini regista c'era già tutto, con la pungentezza, che poi non si trova più, della prima spina; e che tutto quello che seguì, fu il coerente e sempre più elaborato sviluppo di quella prima, energica proposizione cinematografica. Ricordiamo il giorno, l'ora, le circostanze della memorabile proiezione. Declassata prudenzialmente a pomeridiana, nel settore delle « opere pri¬ me ». Una platea straripante e divisa tra amici e malevoli, gli uni e gli altri turbolenti, con in mezzo, in posizione assai scomoda, un gruppetto di neutrali. Ma l'opera s'impose anche ai ciechi; e alla fine, separatesi le schiere dei contendenti, cadde un silenzio gravido di pensiero. Il pensiero era d'essersi trovati davanti a un modo tutto nuovo, negligente e raffinato, statico e dinamico, di fare del cinema: un cinema che, senza essere «letterario», si porgeva come un equivalente, un controcanto, della buona letteratura: nel caso in discorso, dei libri Una vita violenta e Ragazzi di vita.
Perché il personaggio di «Accattone», col mestiere che fa — e come tantissimi altri, anche noi l'abbiamo capito meglio l'altra sera — riesce simpatico? Perché è irrecusabilmente umano, strappato dalle viscere; perché gli pulsa il sangue dei più congeniali eroi pasoliniani: la famosa fauna (o flora) del sottoproletariato romanesco. Rammenterete quando, trovandosi al colmo dell'abiezione, Accattone indugia a guardare un funerale che passa. Sembra niente o appena una zeppa. E' invece un'illuminazione, un tocco redentore; una di quelle « arsi » narrative che lo scrittore-regista sa introdurre nel film, nobilitandone gli schemi. Nel '61, a un pubblico ancora così impreparato, Pasolini poteva dire evangelicamente: «Avete occhi, e non vedete!». Nessuno meglio del sodale Moravia (un altro scrittore intinto di cinema) ha saputo vedere dentro la poetica cinematografica pasoliniana, rilevarne la costante di un'affascinante ambivalenza: il fervore civile, la palingenesi politica, il marxismo da una parte, e dall'altra, sentita con uguale sincerità, la vocazione decadentistica. Il risultato di una contaminazione di elementi così inconciliabili in apparenza, determinò, negli Anni Sessanta, la singolarità del film pasoliniano (si chiamasse Mamma Roma, ancora attaccato alla traiettoria di Accattone, o La ricoita o Teorema o Porcile o Uccellacci e uccellini), dove l'immagine era lavorata come parola e la sequenza come periodo; il che, in altri termini, voleva dire sovvertire i canoni del cinema dinamico (intreccio e psicologia) e sostituirli con quelli di un cinema « contemplativo », a blocchi o strofe.
Fu così inevitabile, anche formalisticamente, che Pasolini non più soltanto regista ma anche filologo del cinema accedesse al Vangelo secondo Matteo, film non solo ispirato ma anche di grande efficacia pratica, perché in grazia della sua lega evangelico-marxistica gli mediò, fino a espugnare le sale di parrocchia, un'immensa quantità di pubblico fino allora rimastagli ostile o indifferente. Il regista fecondissimo (come d'altra parte lo scrittore e il pubblicista) incalzò, non die requie. Tanto da incorrere, presso i puri, nella taccia di involuzione commerciale. Ma considerata nell'insieme, quella sua rigogliosa e tuttavia provocante filmografia, certamente discutibile in qualche titolo, appare oggi legata dall'aureo filo della sincerità, non meno che da un crescente scrupolo artigianale. Che cosa indusse Pasolini a celebrare anche sullo schermo i sottoproletari delle borgate? Il vagheggiamento di una società arcaica, la sua ispirazione di fondo. E codesto vagheggiamento, che non era semplicemente un sogno ma straripava di cultura moderna e di risentimenti freudiani (per accennare ai più evidenti), lo doveva gettare nelle braccia di Medea e di Edipo, rifatti in chiave rustica. Successe poi, all'apice della fortuna, il rilettore di lesti illustri; rilettore sempre in chiave personalissima, dottamente scabra e primordiale; il Decamerone (ch'era piuttosto un'antropologia del Decamerone), I racconti di Canterbury, Le mille e una notte. Qui, non solamente i filistei, ma professori e lettori di classici ricominciarono a strillare. Tornò in campo il venerando problema della trasposizione cinematografica di opere letterarie, con l'altro, che gli va congiunto, del debito di fedeltà. Pasolini (il dotto, il filologo) più d'ogni altro avrà avuto sulle dita Boccaccio Chaucer e il Novellista arabo. Poteva rispondere (non sappiamo se lo fece) che non aveva voluto trasporre un bel nulla, ma ricreare e contemplare. Certo è deplorevole che il Decamerone (già un po' disistimato come grande successo di cassetta) desse la stura alla moda oscena dei pornoboccacceschi. Ma oltre che un artista non è mai responsabile di quel che fa il pecorame, non è poca cosa, a pensarci bene, che un film scateni una frenesia di film. La volgare imitazione continuò stancamente sul Canterbury (un osso più duro) e si affievolì contro gli smalti e le stupende corografie della Mille e una notte.
La carovana passa, il resto rimane. Manca lo spazio e non sarebbe questo il momento per una pacata disamina dei film pasoliniani. Veniamo al punto che ci preme. Come recensori, non ci sentiamo di metterci fra i progressisti. Pure l'esperienza ci ha insegnato che quando un autore fa e il pubblico benpensante si convelle, urla, protesta, il giusto (se giusta è la forza delle cose) è sempre dalla parte dell'autore. Quanti bocconi abbiamo dovuto ingoiare in questi anni, che abbiamo fatto finta di digerire, e che in effetto abbiamo digerito davvero! Intendiamo dire che incalcolabile è stata la forza trainante di Pasolini nella storia più recente del nostro cinema. Avrà essa avuto aspetti sgradevoli, aggressivi, violenti (lui, così mite nei modi) ; ma è indubitabile che la direzione prescritta dalle stelle, piaccia o non piaccia, era quella. Non fosse che per la carica profetica, indipendentemente dal molto di nuovo e di bello che ci ha dato, gli dobbiamo riguardo. Nessun altro regista era forse nel nostro tempo come lui, anche quanto al furore polemico, onde si era recentemente promosso — intanto che lavorava a Salò o le centoventi giornate della città di Sodoma — Catilina del consumismo e Grande Inquisitore della dc. E ora, con tragico schianto, è passato dal presente alla storia.
Leo Pestelli, «La Stampa», 3 novembre 1975
Il ragazzo in carcere racconta come uccise Pier Paolo Pasolini
L'inchiesta della magistratura sulla tragica fine dello scrittore. "Respinsi le sue proposte; fu lui ad aggredirmi" - L'autopsia, compiuta ieri sera, ha rivelato che il regista era ancora vivo quando il diciassettenne lo travolse con l'auto - Interrogati due compagni dell'uccisore: i difensori del giovane chiedono la perizia psichiatrica - La madre di Pasolini si è costituita parte civile
(Nostro servizio particolare) Roma, 3 novembre.
Pier Paolo Pasolini era ancora vivo quando la sua «Alfa GT 2000», guidata da Giuseppe Pelosi, il diciassettenne che ha confessato l'omicidio, lo ha travolto: questo il risultato dell'autopsia. Stasera è terminata la prima ricognizione esterna. La morte è avvenuta per emorragia interna e rottura del cuore. Era in agonia quando l'auto gli ha schiacciato il torace. Il professor Merli ha trovato tracce di vernice sul palmo della mano destra del poeta-regista e in molte altre parti del corpo. Il capo della squadra mobile, Masone, ha detto stasera che si continuerà ad indagare fino a che non ci sarano dubbi sulla tragica fine di Pasolini: «Se analizziamo tutii gli elementi — ha dichiarato — non troviamo riscontri che facciano pensare alla presenza di complici sul luogo dell'omicidio». Il dubbio, avvalorato però solo dalla logica, resta. La squadra mobile ha rintracciato tre amici del Pelosi: Claudio Seminara, Adolfo De Stefanis e Salvatore Deicida, tutti tra i 18 e i 19 anni. Il loro racconto, sia pure con sfumature diverse, coincide con quello fatto dal presunto assassino di Pasolini. Presunto, per la legge, anche se ha confessato. Oltre al racconto dei tre ragazzi, che termina al momento in cui Pasolini e Pelosi si allontanano in auto da piazza dei Cinquecento, ci sono altre due testimonianze precise, quelle di Vincenzo Panzironi, il proprietario del ristorante della via Ostiense dove Giuseppe Pelosi ha mangiato in compagnia di Pasolini, e di Ubaldo De Angelis, l'uomo che ha visto lo scrittore mentre, assieme al giovane, faceva benzina al distributore automatico della «Mobil», sempre sulla via Ostiense, passata la basilica di San Paolo. Possiamo così ricostruire i movimenti di Pier Paolo Pasolini dalle 22 alle 24 di sabato 1 novembre e come trascorse il pomeriggio il presunto assassino.
Raccontano gli amici del Pelosi: «Siamo andati a ballare (e non al cinema, n.d.r.) e poi, chi a piedi e chi in autobus, siamo arrivati in piazza dei Cinquecento». I quattro vedono l'auto con a bordo Pasolini. Poi il Pelosi si allontana, sale a bordo e parte. Pochi minuti dopo ritorna: gli amici, intanto, sono entrati nel bar. Pelosi li raggiunge: poche battute e infine si allontana definitivamente in macchina. Chi sono questi ragazzi? Sbandati, senza altro. Ma c'è chi, parlando del loro ambiente, fa cenno ad un bar del Prenestino dove gira la droga. Parla Vincenzo Panzironi: «Ho visto Pasolini e il giovane nel mio ristorante. Conoscevo il regista; veniva spesso a mangiare. Questa volta lui ha bevuto solo una birra. Il ragazzo invece ha mangiato parecchio». Ubaldo De Angelis era al distributore di benzina, a mezzanotte e un quarto: «Ho riconosciuto Pasolini anche perché sono un suo ammiratore. Armeggiavano davanti alla pompa e li ho visti bene. Il regista era senza occhiali». Dalla stazione della «Mobil» al luogo del delitto ci sono trenta minuti di strada. Il calcolo va fatto tenendo conto dell'ora tarda. Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Pelosi arrivano in via dell'Idroscalo quando manca un quarto all'una. Torniamo allora nel punto dove è stato trovato il cadavere. Da qui allo spiazzo che viene usato come Campetto di calcio ci sono ottanta metri e il percorso è segnato da continue tracce di aggressione. Che cosa è successo? Pino Pelosi si difende affermando che Pasolini non era stato ai patti; che voleva altri rapporti sessuali; che fu lui per primo ad aggredire, ma su quest'ultimo punto chi conosceva bene il regista afferma il contrario. Dice Franco Cittì, regista: «Pier Paolo non avrebbe mai aggredito il ragazzo, non credo poi che possa essere stata una sola persona a ucciderlo. C'è un punto che mi lascia perplesso: Pier Paolo portava sempre gli occhiali. Perché li aveva lasciati nel cruscotto della macchina?» Ma il vero fatto che non quadra, in tutta la ricostruzione, è la camicia di Pasolini, trovata a terra, letteralmente intrisa di sangue. La camicia è intatta.
Non si capisce perché, essendosela levata, era insanguinata. Gli è stata tolta dopo morto? La forza fisica di Pasolini, gli occhiali e la camicia sono gli unici tre punti a soste¬ gno di una differente versione della sua morte. Contro ci sono le testimonianze precise di chi l'ha visto tranquillo al ristorante e al distributore di benzina. Se qualcuno, per qualsiasi motivo, avesse voluto uccidere Pasolini non si sarebbe fatto vedere troppo in giro. Veniamo così all'ultima ipotesi. Pelosi, sul luogo del tragico appuntamento, ha idea di derubare l'artista oppure di portarsi via l'auto. Perde la testa. Pensa di potersi sbarazzare facilmente dell'uomo e lo colpisce all'improvviso con estrema violenza. Tramortito, Pasolini cerca la fusa e per ottanta metri viene colpito ancora. E' quasi morto. Pelosi non capisce più nulla: lo investe con la macchina, sfondandogli il petto e spaccandogli il cuore. Poi fugge all'impazzata finendo contro mano. Così lo vedono i carabinieri, lo inseguono e lo arrestano. Questa sera la madre di Pasolini, la signora Susanna Chiercossi, si è costituita parte civile contro l'uccisore del figlio. L'avvocato Nino Marazzita ha avuto l'incarico, nel frattempo, di inviare alla magistratura un telegramma di protesta: si denuncia la violazione del segreto istruttorio che ha contribuito a fornire all'opinione pubblica una parziale versione dei fatti che — dice la parte civile — sono ancora da accertare. L'avvocato Tommaso Spaltro, che difende Pino Pelosi, subito dopo l'autopsia ha dichiarato all'Ansa: «Sono sbalordito per il comportamento del giudice che non ha ancora disposto il trasferimento del ragazzo dal carcere di " Regina Coeli " dove si trova in isolamento. Essendo un minorenne che ha agito da solo e non, come appare ormai certo, con il concorso di maggiorenni, la giurisprudenza vuole che il mio assistito venga rinchiuso in un istituto minorile».
E' stata chiesta anche una perizia psichiatrica sul giovane. L'avvocato Manca, che ieri aveva assistito — come difensore d'ufficio — all'interrogatorio del Pelosi, ha aggiunto: «Appariva stravolto e voleva che venisse avvertita la madre di ciò che aveva fatto. Ripeteva dì continuo questa frase: "Io che non sono nessuno ho ucciso un uomo tanto importante"». Manca ha anche detto che Pasolini aveva promesso al giovane ventimila lire. Sempre secondo la dichiarazione che l'avvocato d'ufficio ha rilasciato all' "Ansa" «lo scrittore e il giovane, prima di scendere dall'auto sullo spiazw, nei pressi dell'idroscalo di Ostia, avevano già avuto un rapporto orale nell'automobile». L'avvocato ha ancora aggiunto che «questa circostanza, riferita dal ragazzo al giudice, è stata riscontrata anche dai tecnici della "scientifica"». Sempre secondo l'avv. Manca «Giuseppe Pelosi ha detto al giudice di essersi rifiutato di avere altri rapporti con Pasolini in cui avrebbe dovuto avere un ruolo passivo: ciò sarebbe stato, secondo il giovane, il motivo dell'ira e dell'aggressione di Pasolini».
Fabrizio Carbone, «La Stampa», 4 novembre 1975
Tragico viaggio nelle borgate
Da "Sette ville" al prato dove è stato ucciso lo scrittore
Roma, 3 novembre.
Sono quaranta chilometri tra la borgata «Sette ville» — baracche, rovine e palazzi senza fognatura e senza asfalto — il luogo in cui è cresciuto il ragazzo assassino, e il campo fangoso in cui hanno trovato il corpo massacrato di Pasolini. Lungo quei quaranta chilometri c'è la pasticceria dove i ragazzi di «Sette ville» si trovano, dondolano e si guardano attorno, immusoniti, con le mani cacciate in fondo alle lasche dei blue jeans di velluto, come se avessero armi. C'è il locale dei biliardini, dove fanno le scommesse, in attesa. Uno, lo vedo al lavoro, avrebbe le mani agili la faccia sveglia di un bravo meccanico. Ripara il bigliardino. E poi? Continua la veglia, con gli altri giovani della borgata «Sette ville». Per vivere non c'è nessuna ragione al mondo. A meno che succeda qualcosa. Qualcosa certe volte succede.
Ai bordi della via Tiburtina su cui sboccano le strade di polvere della borgata, sostano due o tre grosse automobili coi colori sgargianti. Appoggiati alle macchine aspettano e fumano individui vestiti come le comparse di un film. Tutto è di lusso fuorché la faccia, che si è salvata da chissà quanti scontri, quanti corpo a cor- po, di giorno e di notte. Giù, in mezzo al prato — dove c'è ancora un prato — uno dice: «Ecco, quella è mia madre». £' la donna romana robusta, preparata per ogni evenienza sta lì in mezzo e veglia sui figli piccoli, che giocano dove c'è ancora un po' d'erba, fino a quando non «scappano». Da una collinetta già mezza sventrata scendono in gruppo. Sono ragazzini di scuole elementari, l'accento, il dialetto, esagerato, vendetta contro «la gente per bene», nelle loro grida si sente appena. Anche le facce hanno la dolcezza della vita in famiglia. Ma appena scoppia una lite uno, che intanto mi tiene d'occhio, afferra un pezzo di legno, si butta sull'altro e gli grida: «Guarda che prendo questo asse e te lo sbatto in 'testa ma tanto ma tanto che ti lascio li steso, sai?», e gli altri ridono. Deve essere lo scherzo di borgata «Sette ville», a due passi da via Fenati, dal numero cinque, interno dodici, dove vive la famiglia Pelosi. Uno di quei ragazzi, l'altra notte è diventato assassino. Dal muretto di fronte un gruppo mi guarda. Fanno vedere come sono cambiati dal tempo in cui sono «scappati» — come ha detto ai cronisti la signora Pelosi parlando del figlio. Le facce sono dure e piene di sfida. Si toccano appena co', gomito, nei loro golfetti tirati ma nuovi, nei jeans ben stirati. Qualcuno provvede. Sono facce senza un pensiero. Non viene niente prima, non viene niente dopo nella vita di borgata «Sette ville». Da qui Roma non si vede neanche. Se piove queste strade sono un pantano. Due cabine telefoniche nuove luccicano nel vuoto in mezzo alla polvere. Un ragazzino fa la ronda lì intorno. «Guardi che rubeno». Intende dire i telefoni, le uniche macchine messe qui dal Comune. Infatti si mette il gettone ma non c'è comunicazione e il gettone non torna.
«Glielo avevo detto che rubeno» il ragazzino, che ha esperienza, va via. Sulla porta della palazzina numero cinque un uomo quasi vecchio lavora, sporco di calcinacci, col cappello di carta da muratore. «Io qui avevo la trattoria. Poi un giorno metto a lavorare mio figlio (indica il gruppo di là dal muretto). Che aveva? Diciassette anni? No. Sedici. Qui se fai il garzone sei fortunato. Io potevo farlo lavorare, mio figlio. La sera chiudevo i conti e mi mancavano cinquemila lire. Cinquemila ogni sera. Mio figlio è un ladro. Ma che glielo dici a tuo figlio che è un ladro? Glielo dici sì, se lo prendi. Io non l'ho preso mai. Ho chiuso, vede, sto murando la porta. Mi mancavano cinquemila lire tutte le sere». In fondo alla strada ci sono negozi che sembrano quasi di lusso hanno tutto ciò che non serve. Le ragazzine con i jeans attillati fanno la ressa intorno all'unico telefono che funziona. «E' lui? E' lui? E' quello co' la macchina rossa? Se è lui digli sì, no scema?». La palazzina del ragazzo bruciato è pulita pulita. Sulle scale appena lavate ci sono cicche di sigarette. «I ragazzi fumano e buttano le cicche appena vedono che è pulito. Lo fanno apposta», dice l'ex padrone del ristorante che sta murando il locale. Viene avanti uno con gli occhi furbi, svelto, uno che può essere utile. «Li conosco, io so tutto. La Pelosi, la madre, prende sempre l'aperitivo nel bar dove lavoravo. Poi mi hanno licenziato, riduzione del personale. Da sola no. Però neanche con suo marito». Fa capire che avrebbe rivelazioni da fare. Sta diventando buio. Fidarsi? Eppure non vuole neppure un compenso. Sta cercando, a suo modo una promozione sociale. «Lei è giornalista, no? Com'è la madre del ragazzo assassino? La madre è quasi bella, avrà trentacinque anni, o trentotto. Veste sempre coi pantaloni e certe magliette (fa un fischio). Dicono tutti che è sempre elegante».
Al citofono e alla porta nessuno risponde. I ragazzi continuano la loro veglia sul muro fumando e toccandosi il gomito l'uno con l'altro. Uno grida, con le mani intorno alla bocca: «Chi è dritto è giusto che è dritto» come se fosse un proverbio, o una frase che nel gruppo capiscono. Si può andare di qui in mezz'ora di macchina a Ostia senza vedere mai Roma, incontrando altre case, altre baracche, altre borgate, come alla periferia di Bombay. Quando arrivo a Ostia è già buio. Mi fermo sul lungo mare. Un giovane si fa avanti staccandosi dalla parete di un bar. Dice senza aspettare domande: «Cercate Pierpaolo? Laggiù laggiù in fondo». Lo dice con rispetto, sottovoce. Da questo momento mi accorgo che Ostia «questa brutta città che sembra l'incubo di un remoto " anteguerra "» è divisa in due. Una parte vorrebbe sputare su quel corpo massacrato, e lo dice. Una parte sa solo chi era e che l'hanno ucciso. Sta lì in silenzio e non dice «Pasolini» dice «Pierpaolo». Con me è venuto antonioni. Abbiamo lasciato il lungomare, siamo entrati in un campo di spaventose baracche; ci guida un lumino. Hanno messo le pietre intorno al luogo dove c'era tutto quel sangue. C'è gente venuta da Roma, due o tre. donne e uomini, con giacche di velluto e gli occhiali. «Io gli darei una rosa a quel giovane. Ma lo sa quanti ragazzi ha corrotto? Ha corrotto l'Italia. Gente da uccidere». Non so a chi parlano Una piccola folla è uscita dalle baracche e sta intorno nel buio. Uno sistema i sassi della piccola tomba, l'altro aggiunge dei fiori. La candela si sta spe gnendo. Un gruppo romano va via. «Io mi chiamo Salvetti — dice un uomo robusto, con i capelli bianchi — vivo qui (indica la baracca). Ho visto com'era, al mattino. So chi è Pasolini. Ho sentito come abbaiavano i cani. Io vivo qui. Mi chiamo Salvetti. Sono pratico della vita qui dentro. Mi creda. Loro erano in tanti». va ad aggiungere una candela. Di certo i morti sono due, la vittima e l'assassino.
Furio Colombo, «La Stampa», 4 novembre 1975
Pietà anche per chi ha ucciso
Un profondo disagio morale ci impone di dire una parola di pietà anche per chi ha ucciso: non l'avrebbe forse detta Pasolini, così attento, umano, comprensivo d'ogni dolore e d'ogni colpa umana? Non c'è il rischio che | l'indignazione e il dolore cocente per la morte di un così vivido e sensibile intellettuale impediscano di giudicare con equità il giovanissimo presunto assassino? L'orrore per la violenza di cui dice d'essersi reso colpevole un ragazzo di 17 anni non può, non deve far dimenticare, appunto, che si tratta d'un ragazzo. Se la sera di sabato Pier Paolo Pasolini, spinto dal suo tormento, non l'avesse avvicinato per portarlo al fatale, sciagurato incontro, sarebbe mai diventato quel giovane, a 17 anni, un assassino? In una sera egli ha bruciato tutta la sua vita: nel momento in cui aveva forse immaginato chissà quali futuri, la liberazione dalla povertà e dalle frustrazioni della vita di borgata, magari l'accesso al miraggio luccicante del cinema.
La pietà per Pasolini, accesa dalla coscienza di quanto fosse doloroso il suo viaggio nella società italiana, in quelle fasce marginali della società che gli erano predilette, per simpatia umana o per ì suoi più profondi istinti di scrittore e di uomo, non può far dimenticare che la tragicità del personaggio — scrittore, poeta, cineasta, critico della società — nasceva anche dal suo esser coinvolto in prima persona, nella sua carne, in quel mondo e in quella corruzione. Quanta parte della sua critica della società italiana era tormentosa riflessione anche su se stesso e sul suo mondo? La pietà per Pasolini, più piena quando si ha coscienza della tragicità della sua condizione, non può spegnere la pietà anche per il giovane, ignorante e immaturo, che confessa d'averlo ucciso: ha soltanto 17 anni.
«La Stampa», 4 novembre 1975
Le notizie trasformate in sentenza
La gente nei bar di Roma ha in mano giornali pieni di titoli commossi, ma parla soltanto del "fatto morboso"
Sono in un caffè di Roma, col mio pacco di giornali sotto il braccio, tutti con i titoli grandi e le fotografie emozionanti. Pasolini è stato assassinato. Intorno a me preme ìa folla romana del cappuccino. Sento le voci della mattina, accalorate, confuse Parlano tutti di Pasolini. Involontariamente le ascolto; voci uguali e sfasate, chiare e confuse, come in un montaggio alla radio. E questo groviglio di voci — che sono gli «editoriali spontanei» della gente, degli ascoltatori e lettori dei mezzi di comunicazione di massa, la mattina dopo lo scoppio di una tragedia — mi fa venire in mente una immagine tragica e grottesca dei tempi della pop-art. Un giorno in una galleria d'arte ho visto uno strano carro funebre. Davanti era una limousine, nera, lucente, foderata di velluto di cuoio. Dietro era un carro dell'immondizia. In mezzo c'era un cristallo come quelli che separavano una volta l'autista dai suoi padroni. Il fiume di notizie sulla morte di Pasolini, le voci che sento e che ripetono senza fine i comunicati dell'Ansa, mi ricordano quella costruzione scombinata s tristemente ridicola.
Di qua c'è il ricordo serio e commosso di letterati e di artisti, le parole del dolore e quelle del ritratto di artista. Ma di là c'è la storia morbosa e «completa» del fatto. E qui c'è qualcosa di terribile che colpisce in faccia coloro che si occupano di comunicazioni e che hanno la responsabilità delle notizie. Muore Pasolini, nel modo tragico che sappiamo e in poche ore viene fuori una storia completa di ogni dettaglio: il modo, il luogo, le tappe, il «tipo di rapporti», e (per usare l'espressione del famoso film di Scola) «tutti i particolari in cronaca». Ma di che particolari si tratta? Si tratta di un collage deformato, composto mettendo insieme la legittima e disperata difesa del ragazzo, e tutte le cose che Pasolini avrebbe detto e fatto. All'uno, all'imputato viene tolto il diritto sacro di tutte le società democratiche, di essere considerato solo come indiziato. All'altro, alla vittima — o alla parie civile che ne dovrà rappresentare i diritti — viene buttata addosso la pietra del fatto compiuto, della narrazione completa, ora che la sua voce di «parte lesa» non può più essere ascoltata. Nel mio caffè romano all'ora del cappuccino tutti avevano in mano i giornali pieni di grandi titoli commossi. Ma tutti si raccontavano a voce la storia diffusa dall'Ansa, il racconto completo in cui i verbi al condizionale sono sfuggiti alla gente che, come un tribunale di milioni conclude: eh già, quelli muoiono tutti così. Se un fatto del genere avvenisse in Inghilterra o in America (dove ogni ricostruzione del fatto, ogni narrazione è vietata agli organi ufficiali di una inchiesta) il giudice dichiarerebbe che «il processo è impossibile». Impossibile perché la gente ha già giudicato e archiviato il caso. Il problema è specialmente grave se visto dalla parte dei giornalisti. Infatti i cronisti che sono stati tutto il giorno a contatto con la polizia parlano di cautela, di perplessità, di discrezione e rispetto.
Ma qualcuno, nelle agenzie, ha compilato la storia con «tutti i particolari in cronaca» che milioni di italiani hanno ascoltato, formulata e accettata come un verdetto finale. Questo modo, di fare diventare certezza ciò che non è né compiuto né certo né giuridicamente autentico (e persino: non consentito, si tratta di segreto istruttorio fino a una sentenza) fa nascere quel continuo moto pendolare dell'opinione pubblica in Italia: credere a tutto subito, dubitare di tutto in seguito, con una sfiducia che erode sempre di più il rapporto fra il cittadino e le sue istituzioni. ti torrente di notizie e dettagli — giunti alla gente come finali e sicuri sulla morte di Pasolini — si è trasformato in una sentenza illegittima. Viola il diritto della difesa, pubblicandone le ragioni (che sono ragioni di parte e diventano invece narrazione del fatto). E viola le ragioni della vittima, lasciando affiorare abbastanza chiaramente che sotto c'è il pregiudizio per questo tipo di vittima. Pregiudizio vuol dire letteralmente «giudicare in anticipo». Questo giudicare in anticipo non è un diritto, anzi è la violazione del diritto contro cui è urgente che chi ha responsabilità di informazione protesti. Io mi aspetto che protesti anche il giudice. E' come se qualcuno gli avesse tolto di mano il privilegio esclusivo, che il giudice esercita a nome di tutti, di indagare, ascoltare, confrontare, concludere. Anche il suo diritto, dall'informazione apparentemente «completa», è stato violato.
f. c. (Furio Colombo), «La Stampa», 4 novembre 1975
Un uomo "diverso"
Roma, 3 novembre.
Corruzione di minorenne: è il primo reato che viene contestato a Pierpaolo Pasolini. Siamo nel 1949, a Casarsa nel Friuli, durante la sagra di San Sabino. Pasolini è un giovane professore. Il suo nome viene implicato in un'orgia studentesca. In seguito egli tornerà innumerevoli volte a sedere sul banco degli imputati, accusato di tentata rapina, vilipendio della religione di Stato, ricettazione, oscenità, lesione del comune sentimento del pudore, istigazione alla disobbedienza della disciplina militare, apologia ed esaltazione di fatti contrari alle leggi, disgregazione degli ideali dell'esercito, sovvertimento violento degli ordinamenti costituiti dello Stato, istigazione a commettere delitti. Ogni accusa ha portato a un processo, costellato da una sequela di ricorsi e di appelli. Tante vicende giudiziarie appaiono oggi come altrettanti momenti di un unico processo intentato contro (do scandalo Pasolini», lo scandalo che l'artista stesso rappresentava con la sua caparbia ostinazione nel definirsi «diverso» nel manifestare apertamente scelte e comportamenti «irregolari», nel denunciare la violenza del potere, la corruzione della classe dominante, la sordità della Chiesa ufficiale, i tranelli del moralismo gauchista, la continuità fra il ventennio fascista e il trentennio democristiano, il settarismo della cultura ufficiale, gli effetti disgreganti di uno sviluppo che non è progresso, ma consumismo e mercificazione di massa, i falsi miti del nostro tempo, le facili etichette, i luoghi comuni consolanti. Per la destra è stato un simbolo, da esecrare senza mezzi termini.
«Anomalo sessuale, psicopatico pericoloso» veniva definito abitualmente. Alla prima di «Mamma Roma», nella capitale, lo presero a schiaffi. Alla presentazione di «Accattone», al Lido di Venezia, fu bersagliato da pomodori, uova marce, fischi, invettive. Le provocazioni venivano dai passanti dagli sketches radiofonici. Il linguaggio usato contro di lui era irriducibilmente volgare. Quando gli venne conferito il premio «Città di Crotone», il prefetto di Catanzaro annullò il riconoscimento. La tensione emotiva che egli riusciva ad attizzare — suscitando su di sé collera, violenza, sarcasmo, antipatia, rifiuto, odio — era proporzionale al crescere della sua notorietà e alla sua autorevolezza di artista. Lo «scandalo Pasolini» continuamente si ripresentava, sotto diverse facce. Nel '54 fu il suo primo libro di successo, «Ragazzi di vita», che si attirò — insieme con le polemiche letterarie — l'accusa di oscenità: il processo si con- eluse con un'assoluzione. Poi fu la volta di un epigramma dedicato a Pio XII, morto di recente. I versi dicevano: «Ma la tua religione non parla di pietà? - Migliaia di uomini sotto il tuo pontificato davanti ai tuoi occhi - sono vissuti in stabbi e porcili. - Lo sapevi: peccare non significa fare il male. - Non fare il bene, questo significa peccare. Non c'è stato un peccatore più grande di ten. Valentino Bompiani, che aveva pubblicato la composizione, fu espulso dal Circolo romano della caccia. Premio Strega del '60, l'anno della «Ragazza di Bube» di Cassola: alla presentazione dei finalisti, egli lesse una lunga poesia che parafrasava l'orazione funebre di Antonio.
Era contro Cassola, denunciava «La morte del realismo». 1968: in versi Pasolini lanciò il suo anatema contro gli studenti figli di papà, e si schierò dalla parte dei poliziotti, figli del proletariato; si ritirò dal Premio Strega e invitò a votare scheda bianca; fu al palazzo del cinema del Lido di Venezia, fra i cineasti contestatori. L'irritazione che egli riusciva a seminare intorno a sé, si allargava. Nel '60 fu querelato dai genitori di alcuni ragazzi, che lo accusavano di istigazione alla prostituzione. Nello stesso anno si dovette difendere dall'accusa di favoreggiamento: nella vecchia via Di Panico aveva preso a bordo della sua vettura un giovane che aveva partecipato a una rissa. Fu querelato da un giovane del Tiburtino 111, che si riconobbe nel personaggio di un suo romanzo. Nel '61 un distributore di benzina di San Felice Circeo, vittima di una tentata rapina, denunciò lo scrittore. Pasolini respinse ogni accusa. Al processo di primo grado, nel '62, fu condannato a 15 giorni. In appello fu amnistiato. Nel '69 lo querelò il regista Zeffirelli. Nello stesso anno il pretore di Venezia lo assolse per gli incidenti accaduti alla mostra cinematografica. Nel '71 fu di nuovo sul banco degli imputati, dinanzi alla Corte d'appello di Torino, insieme con Pannella e esponenti di «Lotta continua»: gli vennero contestati i reati di disobbedienza alla disciplina militare, disgregazione degli ideali dell'esercito, eccetera.
Quasi tutta la sua produzione cinematografica è stata contrassegnata da denunce, polemiche, sequestri, processi, conflitti con le commissioni di censura. Divennero «casi» giudiziari e culturali Accattone, Mamma Roma, La ricotta (l'accusa di oscenità e vilipendio alla religione fu sostenuta dal giudice Di Gennaro; la condanna fu di 4 mesi), Teorema, Porcile, I racconti di Canterbury. Ogni volta che la magistratura interveniva, Pasolini era lì, paziente e risentito, pronto a difendere la sua opera. Denunciava «l'oscenità della Tv, la pornografia della produzione cinematografica corrente». Diceva che «la censura è il fatto davvero indecente, perché violenza alla libertà di pensiero e di comunicazione».
Liliana Madeo, «La Stampa», 4 novembre 1975
Le confessioni del poeta
L'esperienza di Pasolini scrittore si chiude idealmente con le poesie di La nuova gioventù, una raccolta pubblicata pochi mesi fa che comprende i primi e gli ultimi versi, tutti in dialetto friulano. E' una circolarità che acquista un preciso significato, che serve a ordinare in qualche modo i pensieri turbati dal fatto atroce che abbiamo sentito, a chiarire un lavoro ricco e intenso, generoso anche di sprechi. In p-incipio, dunque, c'era il Friuli materno, inteso come luogo privilegiato dell'anima e dei sensi, come stagione dell'infanzia: contrapposta a una maturità che è dolore e colpa, sulla quale, incombe a tratti, già acuto, un sentore di morte liberatrice. Dietro l'impiego del dialetto, poi, c'è l'esigenza di riscoprire un linguaggio innocente non solo nella pratica del «parlato», ma anche in una specie di eulta verginità. Il dissidio trova già nella prima raccolta, La meglio gioventù, una possibilità di svolgimento e decantazione. Si passa cioè, quasi insensibilmente, dall'elegia all'epica, dal sonetto e dalla canzonetta al poemetto narrativo, dai versi brevi ai versi lunghi, sulla scorta di una passione filologica esercitata sul Canzoniere del Nigra. Parallelamente si afferma un sentimento di esclusione e rivolta, gli struggimenti del sesso vengono accettati e proclamati come ambigui strumenti di liberazione: «Non puoi perdonare, tu, Friuli cristiano, a uno che la tua lingua schiava liberava in un cuore caldo di peccato».
Il poeta si volge inoltre, dalla distillazione del proprio mondo interiore, al recupero della storia e delle tradizioni della gente contadina, al suo secolare destino di persecuzione e di lotta. Fruendo degli stimoli stessi di una nativa religiosità, gli oppressi cominciano ingenuamente a prendere coscienza di sé: «Vegner' el vero Cristo, operajo, - a insegnare a ver veri sogni». Perché ci sia cambiamento sembra però necessario uno strappo, anche fisico, segnato dal trasferimento di Pasolini a Roma. Il marxismo ha messo in crisi la sua mitologia cattolico-contadina, lo ha spinto a immergersi nella storia, ma questo non avviene senza tensioni e lacerazioni. Si prendano Le ceneri di Gramsci (1957), una raccolta di poemetti già preparati da L'usignolo della Chiesa cattolica, che rivelano in lui il più sicuro temperamento poetico del dopoguerra. In alternativa al mito del Friuli, troviamo quello dell'umile Italia appenninica, esaltata nella sua irrazionalità e spontaneità, «il cui clamore non è che silenzio». E' un popolo che sempre più rapidamente migra e si assiepi nel suburbio, nelle «borgate»: «Un esercito accampato nell'attesa - di farsi cristiano nella cristiana - città, occupa una marcita distesa - d'erba sozza nell'accesa campagna...». In questi sottoproletari Pasolini ravvisa gli eredi delle orde barbariche che rigenerarono Roma, non sa negare loro fiducia e solidarietà. «Qui, nella campagna romana, - tra le mozze, allegre case arabe - e i tuguri, la quotidiana - voce della rondine non cala, - dal cielo alla contrada umana, a stordirla d'animale festa». Certo la sua partecipazione è impura, ma non c'è doppiezza in lui se con tanta impietosa lucidità si confessa, al Cimitero degli Inglesi, davanti al cenere muto di Gramsci: «Lo scandalo del contraddirmi, dell'essere - con te e contro te; con te nel cuore, - in luce, contro te nelle buie viscere; - del mio paterno stato traditore - nel pensiero, in un'ombra di azione - mi so ad esso attaccato nel calore - degli istinti, dell'estetica passione; - attratto da una vita proletaria - a te anteriore, e per me religione - la sua allegria, non la millenaria - sua lotta...».
Non sfugge a Pasolini come l'allegria sia appena una delle componenti, non la più certa, del mondo che ama, di questo speculare Friuli più involgarito e abbietto, che sembra muovere con le sue baracche all'assalto delle metropoli. Tanto fa per difendersi dalla tentazione dell'idillio, dettandosi uno stoico codice di comportamento: «Nel restare - dentro l'inferno con marmorea - volontà di capirlo, è da cercare - la salvezza». E ancora, votandosi a uno sposalizio fervido con la vita, in tutti i suoi aspetti, accettandosi nell'oltranza delle contrapposte passioni: «Solo l'amare, solo il conoscere - conta, non l'aver amato, - non l'aver conosciuto...». Siamo alle acquisizioni più feconde di Pasolini, solo raramente saprà andare più in là. Non è soltanto la scoperta di un mondo subumano che l'Italia ufficiale e gli strateghi della rivoluzione sembrano ignorare; non è soltanto la costituzionale non speranza acuita dalle rivelazioni del XX Congresso del partito comunista sovietico. C'è tutto questo in Pasolini, in lui s'intrecciano i drammi che hanno toccato variamente, in quegli anni, gli intellettuali italiani: davvero, nelle sue cose più alte, è riuscito a dilatare i traumi personali in traumi di generazione. Quando è più debole e stanco e prigioniero della nevrosi, è soltanto un uomo infelice, un letterato querulo; ma nei momenti di grazia, allorché si rivela la sua vocazione allo scandalo, il gusto dell'eresia, il rifiuto della norma e dei fatti compiuti, la sua poesia rende onore alla categoria cosi spesso screditata degli intellettuali. Le ceneri di Gramsci segna uno spartiacque nella poesia del dopoguerra. Oltre il trobar clus degli ermetici, Pasolini recupera forme di poesia che parevano vecchie e desuete come la canzone, il dibattito in versi, l'invettiva, immergendole e vitalizzandole nel tumulto del proprio cuore e del proprio tempo. Petrarca, sì, e Leopardi, Carducci, D'Annunzio, riletti in piena aderenza con la cultura e la storia contemporanea. La lingua tende progressivamente a storicizzarsi, si razionalizza, perdendo le musicali cadenze, i preziosi imprestiti: più che il rigore d'intelligenza emerge la severità dell'ispirazione morale. Già era nato, non ancora edito, il narratore de II sogno di una cosa (pubblicato nel 1966), dove, in un Friuli ancora elegiaco, s'incidono, non senza ingenua retorica, le prime lotte popolari, i turbamenti sociali del dopoguerra. Più importanti Ragazzi di vita (1955) e Una vita violenta (1959) scritti prevalentemente in dialetto e gergo romanesco. L'adozione di questo strumento non pertiene soltanto alla voracità esistenziale e sperimentale di Pasolini; forse è il segno di un altro brusco strappo al cordone ombelicale che lo lega al Friuli dei primi incantamenti. Siamo al mondo delle borgate già esemplificato nelle poesie: Pasolini entra in quel ghetto con un gomitolo di motivazioni. C'è la volontà aspra dello scandalo e la delizia di un plurilinguismo scoperto in Gadda; c'è la compromissione creaturale e la risposta a richiami dannati.
Orrore e fascinazione contendono in lui. In una epigrafe cita Tolstoj: «Il popolo è il grande selvaggio nel seno della società». Continua a credere nella giovinezza innocente anche quando si presenta con le stigmate della perversità. Una vita violenta è la storia di una educazione morale e politica che la morte, si direbbe per fortuna, interrompe: qualcuno lo ritiene il testo più ottimistico di Pasolini. Nelle poesie di La religione del mìo tempo, i ragazzi di vita tendono a essere assolutizzati nel riscontro con i popoli giovani e umiliati del Terzo Mondo, con una nuova internazionale di straccioni allegri e disperati. Il libro segna però la rottura del pur risicato equilibrio delle Ceneri. Come accade, sostanzialmente, per Poesia in forma di rosa (1964) che è una confessione di totale impotenza: non c'è palingenesi che tenga, tutto è sottoposto all'aggressione di una inarrestabile, borghese volgarità. «Ho perduto le forze; - non so più il senso della razionalità; - decaduta si insabbia - nella tua religiosa caducità - la mia vita, disperata che abbia - solo ferocia il mondo, la mia anima rabbia». La rabbia si esprime sempre più sovente nel dileggio e nell'ironia: sui fatti politici e culturali che lo vedono testimone rovente, sulla propria stanchezza ed inerzia. Perché la storia più vera del suo percorso poetico è quella di una personale scissione, di una «impurità», dalla quale tenta di riscattarsi e si riscatta immergendosi negli inferni quotidiani, riportandone pietre di fuoco per la coscienza di tutti. Così sono serviti, sono stati importanti, per coloro che amano la poesia, gli scritti comparsi su Officina e Nuovi Argomenti, i saggi di filologia, sui dialetti, su Pascoli e il Novecento raccolti in Passione e ideologia. Pasolini scrittore a quel punto ha ormai dato il meglio di sé. Nel romanzo Teorema ('68) un dio di straordinaria bellezza scende tra gli uomini a mettere in crisi la colpevole tranquillità di una famiglia borghese.
Il torbido misticismo stride rispetto alla castità del Vangelo secondo Matteo: un film, appunto; dal 1960 in avanti, Pasolini è riuscito a superare l'impasse dedicandosi, con un gusto avventuroso tutto suo, al nuovo mezzo espressivo. Negli ultimi tempi si erano infittiti, anche sulla stampa quotidiana, i suoi interventi provocatori, dove bagliori profetici restano spesso offuscati dal gusto dell'irrisione e della sfida, dell'acre autoflagellazione (ora in Scritti corsari). E' il Pasolini che darebbe l'intera Montedison per una lucciola, che rimpiange l'universo contadino e operaio non ancora toccato dalla civiltà dei consumi, da uno sviluppo aberrante. Sembrava ripreso dal fervore creativo anche sul versante letterario. Stava scrivendo un voluminoso romanzo, dedicato questa volta al mondo operaio: un'esperienza — diceva — che gli mancava, come uomo e co me scrittore. Un tentativo di riaggrapparsi alla «ragione» di coltivare nuove utopie? Il libro conclusivo resta per ora quello friulano: l'adolescenza rivisitata dopo le ultime delusioni, i fuochi spenti. Esorcizzazione o estrema consolazione? Non molto tempo fa Pasolini, parlando di queste poesie che riprendono, dopo vent'anni, la lingua di Casarsa, mi disse: «Il ricorso al dialetto mi venne istintivo. Forse influirono occasionali motivi giornalistici, le voci di recessione suscitarono anche in me l'idea di un ritorno». La recessione, la regressione: l'osservazione apparentemente banale acquista oggi il suo significato più fondo e più vero, come d'un inconsapevole addio.
Lorenzo Mondo, «La Stampa», 4 novembre 1975
Un testimone del nostro tempo
Ha sofferto nel profondo la crisi di tutti i valori
Non ho mai incontrato Pasolini di persona, non sapevo di lui se non quello che egli veniva ostentando di sé con tanta ansia di comunicare, di mettersi a nudo sotto gli occhi di ognuno, quello cioè ch'egli ha espresso con rabbia e abbandono nella poesia, nel romanzo, nel cinema. Ma sono stato uno degli ultimi a «parlare» con lui, ad ascoltare le invettive torrenziali ed innocue che egli mi indirizzava venti giorni fa dalle colonne del Mondo, ed ora eccomi qui, soffocando l'indignazione per la violenza perpetrata e per l'intelligenza spenta, a tentare di decifrare il senso ultimo della sua vita.
Idea e Utopia
Mi sembra che affiori di continuo nell'opera di Pasolini un che di febbrile e di aggressivo, qualcosa di non abbastanza decantato, di prematuro, che nasceva dalla sua prodigiosa intelligenza creativa; trabocca dal suo stesso vivere un esibizionismo impaziente, che sembra nascere non da tracotanza o vanità, ma dalla sua timidezza repressa, ed era forse soltanto un'ansia di essere ascoltato, di stare in mezzo a gente amica, quasi un bisogno struggente di affetto. Tutta l'opera sua di scrittore e di regista lo manifesta come un rivelatore eloquente e sensitivo del nostro tempo, uno di noi che ha più acutamente sofferto nel profondo la radicale crisi dei valori nella quale ci è toccato vivere. Intellettuale diviso tra le certezze dogmatiche del marxismo e la propria libertaria formazione borghese, ha espresso nelle Ceneri di Gramsci l'insanabile lacerazione fra l'adesione rassicurante del cuore e l'irriducibile cimento dell'intelligenza critica. Profeta del pansessualismo come liberazione, ne edificò in Teorema l'allegoria triste, ne ribadì dall'uno all'altro film la monotonia squallida, fino all'inesorabile sbocco nella frigidità di massa e nella nausea. Con ingenuo furore propose di processare i maggiorenti politici, quasi non fosse la lotta politica di per sé un processo continuo, un perpetuo assolvere e condannare, e s'imbizzì perché le persone serie non gli davano ascolto.
Da ultimo avrebbe voluto sopprimere la televisione e la scuola, grandi corruttrici, strumenti diabolici del condizionamento di massa al consumismo, tutto preso ormai dall'illusione ricorrente di dover risalire alle origini per ritrovare l'uomo puro, la verginità dei semplici affetti, la bontà naturale, la naturale ragionevolezza idoleggiata da Rousseau. Abbiamo invece alle spalle soltanto un mondo di paludi e di selve, di carnivori e di serpi, di ciottoli e di rovi: un mondo indifferente al solitario dramma dell'uomo e passivamente ostile. A forza di vagheggiare illusorie innocenze perdute con questo primitivismo di maniera, basterà che sopprimiamo qualche scuola ancora, e potremo rimetterci a scheggiare l'amigdala, ad appostare gli ominidi con l'ascia di selce. Fra queste illusioni campeggia nei romanzi di Pasolini quella di ritrovare fra i giovani delle borgate romane questo uomo puro: un ragazzo semplice, allegro, bonario, arguto, un po' ladruncolo (ma con spensieratezza), un po' magnaccetto (ma così affettuoso!). Poi d'improvviso la scoperta, sotto quegli scanzonati sorrisi, del ghigno nazista, la ferocia cieca e totale, il volto profeticamente antevisto del proprio assassino. Eppure anche questo è un mitologizzare, perché i giovani delle borgate altro non sono, come i giovani tutti, che tenera argilla pronta ad assumere qualunque forma la società sappia loro imprimere con rigore. Stona, sociologia, economia gli erano estranee ed egli s'illuse di poterne superare le smisurate lande, i meandri insidiosi, con intuizioni folgoranti e impennate subitanee.
Resterà invece, autentica e durevole, la presenza sua di poeta, e l'impegno civile dell'uomo aggressivo, indifeso e vulnerabile, che ha sofferto con spasimo tutti i mali del nostro tempo e li ha denunciati con rabbia, fra trasalimenti premonitori e cupi scoraggiamenti, mescolando di continuo le proprie private angosce, i disadattamenti e le impotenze, con le tensioni complesse, i drammatici problemi della realtà. L'impatto era quello di una furia eversiva lucida e sterile, senza speranza. Certo, abbiamo un estremo bisogno di profeti disarmati, di voci che gridino nel deserto: l'inerzia che ci aggrava è giunta a tal punto, che forse soltanto la denuncia senza appello, il rifiuto globale, possono destarci. Ma la protesta pasoliniana non andava oltre, non offriva ipotesi per il futuro. Recise ormai per sempre le radici antiche (i modi di produzione, direbbe un marxista) del mondo contadino, non è più lecito idoleggiarlo come modello recuperabile, riesumare una fresca Arcadia perduta, che è esistita soltanto nelle carte dei poeti. Non è lecito rimpiangere la mansuetudine e la solidarietà fraterna delle comunità dei credenti, senza accettare insieme l'assolutezza del dogma e la morale positiva, che reprime col deterrente del peccato tutti gli istinti carnali, nessuno escluso. Pasolini non era retrogrado, ma, come gli indovini nell'Inferno dantesco, volgeva la fronte «retrorso», al passato. Non volle comprendere che indietro non si torna, che non si può riavvolgere la storia come una gomena che s'è srotolata troppo in fretta, che non resta se non guardare avanti e procedere ad occhi aperti, con disincantata determinazione, anche se nel buio ci attendono baratri e mostri, perché l'unica evasione possibile dal male che ci attanaglia sta nella nostra capacità di inventare giorno per giorno un praticabile futuro.
Ora, la pietà
Non vorrei apparire ingeneroso in questo discutere ancora con chi non potrà replicare, né ora né mai. Ebbene, non lo avrei fatto (non lo feci) finché egli era in vita, perché non c'era altro da dire (il dissenso può divenire incomunicabilità), perché egli stesso aveva dichiarato di non voler replicare «mai più». Tanto valeva che gli restasse l'ultima parola. Oggi invece, al di là dello sgomento inorridito e dei tanti tributi di rimpianto e d'affetto, che si addensano intorno alla sua povera spoglia, sembra doveroso fermare di lui un'immagine non meramente occasionale e patetica. Di fronte a questa morte così stupida e atroce, così casuale e pur così prevedibile, di fronte a questa vivida intelligenza che un pezzo di legno scheggiato ha ridotto a grumi grigiastri raccapriccianti, l'empito dell'orrore, e anche il più radicale dissenso, non possono non placarsi in una infinita pietà. Pietà anche di noi stessi, del mondo distorto in cui ci tocca vivere, e che, forse inconsciamente, abbiamo anche un poco contribuito a costruire — trap¬ pola o calvario — con le nostre mani. Di questo mondo Pasolini è stato dapprima il testimone eloquente, poi il denunciatore che non si placa. Testimone ho detto, non maestro: scolta affannosa di queste nostre inermi fortezze da Basso Impero, non — come forse s'illuse — ispiratore di nuovi ideali, non guida verso il mal scrutabile futuro. Ma più di tanto nessuna età ha mai potuto chiedere ai suoi poeti maledetti e infelici.
Luigi Firpo, «La Stampa», 4 novembre 1975
L'uomo di cinema
Come regista, se il così detto «impegno» significa appassionata o anche accanita verificazione del presente, con intenti di palingenesi, dei nostri registi della generazione di mezzo, nessun dubbio che Pasolini sia stato il più «impegnato» di tutti, quello che meglio ha conciliato insieme, fino a immedesimarle, sincerità e provocazione. Anche nelle opere minori o minime (mettiamo Appunti per un'Orestiade africana), le distrazioni estetiche del «decadente», che a un altro sarebbero bastate, non soffocavano in lui l'impeto riformatore, il soffio messianico. Ciò apparve chiaro fin dall'esordio.
Accattone, che nel '61 poteva sembrare un fuor d'opera, un diporto di letterato romano, e pertanto fu avvicinato con molta diffidenza, folgorò invece gli astanti con sale in zucca perché vi si sentiva l'impetuosa scoperta di un nuovo mondo espressivo (già teorizzato in pectore dal dotto esordiente), l'iniziazione d'un secondo apostolato artistico-civile. Si è costatato recentemente in tv, meglio di quello che si fosse potuto fare quattordici anni fa (futurum plura docebit), la forza, la novità tonale e strutturale dell'opera, dove una creatura abietta (ma esistono creature abiette?) usciva giustificata dalla calda partecipazione umana con cui era vista e rappresentata. Il film, per allora, non somigliava a nessuno. Condotto con apparente negligenza, su una traccia apparentemente improvvisata, negava la letteratura (la letteratura del cinema, fondata sull'intreccio, i dialoghi e le motivazioni psicologiche) al tempo stesso che la riaffermava: per la cura con cui immagini e sequenze erano battute e ribattute, ognuna per sé, come parole e strofe. Ne uscì un cinema nuovo, di successive illuminazioni; dove la dinamica del racconto tradizionale era assorbita dall'immobilità della contemplazione. Accattone era nato dalla poetica dei «ragazzi di vita», si deliziava di quello scenario romano di baracche, tra città e campagna, oggi svanente, dove per un atroce destino lo scrittore-regista ha trovato la sua morte per mano di quella violenza che ultimamente si era dato a esorcizzare con furore sacerdotale. Come tutti i veri artisti, anche Pasolini non si scostò mai troppo dalla sua prima ispirazione.
Lasciamo l'evidente corollario di Mamma Roma, con parti bellissime ma un po' imbarazzato dalla presenza di una grande attrice. Ma non se ne scostò nella Ricotta, in Uccellacci e uccellini, nel Vangelo secondo Matteo. S'implicasse nel sesso, nella psicanalisi, nella satira sociale (Teorema, Porcile), compiesse quei larghi escursi nel mondo antico, facendone uscire apologhi e allegorie di pungente attualità (.Edipo re, Medea), sempre Pasolini accudiva, con cresciuta dottrina, al motivo del cuore: la glorificazione dell'uomo creaturale, astorico, incolume dalla civiltà. E in chiave di «rilettura» libera o addirittura di féerie erudita, che altro fecero il Decamerone, I racconti di Canterbury e II fiore delle mille e una notte, se non riprendere e dilatare, con molto successo di pubblico (anche troppo, viste le infami imitazioni che vi s'attaccarono), quel tema di fondo? Oggi che purtroppo la possiamo considerare chiusa, la filmografia di Pasolini, come ogni altra cosa sua, ha l'inestimabile pregio della «personalità»; testimonia di un'intelligenza lucida, sfidante fino alla provocazione, ma anche commossa fino allo strazio. Si poteva discuterlo e qua e là revocarne in dubbio la misura, il buon gusto (ma sono criteri di giudizio che con Pasolini suonano falsi); poteva scandalizzare Girotti che si lasciava scivolare i calzoni; potevano urtare i tanti accoppiamenti non sempre prammatici, i tanti ceffi dalle dentature sgangherate, gli anacronistici impasti dialettali.... Ma tutto questo ha ora ben poca importanza nell'opera compiuta che si riordina nelle sue linee maestre. Ad ogni film, Pasolini ci serviva le sue viscere su un piatto; anche quando poteva sembrare che tradisse Boccaccio, Chaucer e il Novellista arabo (in realtà non tradiva: smontava e rifaceva), non però tradiva mai se stesso. Potremmo concludere che quando un poeta entra in un'attività, ci reca fracasso e disturbo, ma quando poi ne esce, ci lascia un irreparabile vuoto.
l. p. (Leo Pestelli), «La Stampa», 4 novembre 1975
Interrogato oggi l'uccisore di Pasolini. Atteso un altro rapporto della polizia
Forse lo scrittore frequentava lo stesso bar del diciassettenne - L'inchiesta giudiziaria smentirebbe la tesi difensiva del ragazzo
(Nostro servizio particolare) Roma, 4 novembre.
Piazza dei Cinquecento, lato sinistro della Stazione Termini: sotto ai portici ci sono negozi, bancarelle e bar; nel centro si lavora da anni per l'interminabile metropolitana. Al limite del giardino che porta verso il museo delle terme c'è un chiosco, detto «La Casina delle rose». Pier Paolo Pasolini arrivò qui la sera del primo novembre. Erano le 22,30. Tra il bar «Dei» e il giardinetto incontrò Giuseppe Pelosi, il diciassettenne che ha confessato l'omicidio. Tentiamo un'indagine per capire se vittima e assassino si conoscevano e per chiarire altri punti sfocati della tragica storia. Dall'incontro con la gente del posto emergono tre fatti abbastanza concreti: 1) pare che Giuseppe Pelosi, detto «Pino la rana», conoscesse Pasolini; 2) sembrerebbe accer- meno gradisce vedere il suo nome sul giornale. C'è il signor «C», «l'avvocato» e l'amico.
La testimonianza del proprietario del bar «Dei» è secca: «Ci veniva spesso Pasolini, spessissimo». E allora gli altri si sbottonano: «La sua auto metallizzata — dicono — la parcheggiava lì davanti. Poi veniva al bar oppure andava alla "Casina delle rose" a cercare i suoi compagni». E il discorso cade allora su Pino Pelosi. L'amico dell'«avvocato» è quasi sicuro che si conoscessero. «Pasolini — dice — non offriva cene a sconosciuti». Sono mezze parole. Uno ti accompagna all'altro bar, ti presenta e se ne va. Poi si avvicina un altro di mezz'età e interviene nel dialogo. «Una brutta storia — dicono — perché è morto un uomo importante e perché c'è finito di mezzo un ragazzo». Altri non vogliono dire nulla: sono fer- tato che il giovane non fosse {mi dinanzi le edicole a legge re i giornali aperti alle prime pagine, con le frecce che sottolineano gli articoli e le foto del delitto. Che valore ha quest'indagine? Potrebbero cambiare molte cose se sarà accertato che Pasolini e Pelosi si conoscevano realmente. Sappiamo che questo punto non è stato un occasionale frequentatore del posto, ma un abituale; 3) è certo che il poeta-regista si faceva vedere spesso nella zona. Il quadro emerge da un dialogo difficile. La gente che abitualmente trascorre la sera in piazza dei Cinquecento non parla volentieri. E tanto- ancora chiarito. Il magistrato del tribunale dei minorenni, Salvatore Giunta, che doveva interrogare oggi pomeriggio Pino Pelosi, ha rinviato l'incontro a domani. E' in attesa di un ulteriore rapporto della polizia. Tuttavia i punti fermi dell'inchiesta giudiziaria sembrano demolire la tesi difensiva del presunto assassino: i pezzi di legno repertati dalla polizia sono due. Hanno tracce di sangue, capelli e materia cerebrale di Pier Paolo Pasolini. La ferita alla testa del Pelosi (un punto di sutura) è parallela alla linea della fronte. Secondo il perito il ragazzo potrebbe essersela fatta sbattendo la testa contro il volante dell'auto quando fu fermato dai carabinieri dopo l'inseguimento. Sembra difficile che sia stato un colpo di bastone. Giuseppe Pelosi nell'interrogatorio aveva detto: «Lui mi ha colpito per primo». Poniamo per assurdo che Pasolini e il ragazzo si conoscessero.
Cadrebbe, in questo caso, la motivazione che il Pelosi ha dato ai giudici nel primo interrogatorio: «Io ho rifiutato un rapporto omosessuale che lui mi chiedeva; mi sono difeso dalla sua ira e poi, in un raptus, l'ho ucciso». Altra ipotesi per assurdo: Pasolini frequentava piazza dei Cinquecento e aveva avuto incontri con personaggi del posto. Pasolini conosceva bene via dell'Idroscalo, il luogo del delitto. Non potrebbe essere che i frequentatori di piazza dei Cinquecento, o almeno qualcuno di loro, conoscessero quella zona? Potrebbe così affacciarsi la probabilità dell'agguato, magari per rapina. Parlando con l'avvocato Nino Marazzita, che domani perfezionerà in tribunale la costituzione di parte civile, il discorso cade sulle indagini: «Noi non abbracciamo nessuna tesi precostituita. Alla parte civile — dice — interessa la ricerca della verità, più ipotesi si fanno meglio è». — Lei ha dubbi sulla ricostruzione del delitto? «Ci sono punti che non mi sembrano chiari. Primo: Giuseppe Pelosi ha ucciso Pasolini passandogli sopra con la macchina. Perché? Ha spiegato che non capiva più nulla.
Ma dobbiamo ricordarci che c'erano ottanta metri di strada sterrata da dove era parcheggiata la macchina al cadavere. Per investirlo bisognava girare lo sterzo e sfiorare una recinzione. Era più logico, scappando, andar dritto. Secondo: il regista era un uomo estremamente mite di carattere. Lo dicono tutti quelli che lo conoscevano. Terzo: la camicia di Pasolini macchiata di sangue. A che gruppo appartiene? Sono tutti accertamenti che devono essere fatti. Ma il segreto istruttorio è stato violato ampiamente e l'opinione pubblica si è fatta un'idea precostituita del caso». Parla l'avvocato difensore del ragazzo, Tommaso Spaltro: «E' un caso difficile. Pelosi rischia una grave pena. Noi ci batteremo per la legittima difesa. Ora ci sarà la visita del medico legale e quella psicologica, obbligatoria per i minori». Domani alle 17 ci saranno i funerali civili, partendo dalla «Casa della cultura». Pasolini verrà sepolto a Casarza, in Friuli, dove era vissuto da ragazzo. La madre del regista ha saputo solo oggi i particolari della morte del figlio. «Fino a ieri — dice l'attrice Laura Betti — avevamo parlato di un incidente stradale. Ma dovevamo spiegare cosa era successo veramente per la costituzione di parte civile. E' stato penoso e doloroso. La madre di Pasolini è stanca, vecchia e malata. Povera donna».
Fabrizio Carbone, «La Stampa», 4 novembre 1975
Pellegrinaggio della folla dov'è stato ucciso Pasolini
Curiosità morbosa fra le baracche di Ostia
(Nostro servizio particolare) Roma, 4 novembre.
Al centro c'è un barattolo di latta, rivestito di carta, con garofani rossi e crisantemi bianchi. Tutt'intorno sassi calcinati, blocchetti di tufo, pietre di diversa misura tracciano il perimetro entro cui Pier Paolo Pasolini cadde e fu investito dall'auto in fuga del suo uccisore. Nella terra sabbiosa, impastata di grumi rossastri è piantata una croce di legno ricavata da due assi sconnesse. Sotto il sole intenso appassiscono fiori sparsi, lanciati da mani pietose La gente arriva e si dispone a qualche metro di distanza. Prima osserva in silenzio, poi si avvicina al misero tumulo e punta il dito, chiede, discute. E' un pellegrinaggio ininterrotto. Da lontano si vedono le macchine parcheggiate alla rinfusa lungo via dell'Idroscalo e le strette traverse che conducono al mare. Sono auto di ogni cilindrata. Qualcuno arriva anche in autobus: uno straniero viene avanti consultando una cartina e coi giornali fra le mani. Intere .amiglie hanno scelto questa triste meta per la passeggiata festiva. Appena un'occhiata viene data alla sequela allucinante di casupole, baracche, costruzioni abusive che pullulano alla rinfusa fra le dune di sabbia.
Tutti si dirigono dritti al luogo in cui si è consumata la tragedia. I bambini avanzano saltellando, allegri. Le discussioni si accendono qua e là. Sono discorsi «tecnici». Possibile che un ragazzo di 17 anni abbia potu- i to infierire da solo su un uo- j mo forte e sportivo come Pasolini? A uccidere è stato uno, o lo hanno aggredito in parecchi? L'auto che lo ha investito aveva i fari accesi o spenti? Perché il corpo è stato trovato in questo punto: Pasolini stava fuggendo al suo aggressore o voleva inseguirlo? Appena si forma un nuovo capannello, si ricomincia daccapo. Ma i discorsi non sono, in realtà, mai uguali. Ciascuno mette qualcosa di proprio negli interrogativi che pone e nelle risposte che trova. Gusto per il particolare sadico, puntigliosa predilezione per «certi» aspetti del dramma, lambiccate ricostruzioni dellp. sequenza mortale, oscene ipotesi sui moventi dello scontro. E' una morte che suscita indecenti curiosità. Si capisce che le notizie sulla tragica notte di sabato sono state inghiottite con avidità, consumate, analizzate, scomposte e ricomposte infinite volte. La gente se ne è impossessata brutalmente, come dell'occasione per gettare lo sguardo fra le pieghe della vita privata di un personaggio illu¬ stre, contemplare e misurare le sue debolezze, sentirsi forte ora che lui è stato umiliato cesi profondamente e spogliato di tutto, anche della vita.
E c'è quel mondo oscuro — deviazione sessuale, peccato, vergogna, malavita, corruzione, vizio, genio, sregolatezza — che in Pasolini adesso s'incarna, finalmente svelato e subito punito, quindi meno pericoloso, in qualche modo esorcizzato. A visitare il luogo in cui l'artista ha perso la vita non vengono i suoi amici («Che vergogna! Neanche un regista, un attore ha portato un fascio di fiori o ha incaricato qualcuno di comprarli!» dice un vecchio e indica — unico personaggio che apparteneva all'esistenza di Pasolini — una donna rattristata, raccolta in silenzio da una parte: la sarta dei suoi film). Né si spingono fin qui coloro che sinceramente sono stati feriti da questa perdita, quanti ammiravano la genialità del poeta e del regista, si riconoscevano nelle sue battaglie. Mentre la gente si accalca intorno al povero cippo, un gruppo di ragazzini passa sulla via centrale. Hanno facce sudate, abiti sbrindellati. Ritornano da una partita di pallone. Uno di loro, l'aria proterva, gli occhi scuri bellissimi, chiede: «Ma insomma, chi era questo Pasolini? Perché tutta questa "fiera" per Pasolini?». Nessuno gli risponde. Lui sentenzia: «Era un poveraccio, ecco. Uno come noi». E prosegue per la sua strada, spavaldo.
Liliana Madeo, «La Stampa», 5 novembre 1975
Riferimenti e bibliografie:
Sintesi delle notizie estrapolate dagli archivi storici dei seguenti quotidiani e periodici:
- Giuseppe De Robertis, «Tempo», anno XXI, n. 31, 4 agosto 1959
- «Gazzetta di Mantova», 30 giugno 1960
- Fabrizio Menghini, «Il Messaggero», 8 marzo 1963
- Pier Paolo Pasolini, «Paese Sera», domenica 16 aprile 1967
- Giuseppe Sibilla, «Radiocorriere TV», 19 ottobre 1974
- Fabrizio Carbone, Liliana Madeo, n. s., Enzo Siciliano, Leo Pestelli, «La Stampa», 3 novembre 1975
- l. p. (Leo Pestelli), Luigi Firpo, Liliana Madeo, Lorenzo Mondo, Fabrizio Carbone, Furio Colombo, «La Stampa», 4 novembre 1975
- Liliana Madeo, «La Stampa», 5 novembre 1975
- «L'Unità», 6 ottobre 1984