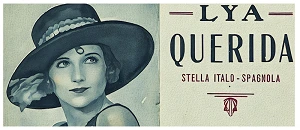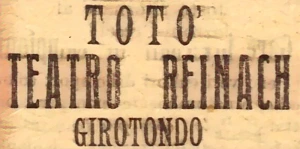Mezzo secolo di canzonette Parte 2 - Vietate agli Ufficiali le contorsioni del charleston

Si delinea il trionfo del jazz e della rivista, mentre l'operetta agonizza
* SECONDA PUNTATA *
Il successo ottenuto in Italia sin dall’inizio, il jazz lo dovette sia al nuovo genere musicale, che trovava una immediata adesione nei giovani, sia agli strumenti, attraentissimi allo sguardo prima ancora che all’udito. Il lucido sassofono, il trombone a coulisse. che s’allungava e si accorciava a tempo, il banjio, la cornetta col turacciolo della sordina, soprattutto il bass-tuba, la cui vasta gola dominava sul fondale d'ogni complesso importante, davano al nostro pubblico, specie a quello dei cinema-varietà di provincia, l’illusione di un modernismo facile, "novecento” come si diceva allora, capace di far sognare Manhattan e le luci di Broadway anche stando a Modena o a Vercelli. I pionieri del jazz, per andare incontro a questo stato d’animo, portavano dei corti dinner-jackets giallo-canarino o scarlatti, dei quali i maestri d’oggi, ligi al frack o allo smoking come solisti del conservatorio, si vergognerebbero. I primi testi, ancora fedeli alle note del pentagramma, giunti a noi verso il 1924, furono dei fox-trott oggi dimenticati: Electric girl, Lo sceicco (precedeva il film di Valentino), Seminola, Indianola e, soprattutto. I' ve no bananas. Questa canzoncina scema, che in America tanto aveva entusiasmato da render milionari gli autori, impose alle dive del nostro music-hall, già costrette a misurarsi col francese, di sbrigarsela anche con strofe in inglese, ma il pubblico solito, quello che le canzoni le fischia e ripete per la strada, non volle saperne di testi stranieri, e si assistette così, tra il 1925 e il ’27, a strani tentativi di traduzione, da parte dei nostri "parolieri", per adattare le canzoni americane più celebri alla mentalità corrente. Un inno universitario, Collegiate, divenne così Picche nicche e chi se ne fricche. In my gondola si trasformò in Non ti arrabbiare, la vita è breve, mentre, per non restare sopraffatti da questa moda in fatto di ne*ri e jazz, Rulli e Cherubini composero Johnson, storia di un moro arrivato con la sua orchestra in Italia, e così felice di quanto vi trovava da concludere: «Sbagliare geografia America esser qui», anticipando il giudizio che i suoi consanguinei G. I. avrebbero espresso vent’anni dopo.
ARRIVA JOSÉPHINE BAKER
La marcia dei ne*ri per la conquista dell’Europa continuò con l’entusiasta collaborazione degli "invasi”. Il 22 settembre 1925 sbarca in Francia, senza grandi mezzi e vestita a colori troppo vivaci, Joséphine Baker. Con un buon ballerino ne*ro, Louis Douglas, specializzato nel farsi fotografare mentre addentava delle grosse fette di cocomero, miss Baker esordisce al Teatro dei Campi Elisi nella "Black Revue" e lancia il primo charleston. Parigi va in estasi, il charleston (è Yes, sir, that’s my baby divenuto in Italia, grazie alle traduzioni di cui si è fatto cenno, Lola cosa impari a scuola) dilaga nel continente. In pochi mesi Joséphine Baker arrivò a possedere un appartamento con piscina di marmo, un’automobile carrozzata in pelle di serpente (era l’epoca delle scarpe di pitone) e una mezza arca di Noè di animali vivi e finti. Donna di spirito pratico, acuto, comprese che dipendeva da lei poter diventare una specie di istituzione parigina, come già lo era Mistinguette, e, lasciata da parte la rivista ne*ra, passò prima alle "Folies Bergère”, poi in un suo cabaret dove ballava sostituendo al tutù della grande tradizione una cintura di banane.
Sposò un siciliano dal nome quasi spagnolo, Pepito Abbatino, fece delle tournées all'estero, ma sempre per rientrare in Francia, fu uno degli argomenti del giorno per tutto il mondo, e, in un rapporto ai camerati giornalisti. Mussolini disse che era ora di smetterla con la "cosiddetta Venere nera”. Molto sensibile ai cambiamenti di gusto del pubblico, quando le danze troppo libere e il troppo famoso gonnellino di banane ebbero fatto il loro temi», la Baker passò a tutt’altro genere, mettendo in risalto una voce strana e gradevole, la sua fama uscì consolidata, e i dischi di fai deux amours e della Canne à sucre, negli anni intorno al 1930, non mancarono a quanti possedevano un grammofono a valigia o uno dei primi "radiofonobar” nel mobile di radica. Nel 1932 l’attrice venne in Italia, arrivò anche nelle città di provincia, riscuotendo consensi. Le pazzie di un giorno erano dimenticate; Joséphine, in abito lungo e accoccolata alla ribalta, canzoni sentimentali e molto orecchiabili degli ulti cantava Pretty little baby (su questo stile "aristocratico” la Baker si mantiene ancora, come s’è visto durante la sua recentissima tournée italiana).
Anche in Italia il charleston ebbe successo. Era un ballo curioso, con una figura fondamentale eseguita a ginocchia unite e coi piedi che si allontanavano verso l’esterno, dopo aver strisciato a terra come se schiacciassero qualcosa: una danza in carattere con gli abiti di lamé dorato, dalla vita lunga, e i capelli "alla maschietta" delle ragazze di allora. Molti la trovarono poco dignitosa, e infatti una circolare del ministero della guerra proibì agli appartenenti alle forze armate di ballarla in divisa, e in tal modo, nei circoli ufficiali, le orchestrine composte dà reclute e sergenti, alternarono ai molti valzer qualche fox soltanto. Più libero, De Pinedo, durante il suo volo di 55.000 chilometri sul "Gennariello”, suonava il disco americano Gorni Kramer è uno dei migliori esecutori di musica di Whof, da lui considerato un moderna del mondo: le sue doti di suonatore di portafortuna, ogni volta che le cose terra abruzzese, gli hanno dato vasta popolarità. Di lui fisarmonica sono certo eccezionali. Ha scritto molte sembravano mettersi per traverso, si devono ricordare "Campane" e "La piccinina”, canzoni che hanno avuto, però, scarsa popolarità. Neppure le nostre attrici potevano ignorare il charleston, e Lydia Johnson, volendo per la stagione 1926 un repertorio suo, disse a un giovanotto che suonava in orchestra alla "Sala Umberto”, a Roma, di scriverle qualcosa. Giovanni D’Anzi, il futuro autore della Madonnina, compose in tal modo, a vent’anni, Charlestonmania, il suo primo successo, pubblicato dalla casa Franchi, un vivaio dal quale doveva uscire gran parte del gruppo degli attuali compositori milanesi. Nello stesso 1926 Maurice Chevalier, ancora ignoto in Italia, lancia Valentine e, soprattutto, Io cerco la Titina. Di lì a poco, un altro successo internazionale: Valencia.
IL TRIONFO DI PADILLA
Già prima di allora José Padilla, spagnolo di origine, non era uno qualunque: all’opposto, fra le sue canzoni, El reliquiario (ricordava le marce dei toreador) e La violetera avevano raccolto applausi su molti palcoscenici, anche per merito dell’attrice che li aveva promossi, Raquel Meller (terzo cavallo di battaglia di Raquel Meller fu Ay ay am un canto criollo messo al bando in Italia, come menagramo). Ma il trionfo che Padilla ottenne con Valencia doveva raggiungere ben altre proporzioni: la canzonetta, tenuta a battesimo, a Parigi, dalla già allora intramontabile Mistinguette, divenne, con una intensità di esecuzioni stradali paragonabile solo a quella di Abat-jour, una specie di persecuzione sonora, un incubo. I diritti d’autore resero milioni, i giornali pubblicarono la fotografia del maestro seduto al pianoforte. Padilla seppe sfruttare il momento, fece una tournée con una sua orchestra, e annunziò che, dopo Valencia, avrebbe illustrato altre metropoli d’ogni nazione. Compose infatti, poco apprezzata, New York e, riuscitissima, Qa c’est Paris, prescelta per anni, da Mistinguette, come inno personale. Cogliendo l’occasione, l’editore Franchi invitò Padilla a comporre la canzone dedicata a Roma: su parole di De Torres e Simeoni apparve così Fontane, l’ultimo successo del musicista spagnolo: e su Fontane, la fama di Padilla lentamente si dissolse.
La Spagna era tornata di moda, e i nostri compositori non lasciarono cadere l’argomento, coltivando un filone che ancor oggi dà i suoi frutti. Uomo di spirito, Cherubini è il primo a sorridere delle parole da lui date a Passione madrilena di Stocchetti, non troppo diversa, come racconto, da Notti sivigliane (c’è un "torvo bandolero” che esclama: «Giù le nacchere, questa donna è per me»). Mentre la canzone a carattere nostrano segnava un punto a favore col Fox della nostalgia di Rulli e Cherubini (apparso nel 1925, ma rimasto a lungo in repertorio, sentimentale e patriottico com’era, per la vicenda degli emigranti di ritorno dalla "sponda argentina”), nelle sale da ballo il charleston si trasformava in black-bottom.
L’operetta piaceva ancora molto. Al "Nuovo" di Verona, Gondrano Trucchi riusciva a portare avanti la stagione con due soli spartiti, Paganini di Léhar e La principessa del circo di Khalmann, e tuttavia i sintomi di una prossima decadenza non avrebbero dovuto sfuggire agli osservatori. Ciò apparve chiaro nell’autunno del 1927 quando la tournée del Teatro Mogador di Parigi portò in Italia No, no Nanette, dell'americano Vincent Youmans, già noto per un fox non ancora cancellato del tutto dai programmi, Hallelujah. Nella nuova "operetta trepidante” la vecchia impalcatura dello spettacolo andava in pezzi, non v’erano più prima donna, tenore e brillante, ma degli attori comici capaci di recitare con naturalezza, e soprattutto, accanto a un corpo di ballo femminile, apparivano dei boys ben diversi dalle solite comparse reclutate sul posto: anche gli abiti di questi "ragazzi” (lo smoking a doppio petto, la giacca azzurra coi bottoni d’oro sui calzoni bianchi) portavano un desiderio di novità, in fatto di abbigliamento, tra i frequentatori delle barcacce e della balconata. No, no Nanette influì solo indirettamente sui gusti del pubblico, i due pezzi fondamentali, Tea for two e I wont to be happy non conquistarono mai le "balere” della periferia, ma l’importanza di questo spettacolo fu decisiva perché molti rilevarono come la musica facile potesse essere indirizzata su strade a fondo intellettuale. Di ciò si avvide, in un primo tempo, l’alta borghesia. Mentre Ripp diffondeva nelle vie Creola («straziami, ma di baci saziami») nei salotti in penombra e negli appartamentini dei figli di papà, i grammofoni a molla e quelli elettrici (nei primi, per attutire il suono non graduabile, si cacciava un asciugamano nella tromba) ripetevano per gli iniziati, capaci di apprezzare le sfumature di certe esecuzioni come gustavano i primi cocktails e il whisky nel bicchiere a tubo, i dischi dei Revellers (un quartetto ne*ro di cui più non si parla) di Elena Kane, Old man river e gli altri motivi di Show boat cantati da Robeson ecc. Queste preferenze, diffuse in seguito in un ambiente più vasto, ma tuttavia sempre limitato (e la scoperta di St. Louis blue darà l’indirizzo definitivo a questa tendenza) operarono una scissione profonda, rimasta per decenni e non ancora scomparsa, fra chi dalla canzonetta era risalito al jazz puro (bisogna aver visto la fila di quanti attendevano d’entrare, l’anno scorso, all' "Odeon” di Milano nei giorni in cui suonava Armstrong, per comprendere, dalle espressioni dei visi, cosa sia un contenuto, ma incrollabile fanatismo) e la grande massa, desiderosa, come un tempo, di canzonette facili da canticchiare senza pensarci su. È infatti proprio mentre il clan degli amatori di jazz-hot comincia a formarsi, che il pubblico di periferia decreta, tra il 1926 e il 1928, il trionfo di un genere definito, negli ambienti tecnici dei canzonieri, addirittura "sociale”. A catena, i successi si inseguono: Spazzacamino, La meridiana, il Valzer di Mimosa di Ermenegildo Rusconi (è uno degli assi del genere), Miniera e Ferriera di Bixio Cherubini, via via fino a Campane di Di Lazzaro, si sussegue la serie delle vicende patetiche, con forgiatori investiti dal fuoco traditore, minatori sepolti e bimbi a piedi scalzi nella neve.
LA SCOMPARSA DI RULLI
Non si parlava ancora di film sonoro, nel 1927, ma già nasceva spontaneo il desiderio di completare lo spettacolo con della musica, sia pure affidata alle orchestrine, adatta alla vicenda della pellicola. Dall’America, Ramona, interpretato da Dolores Del Rio, si portò dietro un valzer che piacque tanto da riuscire a rimettere in voga questo ballo nelle sale dominate dal charleston, e con tanta fortuna da invogliare Dino Rulli, a comporre, di lì a poco, due canzoni per film: Maruska, altro valzer per Dolores Del Rio, e, pezzo melodico di indubbio valore. Appassionatamente per la prima edizione di Settimo cielo, diretto da Borzage e interpretato da Charles Farrell e Janet Gaynor. Il pubblico accolse con vero entusiasmo queste composizioni (la seconda non è ancora dimenticata), ma purtroppo l’opera di Dino Rulli stava per concludersi. «Era il Puccini del nostro gruppo», dice di lui il maestro Cherubini. «Se fosse vissuto, certamente sarebbe un nome di primissimo piano: già allora era celebre e guadagnava bene». A trentadue anni soltanto, buono, affabile, sorridente, Rulli morì. Meno popolari delle canzoni, egli lasciò due operette, I vagabondi delle stelle e La ragazza della penombra, oltre a musica sinfonica e da camera. «Figlio, figlio», ripeteva sua madre, abruzzese come lui, «perché m’hai lasciato così presto?».
Il film sonoro nasce ufficialmente nel 1928 mentre, liberandola dagli altoparlanti di ebanite nera, la radio inizia il suo consumo giornaliero di musica. Fu quella l’epoca dell’intensa, invadente passione per il ballo. Nei circoli rionali, nei caffè, negli atrii degli alberghi, ovunque ci fosse posto disponibile e un pavimento adatto, si impiantava una pista da ballo, le veglie seguivano, quasi giornalmente, i tè danzanti, e, alla "Certosina” di Sanremo, persino gli aperitivi danzanti fra le undici e mezzogiorno. La orchestrina jazz, limitata a quattro o cinque elementi, trovava posto in un angolo, sopra una pedana molto stretta. Jack Hvltoh, altro divo del jazz di allora, lanciò il vezzo di dirigere senza bacchetta, e presto i palcoscenici di varietà si popolarono di orchestre che, animate da una specie di forzata allegria collettiva, "agivano” dietro alle spalle dei "numeri”, guidate da un maestro in perpetua agitazione, che, scuotendo le spalle a tempo, sventolava le mani in aria. In Italia, il primo a portare l’orchestra sul palcoscenico fu Mario Latilla che creò anche il genere della "canzone ambientata”, cioè interpretata con un quadro animato e suggestivo, che faceva da accompagnamento e commento alla musica. Al Casinò di Sanremo, il giovane maestro Barzizza, già con gli occhiali ma dotato d’una bella chioma, dirigeva, in smoking, l’orchestra Blue Star nell’esecuzione di Gigolò, tango di Casucci molto apprezzato specie in Germania, e Chiudi gli occhi Rosita, di Marf-Cherubini. La canzone in lingua spagnola sembrava avesse fatto il suo tempo quando, a rimetterla in piena luce, giunse in Italia, sul finire del 1928, Eduardo Bianco col suo complesso tipico, una quindicina di giovanotti in autentico costume argentino, pantaloni neri ricamati a rose scarlatte, grandi fazzoletti di seta candida, cinture decorate con monete e ferri di cavallo. Bandoneon, chitarre, violini, fisarmoniche intarsiate di madreperla, sembrarono detronizzare la musica sincopata, i gauchos appiedati di Bianco imposero, con i lenti inchini e i sospiri nella presentazione di Piegaria, Adoracion, Crepuscolo, Pasion, Adios muchachos e, più tardi, Cominito, uno stile nuovo, meno sbrigativo e pieno di nostalgie inespresse. La risposta italiana non tardò: Tango delle capinere di Bixio Cherubini («A mezzanotte va la ronda del piacere»). D’altra parte, perché non si ha sempre voglia di essere tristi, al Tango appassionato («tu che mi lascerai la febbre nelle vene» ) fece riscontro una serie di fox umoristici: Tre, Paga Giovannino, Biagio adagio, Si fa ma non si dice.
L'operetta agonizza. Nel gennaio 1930, un grande manifesto arancione a lettere nere copre la facciata dell’ "Excelsior" di Milano: «Za Bum presenta le cinquanta più belle donne d'Europa». È il primo spettacolo Schwarz, quello che porterà, una stagione dopo l'altra, alle messe in scena sfarzose del Cavallino bianco e di Casanova, abituando il pubblico milanese all'attuale esigenza in fatto di belle donne e costumi lussuosi. Il 1930 è ancora l’anno in cui il film sonoro, uscito dalla fase sperimentale, entra in quella positiva. In settembre la "Cines Pittaluga” lancia La canzone dell'amore, così legata al leit-motiv di Bixio Cherubini, che le ragazze dei laboratori chiamano senz’altro, questo primo esemplare italiano, "la pellicola della Lucia”. Negli stessi giorni si proietta Il principe consorte di Lubitsch. C’è una marcia dei granatieri, nel film, che piace senza dubbio alle nostre altissime gerarchie, cosicché, molti spettatori di buona memoria, hanno la sorpresa di ascoltare, mesi dopo, le stesse note militaresche e birichine, che già diedero palpiti alla gola di colomba di Jeannette Mac Donald, uscire dagli austeri ottoni della banda della P.S. durante le marziali sfilate degli agenti davanti al capo del governo.
Massimo Alberini, «Oggi», 4 maggio 1950
 |
| Massimo Alberini, «Oggi», 4 maggio 1950 |