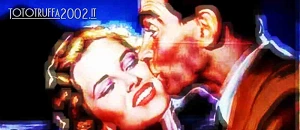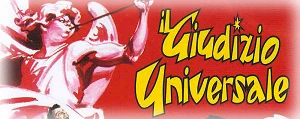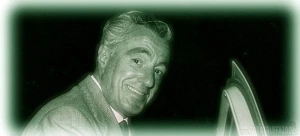Vittorio De Sica, il gentiluomo in passerella

I registi italiani che hanno sconfitto Hollywood. A sessantanni, dopo aver diretto diciassette film ed averne interpretato una novantina, il regista ha scoperto una nuova parte da recitare: quella dell’artista ormai avviato sul viale del tramonto. Ma a smentirlo ci sono i progetti dei quattro film che si prepara a dirigere uno dietro l’altro
Roma, gennaio
La prima volta che lo vidi fuori dagli schermi fu allo Sherry-Netherland Hotel di Nuova York. Era seduto al bar e gli avevano messo vicino un telefono candido che suonava ogni cinque minuti, anzi, ogni volta che lui rimetteva giù la cornetta. Adoperava la mano destra per il telefono e la sinistra per reggere il Post. «Yes — diceva a ogni chiamata, nel suo orribile inglese — yes, darling, I love you. Yes cocca». Il barman andò a portargli una bibita-. «Non la lasciano mai in pace, eh?». «No — disse lui — non mi lasciano mai in pace. Le donne. Sempre le donne. Mi cercano. Le sente? eccone una altra. Signore Iddio, che pazienza». Sorrideva, bello e beato. Il neon gli dava riflessi azzurri ai capelli che erano d’un bianco lavato nell’indaco e il viso aveva una patina ramata da vacanze sui ghiacciai. Ero lì ferma a guardarlo quando fui lanciata contro un muro. Un’orda di donne mi travolse, un’orda irsuta di "biro” snudate e di bocche urlanti «Vittorioh, Vittorioh, oh darling, how wonderful». Io fuggii da un’altra porta e lui, almeno così mi disse il barman, fu poi salvato dai pompieri, ma io non lo incontrai più fino all’altro giorno, a Roma, quando andai a trovarlo negli uffici di Ponti per metterlo tra i ”miei” registi che hanno sconfitto Hollywood.
 Nato a Sora, in provincia di Frosinone, il 7 luglio 1902, Vittorio De Sica (che però ama definirsi napoletano d'elezione) prima di giungere al cinema è stato uno dei più brillanti attori di prosa italiani. Il suo esordio sugli schermi risale al 1932, con la "Segretaria per tutti", al quale ha fatto seguito la serie dei film sul mondo piccolo-borghese diretti da Mario Camerini: "Gli uomini che mascalzoni", "Darò un milione", "Grandi magazzini" che hanno fatto di De Sica uno dei divi più popolari degli anni che hanno preceduto la seconda guerra mondiale. Fece la sua prima prova come regista nel 1940, dirigendo "Rose scarlatte". De Sica, dopo la separazione da Giuditta Rissone, dalla quale ha avuto una figlia, si è unito a un’altra attrice, Maria Mercader, dalla quale ha avuto due bambini.
Nato a Sora, in provincia di Frosinone, il 7 luglio 1902, Vittorio De Sica (che però ama definirsi napoletano d'elezione) prima di giungere al cinema è stato uno dei più brillanti attori di prosa italiani. Il suo esordio sugli schermi risale al 1932, con la "Segretaria per tutti", al quale ha fatto seguito la serie dei film sul mondo piccolo-borghese diretti da Mario Camerini: "Gli uomini che mascalzoni", "Darò un milione", "Grandi magazzini" che hanno fatto di De Sica uno dei divi più popolari degli anni che hanno preceduto la seconda guerra mondiale. Fece la sua prima prova come regista nel 1940, dirigendo "Rose scarlatte". De Sica, dopo la separazione da Giuditta Rissone, dalla quale ha avuto una figlia, si è unito a un’altra attrice, Maria Mercader, dalla quale ha avuto due bambini.
Lo trovai seduto su un divano verde, con un dipinto del Settecento dietro la testa, un abito Principe di Galles e i calzini neri a pois bianchi.
«Ha visto — ruggì — ha visto cosa scrive?».
«Chi?».
«Marotta. Giuseppe Marotta. Don Peppino. Ah, ma gliela farò pagare. Sarò implacabile. Del resto l’ho già querelato. Non doveva permettersi di insultarmi così. Per una canzone, capisce?, per una canzone bocciata a Sanremo, neanche gliel’avessi bocciata io. Si chiamava Lucciole nel grembo, o qualcosa del genere. Non era brutta, anzi io mi sono perfino battuto. Che colpa ne ho se non ce l’ha fatta? E guardi come mi chiama. Iridato farfallone, mi chiama. Le sembro un farfallone? Le sembro iridato?».
«E’ tutto qui?».
« Tutto qui? Senta, senta: Lui che non distingue Pascoli da Stecchetti e un endecasillabo da un verme solitario. Pfui. Mi fa quasi ridere. Anzi mi fa decisamente ridere. Ohi ohi che ridere. E io che gli ho fatto anche L’oro di Napoli. Un endecasillabo da... ohi che ridere, vada avanti lei perchè io non posso, mi viene troppo da ridere».
« ...soltanto il cinema, che è il paese degli equivoci, poteva convertire in una montagna d’oro l’insolvenza letteraria del nostro don Vittorio...».
«Ohi ohi, ah ah».
«...questo poeta arido come un sughero...».
«Vada avanti, vada avanti».
«...questo erudito ti cut scibile non colma un ditale...».
«Ah ah ah».
«...questo iridato farfallone...».
«Ohi che ridere».
«Scusi, ma se si diverte tanto, perchè lo vuole querelare?».
«Perchè impari».
«Marotta? Nessuna querela gli potrà togliere il gusto di litigare. Lo fa con amore, con passione. E’ il suo fascino».
«E’ matto — dice De Sica. — E io che gli ho fatto anche L’oro di Napoli. Lei l’ha visto L’oro di Napoli? Non era neanche riuscito male. Non è il film che preferisco, ma gli sono abbastanza affezionato».
«Qual è quello che peferisce?».
«Umberto D. Il film che non è riuscito neppure a tirare su le spese delle copie».
C’è da restare senza fiato. Umberto D., uno dei film più i belli della storia del cinema mondiale, non è riuscito neppure a tirar su le spese delle copie. In che mondo siamo?
«Non lo so in che mondo siamo — dice — ma certo la roba buona va poco. Anzi, ora la situazione è molto migliorata. Il pubblico manda giù cose per le quali una volta avrebbe chiesto il rimborso del prezzo del biglietto. Io non so se la gente si sia fatta un po’ il palato, o se sia una forma di snobismo: comunque ora trangugiano anche i film "artistici". Forse, i miei, io li ho fatti troppo presto. Li dovevo fare ora. L’alienazione, l’incomunicabilità, li avevo già inventato prima di Antonioni, al tempo di Umberto D».
Vittorio De Sica, anche dopo essersi imposto come uno dei più rappresentativi esponenti del neo-realismo cinematografico italiano, non ha rinunciato alla recitazione, alternando la sua attività di regista a quella d’attore. I primi film diretti da De Sica, "Maddalena zero in condotta". "Teresa Venerdì”, "Un garibaldino al convento", rivelavano una vena leggera e romantica che scomparve solo verso la fine della guerra, quando realizzò "I bambini ci guardano".
«Potrebbe rilanciare qualche vecchio film e riprendersi oggi i soldi che non ha incassato allora».
«Eh, già. E’ proprio quello che volevo fare, ma guardi la scalogna: sono andato a tirare fuori Ladri di biciclette e ho scoperto che il negativo s’è ristretto. Non si può proiettare».
Mi spiegò una complicata storia di buchi che da quattro s’erano ridotti a tre, o qualcosa del genere, ma io ci capii poco. Quello che non riuscivo a mandar giù era che la celluloide si ritirasse come una tela bagnata, ma lui disse che era proprio cosi. Disse che l’unica sua speranza era quella di trovare un controtipo da qualche parte, forse in Inghilterra, perchè j gli Inglesi sono i soli che sappiano tenere da conto le cose. Ecco un lavorino per loro nel quadro del Mercato Comune: I tenerci in ordine le opere d’ar-
te, che facciamo tanto bene e conserviamo così male. «Ma che ci sta a fare il Ministero per lo Spettacolo? Solo per trastullarsi con la censura? René Clair e io abbiamo fatto una proposta: il governo deve obbligare le Case cinematografiche a consegnare la copia di ogni film a una cineteca nazionale, press’a poco come si fa per i libri e per i dischi, altrimenti non si salverà niente».
Sapevo che una giuria di esperti, tempo fa, ha compilato a Bruxelles un elenco di film da salvare? Sapevo che al primo posto c’è La corazzata Potiomkin di Eisenstein e al secondo, pari merito. La febbre dell’oro di Chaplin e il suo Ladri di biciclette? E che una seconda giuria, composta di giovani della nouvelle vague, ha addirittura messo Ladri di biciclette al primo posto e La corazzata Potiomkin al secondo?
«Commendator De Sica — disse una ragazza mettendo la testa dentro la stanza — la chiamano da Parigi».
Si alzò e usci da una porta imbottita di stoffa verde come il divano, e siccome la lasciò socchiusa io buttai là un occhio e vidi un salone pieno zeppo di sculture. Mi affacciai. Lui non c’era, doveva avere infilato ancora un’altra porta e allora entrai: c’erano teste enormi di pietra che dovevano essere molto antiche, e quadri del Settecento e nel fondo una grande scrivania con uno scaffale tutto pieno di volumi della Plèiade che avevano tutta l’aria d’essere stati comperati, sistemati lì, e non più toccati da dita umane, ma solo da piumini per la polvere. In quel momento lui ritornò, e anche se fu un po’ stupito di trovarmi lì non lo dette a intendere per nulla, anzi, fece un gran bel sorriso. «Le pia e?» chiese, e poi mi accompagnò vicino alla finestra che dava sulla scalinata della chiesa di Aracoeli e sul Campidoglio e sembrava una copertina di Connaissance des Arts.
«Com’è fortunato», gli dissi.
«Oh, ma lei crede che sia il mio studio? Che follìa. E’ di Ponti. Se io avessi uno studio con una finestra così non uscirei mai, starei sempre seduto su quella poltrona e non combinerei più nulla».
Andò a sedersi sulla poltrona per provare. La poltrona gli donava molto. Era grande, ben fatta, ricoperta di tessuto gobelin a fiori colorati su fondo nero. Non so come questo ambiente incornici un tipo come Ponti, ma sono sicura che si addice molto di più a Vittorio De Sica.
«E lei dove abita?» chiesi.
«Ecco, io di case ne ho più d’una, veramente, ma posso dire di abitare in Via della Consulta, dove ho una specie di pied-à-terre.
Nella sua lunga carriera Vittorio De Sica (che è fotografato in queste pagine a Roma sulla scalinata di Trinità dei Monti) ha ottenuto quasi tutti i maggiori premi italiani e stranieri. Oltre a numerosi "Nastri d’argento” ed a due "Grolle d’oro” che hanno premiato la sua attività d’attore e di regista, De Sica ha ottenuto due volte, con "Sciuscià” e "Ladri di biciclette”, l’ "Oscar” per il miglior film straniero presentato negli Stati Uniti. Il film al quale il regista confessa di essere più affezionato è "Umberto D." che racconta il drammatico e solitario crepuscolo di un pensionato abbandonato dalla società e dagli uomini.
Gli chiesi se anche lui avesse la passione delle sculture, ma disse di no. Preferisce i quadri. Nonostante la sfiducia di don Peppino Marotta nella cultura di De Sica, bisogna dire che almeno in fatto di quadri ha una preparazione e un gusto piuttosto solidi, e ha messo insieme una buona collezione. Gli feci i miei complimenti: «Lei ha realizzato molte cose, nella vita: una quantità di quadri, tre figli, una novantina di film come attore e diciassette come regista».
«Diciassette? I sequestrati di Altona era il mio diciassettesimo film?». Li ricontò sulla punta delle dita: Due dozzine di rose scarlatte, Maddalena zero in condotta, Teresa Venerdì, Un garibaldino al convento, I bambini ci guardano, La porta del cielo, Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, Umberto D., Stazione Termini, Il tetto, L’oro di Napoli, La ciociara, Giudizio universale, Boccaccio ’70, I sequestrati di Altona. «Eh già. Se non ne ho dimenticato qualcuno, I sequestrati è proprio il diciassettesimo».
«Lei è superstizioso?».
«Molto. Moltissimo. Non vorrei avere una cosa viola per tutto l’oro del mondo. E anche il 13 mi piace poco. Ma soprattutto il viola. Sono superstizioso come tutti i napoletani».
Non ho mai capito perchè De Sica si ostini a dire che è un napoletano. E’ nato a Sora. in Ciociaria, da un padre sardo e da una madre romana. Ha perfino la nonna fiorentina. «Ma io sono napoletano — dice; — lo sono dentro».
«Va bene. Torniamo ai Sequestrati. Prima di tutto vorrei sapere se Altona si pronuncia con l’accento sulla prima ”a’’ oppure con l’accento sulla ”o”».
«E proprio da me lo vuol sapere? Non si ricorda quello che ha detto don Peppino a proposito della mia insolvenza letteraria?». Poi cedette e disse che si poteva pronunciare sia in un modo, sia nell’altro. In Germania dicono Altona con l’accento sulla ”a”. Ma noi italiani possiamo anche pronunciare Altòna. Per quanto riguardava il film, be’, ammetteva che lui e Sartre non avessero gran che in comune. Ma Ponti aveva acquistato i diritti e anche Sartre aveva piacere che il regista fosse lui. E lui aveva voglia di farlo perchè c’era dentro quella protesta contro il nazismo che gli andava parecchio a genio.
«E la Loren?».
Le critiche dei benpensanti
Già, la Loren. Così brava, povero angelo, e questa volta così poco capita dal pubblico. «Hanno detto che ha recitato con l’accento napoletano. E pensare che lei il film l’ha girato in inglese e lo sanno tutti che l’inglese di Sofia è perfetto. Oddio, forse nel doppiarlo un po’ di Napoli ce l’avrà anche messo, ma perchè hanno badato tanto a questa stupidaggine e così poco alla bravura di lei che ha dovuto fare un personaggio difficile e quasi di secondo piano? L’umiltà di Sofia nell’accettare quella parte è stata grande. Crede che tutti gli attori si adattino? E poi è facile fare un grande personaggio che si regge anche da solo, mentre è difficile farne uno più piccolo che ha bisogno
di reggersi sulla bravura dell’attore».
Certo, l’umiltà di Sofia è stata grande, ma cosa avrebbe fatto se il film non fosse stato di Ponti? Mah.
«Quanto mi piacerebbe — dice De Sica — se Sofia mi facesse Assunta Spina. E’ un personaggio adattissimo a lei. Una cosa a forti tinte, sa, dalla commedia di Salvatore Di Giacomo. La prima volta lo fece Francesca Bertini».
«Perchè non fa comperare i diritti da Ponti?».
Non mi rispose. Era riapparsa la solita ragazza e l’aveva chiamato per il solito telefono. Quando tornò gli chiesi se voleva uscire un pochino, altrimenti non saremmo mai andati avanti. Quello non era un dialogo, era un colloquio a tre: lui, io e il telefono. Cosi uscimmo e andammo a passeggiare sulla piazza del Campidoglio. Sarebbe stato meglio rimanere in ufficio. Perchè lì al Campidoglio incominciarono a girargli intorno i turisti che volevano fotografarlo con Marc’Aurelio e coi ruderi e lui doveva anche firmare gli autografi agli americani, agli svizzeri e anche a un paio di giapponesi o filippini, chi lo sa. Comunque questo fatto gli dette lo spunto per dire che il cinema non sarà magari un’arte, ma è certo un linguaggio che avvicina i popoli. Spiegò che Sciuscià, per esempio, consentì all’Italia del dopoguerra di riprendere un dialogo con i francesi, i quali apprezzarono il nostro coraggio nel mettere a nudo le piaghe anche contro il conformismo di certi ”bempensanti’’.
«Mentre giravo in via Veneto quella scena di Sciuscià dove il bambino pulisce le scarpe all’americano, passò un signore e mi disse: "Lei non si vergogna di fare un film su queste cose?”. ”No — gli risposi — non mi vergogno di fare un film su queste cose. Mi vergogno che queste cose esistano”».
Anche Ladri di biciclette fu un film coraggioso. Da un punto di vista economico non andò nè bene nè male, ma all'estero ebbe un certo successo. In Italia pochissimo. «La sera della prima al Metropolitan di Roma — racconta De Sica — io morivo di paura e non me l’ero sentita di assistere alla proiezione, ma a un certo punto non ce la feci più a stare in casa e andai là per vedere come si mettevano le cose. Mi fermai nell’ingresso e chiesi a una maschera di chiamare il direttore. Proprio mentre lui arrivava vidi un gruppetto di persone che veniva fuori dalla sala. Mi nascosi dietro una tenda e sentii uno gridare: ”A diretto’, ma je sembrano filmi da facce vede? C’iaridia li sordi, avemo speso duecento lire a testa, semo quattro, so’ ottocento lire: nun se possono mica buttà ottocento lire pe’ ’sta bufala”».
Per Ladri di biciclette fu coniata anche una barzelletta che a quei tempi ebbe molto successo: un toro si presenta al botteghino del Metropolitan e domanda alla cassiera: «E’ vero che qui danno una bufala». La "bufala”, oggi, è uno dei dieci film da salvare, con La corazzata Potiomkim, La febbre dell’oro, La grande illusione e roba così.
«Tutto sommato — dice De Sica — la colpa è mia se non faccio soldi, perchè io preferisco gli attori presi dalla strada, e quelli non chiamano pubblico. Ma a me gli attori veri sembrano poco convincenti. Ha visto invece com’èra convincente Maggiorani in Ladri di biciclette? Sembrava così vero che dall’America hanno continuato per anni a mandarmi lettere con un dollaro dentro da dare a Maggiorani perchè si comperasse un’altra bicicletta».
Maggiorani era un operaio della Breda, De Sica lo vide e lo fece chiamare. Gli disse che lo voleva per un film, ma si fece dare la parola d’onore che dopo il film sarebbe ritornato a fare l'operaio. «Tu non sei un attore — gli disse. — Ora mi servi per un film, ma non sei un vero attore. Prometti che tornerai a fare il tuo lavoro». Maggiorani prese un permesso di tre mesi, fece Ladri di biciclette e in quel periodo gli andarono via tutti i calli che aveva sulle mani, così quando ricominciò a lavorare come prima gli vennero le bolle e lui andò a farle vedere a De Sica per dimostrargli che aveva mantenuto la promessa. Dopo sei mesi lo licenziarono per riduzione di personale. Allora riprovò col cinema, ma non gli andò bene come sperava e così aprì un negozio di calzolaio.
«Gli va bene?».
«Non credo. Le ultime notizie non erano gran che buone, poveraccio».
«E Pricò? Quello che fece l bambini ci guardano?».
«D’Ambrosio? Ora è un giovanotto. Fa il doppiatore alla C.D.C.».
«Era straordinario. Ma come ha fatto a cavargli fuori quelle espressioni, quei singhiozzi? A quel tempo doveva avere cinque anni, sei al massimo. Io penso che i bambini non dovrebbero essere sottoposti a certe torture».
«Sì, a volte i sistemi sono un po’ crudeli. Con il bambino di Ladri di biciclette, mi ricordo, fummo proprio cattivi. Un operatore gli mise in tasca una manciata di cicche senza che se ne accorgesse, poi lo portò davanti alla macchina da presa e gliele tirò fuori sotto gli occhi fingendo molta sorpresa. ”Ma che fai, idiota — gli disse — ma che fai, vai in giro a raccogliere cicche come un pezzente? Non ti vergogni?”. Il bambino era esterrefatto, non capiva più niente e si metteva a piangere come un disperato, coi lacrimoni che gli scendevano fin dentro il colletto. Oppure gli si fanno dei regali e poi si rompono sotto i loro occhi, e gli si tolgono di mano all’improvviso. Sì, i sistemi sono un po’ crudeli».
Nonostante ami atteggiarsi a regista della "vecchia guardia" che ha ormai terminata la sua missione, De Sica è ancora uno degli artisti del cinema italiano più popolari e stimati all’estero. Negli ultimi anni, dopo un periodo di silenzio seguito agli scarsi successi di "Stazione Termini” e ”Il tetto”. De Sica ha ripreso con ”La ciociara” e ”Il giudizio universale” la sua attività di regista. L’ultimo film da lui diretto, dopo l’episodio della "Riffa” in "Boccaccio 70”, è ”I sequestrati di Altona”. In tutti i suoi film il regista si è avvalso della collaborazione, come soggettista e sceneggiatore, di Cesare Zavattini, che in questo momento sta lavorando attorno ai soggetti di quattro film: ”I figli di Sanchez” con Sofia Loren, ”Una nuvola d’ira”, ispirato al romanzo di Giovanni Arpino, ”Il boom”, imperniato su Alberto Sordi, e ”Il diario di una donna” con Silvana Mangano che costituiscono il nutrito programma per il 1963 di De Sica.
Già, fanno così anche certi fotografi. Ne conosco uno che durante il terremoto dell’Irpinia girava con le tasche piene di caramelle per darle ai bambini piccoli e poi strappargliele proprio quando stavano per mettersele in bocca. E loro giù a piangere e lui giù a scattare foto "strazianti”.
Un programma nutrito
«Eh — dice De Sica — ma io dopo li coccolavo, li abbracciavo, li consolavo, li riempivo di regali. I bambini mi hanno sempre voluto bene e io li adoro. Forse per questo riesco sempre a fargli fare quello che voglio».
Il suo amore per i bambini è proverbiale come il suo amore per le donne alle quali, probabilmente con sistemi più o meno simili, riesce sempre a far
fare, appunto, quello che vuole. I posteri potranno dire di lui: fu un gran signore, amò fortemente la vita. Ma prima di tutto, da vero gentleman, amò le donne e i bambini.
Riesce, però, a ottenere ciò che vuole anche quando si tratta di vecchi professori di lingua latina, come Carlo Battisti, l’interprete di Umberto D. «Con lui da principio fu molto difficile — racconta. — Io parto sempre dal presupposto che in ognuno di noi c’è un bisogno di istrionismo, che tutti, più o meno, sono capaci di recitare. Basta pensare al carnevale; c’è qualcuno cui non piaccia mettersi i nasi finti? Con lui, però, la cosa non funzionava. Non ne voleva sapere. Era un professore, non voleva perdere la sua dignità. Io gli dicevo che si trattava di un film serio, di una protesta, di un tentativo d’aiutare i vecchi soli e inutili. Ci volle molto tempo prima che si convincesse. E quando finalmente arrivò agli studi era così confuso e agitato che portava due cravatte una sull’altra. A un certo momento dovemmo prenderlo al volo perchè stava per uscire dalla finestra invece che dalla porta. Poi se la cavò meravigliosamente».
«Che fa ora?».
«E' a Firenze. Credo sia in pensione».
Umberto D., spiega De Sica, è il film dell’indifferenza. Dopo la guerra ci sono stati tre periodi: la disperazione, l’indifferenza, l’angoscia. Ai tempi della disperazione lui fece Ladri di biciclette. Dopo venne l’indifferenza e lui fece Umberto D. Ora è il tempo dell’angoscia, ma lui non ha più fatto film impegnati. Si è preso una lunga vacanza. Gli chiedo se ne farà ancora e dice che non lo sa. E’ disoccupato. Cioè doveva fare un film al Messico, I figli di Sanchez, ma il governo messicano ha messo il veto. Forse andrà a girarlo in Guatemala. Poi dovrebbe fare Una nuvola d'ira, dal romanzo di Arpino.
«Perchè non fa Delitto d'onore, oppure La suora giovane? — chiedo. — Una nuvola d’ira è brutto».
«Eh, ma c’è dentro quel problema così italiano e così grave dell’impossibilità di divorziare. E’ grave, apra i giornali e vedrà. Tutti i giorni c’è qualche marito che ammazza la moglie e viceversa. Quanti siamo in Italia, cinquanta milioni? Be’, siamo cinquanta milioni di prigionieri. Bisogna pure che se ne parli».
Poi farà Il boom, con Sordi, un film grottesco, sulla manìa che ha la gente di spendere più di quello che guadagna, sulle cambiali eccetera. Ci voleva mettere dentro anche Silvana Mangano, ma poi ha pensato di conservarsela per un film più adatto a lei, come Il diario di una donna. Poi c’è Bronston che vorrebbe una decina di episodi sulla Parigi del 1898, ai tempi di un altro "boom” economico. E non è finita, perchè ha in mente anche tre sketch con Sofia, che impersonerà tre donne: ima napoletana, una romana e una milanese.
Traversiamo la strada, il vigile lo riconosce e ferma il traffico facendogli un gran saluto: «Passi, signor De Sica». Lui sorride, ringrazia. Forse per lui tutto il mondo è un set, o un palcoscenico. O forse, chi lo sa?, una passerella.
Mirella Delfini, «Tempo», anno XXV, n.4, 26 gennaio 1963
 |
| Mirella Delfini, «Tempo», anno XXV, n.4, 26 gennaio 1963 |