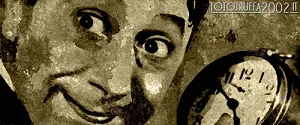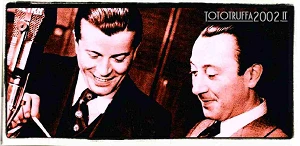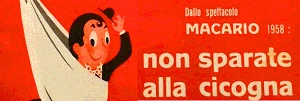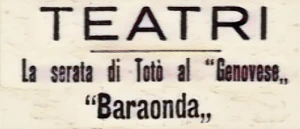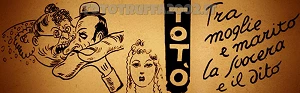Teatri: Macario

Di solito quando si scrive di un attor comico è per farlo rientrare negli esempi della propria definizione della comicità : e si sa bene come questa sia un capitolo della psicologia nel quale è facile affondare sino alle ginocchia e restare in attesa di soccorsi, senza potersi muovere (anzi appunto per l’amore di questi pericoli abbondano gli escursionisti).
La stessa impresa, con molta ingenuità, eravamo convinti di poter tentare entrando nella sala del teatro Valle per vedere in carne ed ossa quel Macario che già avevamo ammirato sugli schermi. Abbiamo detto in carne ed ossa ma sarebbe stato più esatto dire : a colori. Se un elemento, infatti, è potuto sfuggirci per il giudizio guardando Macario nei film, questo è appunto il suo candido e prospero colorito. Colorito che si spande dal viso sugli abiti e si concreta in certi completi grigio perla e marroncini o addirittura pomodoro, in camicie bianche a pallini rossi, in onesti cappellucci domenicali di un gusto ormai dimenticato e che danno, al solo vederli, la malinconia delle fotografìe fatte nella prima infanzia.
Questo controllato cromatismo, in altro campo divenuto appannaggio dei pittori «tonali», Macario se lo ritrova nella condotta di scena e potrebbe dirsi una prova del nove della sua castissima ispirazione: poiché non vedendo bene quanto questa influenzi quello (e viceversa) si arriva a concludere che tutti e due nascono da una sincera disposizione dell’attore verso il «suo» mondo. In breve il candore di Macario non è voluto c claunesco, ma naturale e frizzante, autobiografico.

Potrebbe, questo, essere un demerito, in teoria: in pratica, per gli scopi che si prefigge l’attore, si cambia in una vera benedizione.
Verso la fine dello spettacolo, quando il pubblico sta mostrando di più divertirsi, Macario domanda al suo compare (l’infaticabile attore Rizzo) perché la gente ride e applaude. «Perché si diverte», risponde quello. «Impossibile», osserva Macario melanconicamente, «i critici dicono che io non riesco a divertire nessuno».
L’altra sera poco è mancato che il pubblico prendesse in braccio e confortasse il suo beniamino, tanto la sua frase pareva nascere dal risentimento di chi non riesca a consolarsi di una ingiustizia inutile. La sala applaudì a lungo, dimostrandosi in confortante opposizione con la critica ufficiale e allora Macario finì lo spettacolo con la maggiore grazia possibile, maldestro e commosso come se gli avessero ridata la fiducia nel mondo, senza la quale un attor comico può correre il rischio di trasformarsi in uno scrittore satirico da un giorno all’altro.
Circa l’insinuazione del critico cui alludeva Macario, non staremo a precisare il nostro giudizio, davvero poco importante. Macario sa pure che un critico che, in pratica, ride, può dimostrare, in teoria, di non aver fiso e la cosa gli riesce tanto più facile quanto più si è divertito.
Ma a noi, che ci è permesso di affidarci persino alla prima impressione (che è poi quella del pubblico che paga) costerebbe troppa fatica dimostrare come e perché Macario non fa ridere, e perciò ci rinunciamo molto volentieri. L’innocenza di Macario è la base stessa del suo successo, sempre crescente. Quest’attore è per primo contento delle sue battute, spesso ride col pubblico sinceramente, o scherza con gli attori, in buon’armonia.
Appena arriva sulla scena l’aria di falso, di magazzino, quel luccichio che manda il palcoscenico sul quale si rappresenta una «rivista», viene assorbito dal suo candore. Si direbbe un attore novellino spinto da un collega che avesse voluto fargli un cattivo scherzo e che pian piano comincia a rinfrancarsi e a recitare. Il suo linguaggio è elementare, senza trovate da maschera, poco sicuro, ma traducibile. Non vi hanno posto le allusioni, le smorfie, né l’attore ha bisogno di un’intesa preventiva col «suo» pubblico.

Eccovi davanti un ragazzo in buona salute, con un principio di pancetta e gli occhi sinceri : non c’è bisogno di forzare l'immaginazione per cominciare a divertirsi ; basta il fatto che un tipo simile esista perché il buonumore vi conquisti.
Le prime attrattive dell’umorismo si provano a scuola, le prime volte che il maestro sbaglia la pronuncia di una parola qualsiasi. Macario si prende spesso l’incarico del maestro e sbaglia facendo fare ad una sala di scolaretti cresciuti le più care e ingenue risate. All’uscita non ci si ricorda perché si è riso e di Macario rimane soltanto l’immagine furba e timida di un ragazzone campagnolo col nastro della prima comunione alla manica della giubba.
Tra gli applausi di stima diretti all’attore, non poteva mancare una voce contrastante. «Più gusto, nelle riviste», doveva fatalmente esclamare un signore dall’aspetto severissimo. Sempre ci prende la malinconia quando sentiamo parlare di gusto poiché alle spalle di questa vediamo apparire le vere parole che si volevano dire : «moda, eleganza, distinzione». Specie se una invocazione simile si fa a proposito di un genere di spettacolo che intende soccorrere gli spettatori nelle ore topiche della digestione invece di metterli brutalmente a contatto con problemi impostati a ricerche severe o costringerli a seguire vicende logiche come ve ne sono spesso nelle commedie.
Ciò che il buon spettatore dovrebbe cercare nella «rivista», e non e a dire che non lo faccia, sono l’illogicità e l’incoerenza allo stato puro, la sorpresa senza complicazioni e una generale facilità di tono : ossia gli ottimi elementi di uno spettacolo visivo. Più una «rivista» è illogica, meno è lo sforzo richiesto a chi sta in poltrona a godersela e più lo scopo è raggiunto.
Poiché Carosello di donne obbedisce a questi requisiti, sin dal principio si entra nel mondo fiabesco soprannaturale (che dovrebbe essere appannaggio dell’arte e che invece ormai tutti dimenticano di esplorare per seguire i capricci della realtà).
Ecco seguirsi le visioni orientali, le leggere satire, gli intermezzi comici, su un filo da ragnatela, che offre al protagonista principale il mezzo di farci sapere ch’egli vuol fare del cinema.
Tempo e spazio aboliti, una battuta basta a giustificare il quadro seguente. Subito dopo una parodia dei «tre moschettieri», che si svolge alla corte di Luigi XIII con le signorine del coro vestite alla «Direttorio» ecco avanzare una meravigliosa schiera di severissime signore inguainate in neri merletti che canta gli insospettabili versi : «Femine siam, un veleno abbiam nel sen» offrendo un esempio di casalinga depravazione come soltanto se ne riscontra nei quadri di Franz von Stòck e nella prosa di Sem Benelli. (Bellissimo spettacolo, senza dubbio, ma si possono prendere sul serio tante Cleopatre in una sola volta ?).
Che cosa dire degli attori che fiancheggiano Macario e Vanda Osiri se non tutto il bene possibile?
Secondo il nostro parere l’attore delle «riviste» è il solo che ancora riserbi delle sorprese : compito, «distinto» e ben vestito, offre al pubblico le sue battute con la più precisa e impersonale delle pronunce, mantiene il suo volto costantemente inespressivo e perciò fa pensare che le sue parole nascondano meravigliosi significati.
* * *
All’appunto estetico dello spettatore, Macario ha soggiunto, sempre rivolgendosi al compare, e alludendo ai critici, che avevano ragione «loro» anche su questo punto. Confessiamo che non si poteva rispondere meglio, con più raffinata diplomazia e, soprattutto, con più gusto.
Ennio Flaiano, «Oggi», 17 febbraio 1940
 |
| Ennio Flaiano, «Oggi», 17 febbraio 1940 |